Leggere Buzzati è sempre un’esperienza leggermente perturbante. Non è mai chiaro, infatti, se, quando descrive qualcosa, intenda descrivere esattamente ciò di cui sta parlando o se in realtà voglia alludere a qualcos’altro. Anche quando parla di qualcosa che sembrerebbe essere solo ed esattamente ciò che appare, lascia sempre sottintendere che in verità abbia in mente altre cose, che ciò a cui allude sia una specie di simbolo, anche quando ha tutte le fattezze della semplice realtà.
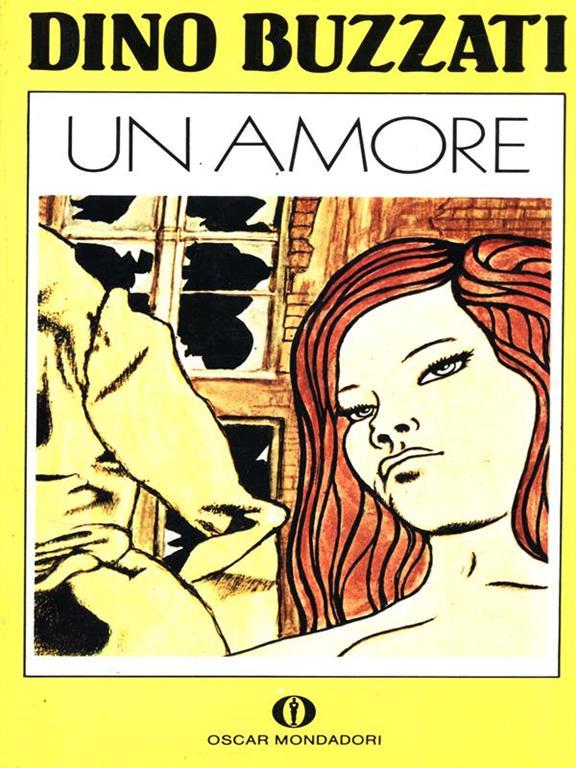
A questo effetto contribuisce in maniera determinante anche il suo stile, che è uno stile scabro, irregolare, audace, incline all’inesattezza, all’anomalia. Buzzati scrive rimanendo sempre in equilibrio tra la sgrammaticatura e il lirismo, tra l’errore e la finezza espressiva. È capace di elaborare frasi lunghissime, proposizioni senza neanche un verbo; nella sua prosa sono spesso presenti forestierismi, dialettismi, neologismi; la sua è una scrittura asciutta, coraggiosa, che non indulge al compiacimento di sé, quasi indifferente alle suggestioni letterarie. Ma poi, all’improvviso, è capace di inserire – nel bel mezzo di una descrizione che procede per accumulo, alla fine di un interminabile flusso di coscienza – una criptocitazione leopardiana ispirata ad alcuni dei versi più suggestivi e più lirici della letteratura italiana, quelli iniziali della Sera del dì di festa:
«porte che si schiudono senza scricchiolii, parole sommesse sul bordo del letto, quelle trasparenze sessuali, la vorticosa storia che la affascina, la risata, il braccio che cinge alla vita e lei si abbandona, lentamente oh sì, sì, lentamente mentre al di fuori, sul giardino, in completo silenzio, posa la luna.»
Siamo nel bel mezzo di Un amore, uno dei romanzi più belli e compiuti di Buzzati, in cui la predilezione dell’autore nei confronti della realtà predomina sulla sua inclinazione nei confronti del simbolo. In Buzzati, la realtà è spesso un espediente per arrivare al fantastico, al sovrannaturale, all’orrore anche. Dunque una specie di tramite, un espediente per attingere a una dimensione più importante e più pertinente nell’immaginario dell’autore, ovvero quanto concerne l’immateriale, l’invisibile, l’incorporeo. Ma in Un amore – tuttavia – la realtà è imperscrutabile, opaca, non lascia trasparire il senso delle cose, scorre parallela rispetto alla percezione degli eventi da parte del protagonista, e dunque si configura come un ostacolo piuttosto che un tramite, un impedimento che si frappone tra l’accadere e il sentire, e che risuona in modo sordo e indifferente rispetto alle aspettative dell’uomo.
Il romanzo narra l’amore di Tonino Dorigo – un uomo intelligente, di mezza età e di buona estrazione sociale – per la Laide, una ragazza molto più giovane di lui. La Laide è una prostituta, e Dorigo, a furia di frequentarla, finisce per innamorarsene. Dorigo può possederla ogni volta che vuole per sole ventimila lire, e per questo semplice fatto si fa l’idea che la ragazza debba affezionarsi a lui. In fondo, è un uomo istruito, pulito, benestante, il tipo d’uomo che può dare sicurezza a una ragazza giovane e inesperta come lei. E il fatto di avere delle frequentazioni carnali con lei gli fa credere che tra di loro debba necessariamente nascere e svilupparsi un sentimento di qualche natura. Ma Dorigo sembra dimenticare che la Laide va a letto con lui solamente per denaro.
Tra la realtà e la sua percezione si crea così un’asimmetria, uno sfasamento. Ed è in questa asimmetria che trova la sua giustificazione la criptocitazione leopardiana menzionata in precedenza. Se la realtà infatti è grigia e opaca, e non è possibile darne una lettura chiara (i sentimenti della Laide rimarranno sempre per Dorigo una lastra oscura e imperscrutabile), l’aspirazione dell’uomo (e con lui di Buzzati) è quella di osservare questa realtà in maniera poetica, come se fosse illuminata dalla luna che si affaccia in piena notte su un giardino.
Simili suggestioni sono capaci di aprire nella prosa di Buzzati scorci luminosissimi, che rendono conto di una ricerca complessa, mai banale, sempre attenta a cogliere tutto ciò che si colloca al di là dell’universo sensibile. Sono dettagli in apparenza trascurabili, dati di fatto ipotetici, dotati di una loro verità sfuggente, di una consistenza indecisa, particolari còlti come da un uscio della percezione, in maniera indiretta, obliqua: le «porte che si schiudono senza scricchiolii», le «parole sommesse sul bordo del letto», le «trasparenze sessuali». Attimi apparentemente destinati a non lasciare traccia, ma che in realtà si rivelano snodi cruciali, momenti talmente intimi da costituire lo zoccolo duro dell’esistenza, più degli eventi macroscopici che solo apparentemente danno forma alla vita.
Una mattina all’alba, Dorigo si sta recando a Modena per prendere la Laide e riportarla a Milano. E mentre viaggia su un’autostrada deserta, fiancheggiata da interminabili filari di pioppi ancora non illuminati dal sole, gli sembra di comprendere il senso di quella desolazione, di quella fuga all’indietro degli alberi, come se i pioppi volessero in qualche modo rivelargli un segreto, assumendo l’espressione intensa di qualcuno che sta per parlare:
«Di colpo egli capì ciò che dicevano, capì il significato del mondo visibile allorché esso ci fa restare stupefatti e diciamo «che bello» e qualcosa di grande entra nell’animo nostro. Tutta la vita era vissuto senza sospettarne la causa. Tante volte era rimasto in ammirazione dinanzi a un paesaggio, a un monumento, a una piazza, a uno scorcio di strada, a un giardino, a un interno di chiesa, a una rupe, a un viottolo, a un deserto. Solo adesso, finalmente, si rendeva conto del segreto.
Un segreto molto semplice: l’amore. Tutto ciò che ci affascina nel mondo inanimato, i boschi, le pianure, i fiumi, le montagne, i mari, le valli, le steppe, di più, di più, le città, i palazzi, le pietre, di più, il cielo, i tramonti, le tempeste, di più, la neve, di più, la notte, le stelle, il vento, tutte queste cose, di per sé vuote e indifferenti, si caricano di significato umano perché, senza che noi lo sospettiamo, contengono un presentimento d’amore.»
Il significato del mondo visibile, quando ci incanta con la sua bellezza, quando sembra volerci rivelare il segreto stesso dell’esistenza, non è nient’altro che l’amore. Se il bello esiste, se l’universo assume conformazioni seducenti, se qualcosa di grande entra d’improvviso nel nostro animo per amplificarne la sensibilità e l’intelligenza, ciò avviene affinché ne possiamo condividere il fascino con la persona amata. L’universo ci invita all’amore facendo la ruota come un pavone, ci corteggia in mille modi diversi per assumere un significato a fronte dell’insensatezza che a volte ci sembra di scorgere nella vita, per caricarsi di senso quando abbiamo maggiormente bisogno di esso, ovvero quando siamo innamorati. L’amore è quel grumo denso di significato che ricerca un valore in ogni cosa, ansioso di essere condiviso con la persona amata.
Non può essere in altro modo che così. La bellezza non ha senso se non può essere partecipata: «Quanto meschina sarebbe, di fronte a un grande spettacolo della natura, la nostra esaltazione spirituale se riguardasse soltanto noi e non potesse espandersi verso un’altra creatura». La bellezza è altruista, liberale, generosa. Vuole essere comunicata agli altri, anzi, vuole essere goduta insieme alla persona amata. Ma, in cambio, pretende reciprocità, esige che il sentimento da lei ispirato susciti nell’amata una corrispondenza, un conseguente desiderio di condivisione.
E invece, quella mattina, lo spettacolo della natura non suggerisce a Dorigo solamente immagini di bellezza. Lo mette anche in guardia, lo avvisa che se lui è desideroso di condividere con qualcuno la felicità di quello spettacolo, al termine della strada non c’è nessuno che lo aspetti con il medesimo desiderio. «Fermati, uomo», sembrano dirgli i pioppi con la loro fuga all’indietro lungo l’autostrada deserta, «fa’ dietro front, non pensare più a lei e seguici, non correre alla tua rovina. Noi ti condurremo al remoto paradiso degli alberi dove esiste soltanto benessere, canto di uccelli e pace dell’animo. Non ostinarti».
I pioppi, in altre parole, ricordano a Dorigo l’asimmetria della sua esperienza. Lui ha il cuore tutto pieno della Laide, crede che i momenti d’amore vissuti insieme a lei derivino da un sentimento d’amore ricambiato, ma non è così. La Laide gli restituisce i baci e le carezze solamente per denaro. Se forse, di tanto in tanto, arriva a provare un po’ di tenerezza per quest’uomo tanto più vecchio e tanto diverso da lei, si tratta di sporadici momenti di debolezza. Dorigo è consapevole di questa verità, e tuttavia non rinuncia mai all’illusione, rifiuta di credere alla realtà che pure percepisce nel suo cuore.
E ancora una volta, Buzzati rende conto di quest’asimmetria principalmente da un punto di vista stilistico, con una lingua sghemba, sovrabbondante, eccessiva, forzando la sintassi fino al limite più spinto della norma, giocando con l’errore, sfidando l’ortografia (scrive «valige», scrive «guancie»), simulando il refuso. Ci sono frasi in cui l’autore cambia il tempo verbale nello stesso periodo, dal futuro al passato, dall’imperfetto al presente, provocando nel lettore un senso di straniamento improvviso, costringendolo a rileggere, a mettere in discussione il patto stabilito con l’autore: io ti seguirò per le volute della tua narrazione, ma tu ti impegnerai a creare un universo coerente, con delle pareti solide, realistiche e verificabili.
Ebbene, Buzzati si diverte a tradire questo patto, a mettere il lettore in difficoltà. Lo sfasamento dei tempi verbali nello stesso periodo è un caso emblematico. Si veda per esempio: «fra poco la notte impallidirà e un respiro di aria fresca cominciò a entrare nella stanza»; o ancora: «Le vedeva con gli altri, a braccio degli altri, al tavolo degli altri, in automobile con gli altri e se lui le fissava, infastidite voltano la testa dall’altra parte sempre così».
La sgrammaticatura di Buzzati è diversa rispetto a quella – mettiamo – di uno Svevo (del quale Senilità ha più di un aspetto in comune con Un amore). Svevo è più regolare nella sua difformità. Anche nelle anomalie sintattiche e grammaticali, rivela una padronanza assoluta della frase, la governa tutta dall’inizio alla fine, e quando sbaglia, sbaglia con eleganza, in modo consapevole, dà sempre l’impressione di sapere il fatto suo. Buzzati, invece, a volte sembra perdersi nei suoi flussi di coscienza, mentre tenta di rendere conto di una realtà magmatica, di dipanare fili inestricabili, e per farlo produce un amalgama linguistico tortuoso, ingarbugliato, almeno quanto la realtà che rappresenta. E talvolta il lettore fatica a stargli dietro.
Ciò non capita tuttavia quando descrive la Milano vecchia, che proprio di questa inestricabilità diviene un simbolo, con i suoi vicoli impervi e le vecchie case ravvicinate. In tutto il romanzo abbondano le descrizioni di questi scorci milanesi, e sono visioni indimenticabili, perforazioni vertiginose, prospettive che bucano la realtà che rappresentano per puntare dritto al cuore delle cose:
«Esisteva in corso Garibaldi, a Milano, un gruppo di vecchissime case addossate le une alle altre in un groviglio di muri, di balconi, di tetti, di comignoli. Dove lo spirito della città antica, non quella dei signori ma quella dei poveri, sopravviveva con una singolare potenza. Pezzo a pezzo, la vecchia Milano era stata distrutta. […] In corso Garibaldi però durava ancora ostinata, pur sbrecciata ai margini dal piccone, un’isola ancora intatta. E fra il numero 72 e il 74 c’era un passaggio sormontato da un arco, una specie di porta che immetteva in uno stretto e breve vicolo. C’era anzi una targa in pietra su cui era scritto: Vicolo del Fossetto.
È così angusto l’ingresso della minuscola strada che la maggioranza dei passanti non se n’accorge nemmeno. Ma dopo otto nove metri, il vicolo si allarga in una specie di piazzetta contornata da edifici decrepiti. È un angolo dimenticato, un labirinto di viuzze, anditi, sottopassaggi, piazzuole, scale e scalette dove si annida ancora una densa vita. Lo chiamano, chissà perché, la Storta.»
Nelle descrizioni di Milano vecchia, Buzzati riprende magistralmente il controllo della narrazione. Le frasi si addossano le une alle altre come le vecchie case della città. La rappresentazione si confonde con ciò che viene rappresentato, il simbolo con ciò che viene simboleggiato, il significante con il significato. Sono descrizioni indimenticabili, perché rendono conto perfettamente della confusione, della difficoltà a riconoscere i singoli elementi di cui il tutto si compone (il «groviglio di muri, di balconi, di tetti, di comignoli», il «labirinto di viuzze, anditi, sottopassaggi, piazzuole, scale e scalette»), e la densità della vita che vi brulica emerge con esattezza e prepotenza.
È qui che Buzzati dimostra il proprio nerbo di scrittore di razza, quando prova a confrontarsi con quella bellezza nascosta delle cose che, mentre ci incanta, ci invita all’amore, perché è vero, la realtà non è mai soltanto quello che è, ma ha sempre un significato più profondo. Ed è un significato che passa per l’incanto delle parole, per la costruzione delle frasi, e che assume un valore speciale per l’asimmetria nella quale è incastonato, per il disordine così prezioso che lo incornicia e ce lo getta incontro.
Luca Alvino è nato a Roma nel 1970. Ha pubblicato Il dettaglio e l’infinito. Roth, Yehoshua e Salter (Castelvecchi, 2018) e Il poema della leggerezza. Gnoseologia della metamorfosi nell’Alcyone di Gabriele d'Annunzio (Bulzoni, 1998). Si interessa di letteratura contemporanea e di poesia. Collabora con il blog minima&moralia.

