NY 6 Marzo 2004 ore 14.30
Che delizia – dopo che il vento di Manhattan ha provato a scalfirti i connotati – trovare rifugio alla Carnagie Delicatessen, uno dei quei locali sulla Settima Avenue equidistanti tra Times Square e Central Park, che si contendono il primato della miglior Cheese Cake di New York!
Addentrandomi in questa Deli le cui pareti sono consacrate al divismo di mille autografate fotografie di celebrità americane, mi lascio elettrizzare dalla scortesia dei camerieri pakistani che, senza neppure salutarmi, mi hanno messo sotto gli occhiali un menù plastificato e una ciotola piena di turgidi panciuti cetrioli giallo-verdi. Sono entusiasta – con lo spirito d’uno snob fin-de-siècle che trova assai “pittoresca” ogni bettola – dell’ambiente spartano e dell’odore inconfondibile di cucina intrugliata.
 Finché trovandomi faccia a faccia con questo sandwich al pastrami così ridicolmente rablaisiano (esisterà uno stomaco capace di contenerlo tutto?), capisco che la vera differenza tra l’America e l’Europa – la differenza su cui tanto oggi si favoleggia – è tutta nella diversa quantità di cibo servita nei ristoranti. Quel che mangia un americano basterebbe a sfamare un paio di europei e almeno una dozzina di cinesi.
Finché trovandomi faccia a faccia con questo sandwich al pastrami così ridicolmente rablaisiano (esisterà uno stomaco capace di contenerlo tutto?), capisco che la vera differenza tra l’America e l’Europa – la differenza su cui tanto oggi si favoleggia – è tutta nella diversa quantità di cibo servita nei ristoranti. Quel che mangia un americano basterebbe a sfamare un paio di europei e almeno una dozzina di cinesi.
Eppoi il miracolo.
Un miracolo che immobilizza il gigantesco panino nelle mie mani a pochi centimetri dalla bocca. Alla cassa del bistrot, con aria accigliata, mentre conta una bella mazzetta di dollari, c’è niente meno che Saul Bellow. Possibile? Non ho dubbi. È lui. Buon Dio, il feticismo letterario servirà pure a qualcosa! Ecco, la mia Bellow-mania – che nel tempo mi ha portato a scaricare da internet centinaia di foto di quel ciclope della letteratura mondiale con annesso il catalogo di mogli, figli, fratelli, amici, editori, agenti, affini… – mi assicura che non sto sbagliando: il signore alla cassa non è altri che lo scrittore da me per anni inseguito con la dedizione d’una teen-ager idolatra o d’un cavaliere medievale.
Come potrei sbagliarmi?
Ma non è questo il miracolo. Nient’affatto. Sì, insomma, il miracolo non è che un premio Nobel per la letteratura ultraottantenne abbia rilevato una Deli sulla Settima, e che ora lo gestisca con successo. La cosa realmente sconvolgente è che questo Saul Bellow non dimostri più di cinquant’anni. Non si tratta di un Bellow a me contemporaneo, ma d’un Bellow degli anni ’60. Mica il Bellow che – a sentire un’amica cattedratica che lo conosce personalmente – se la passa male, poveretto, ma un Bellow all’apice del suo splendore: capelli ondulati, labbra carnose, occhi voluttuosi alla Gary Cooper: colui che veniva dal trionfo di Herzog, quel libro che tutti acquistavano e nessuno leggeva: l’adone ricco, elegante, celebrato, spiritoso, irresistibile che oggi non dovrebbe più esistere.
Mi avvicino. Lo guardo meglio, senza farmene accorgere, tentando di dissimulare il turbamento e di ricacciare nel fondo di me stesso il desiderio di abbracciarlo e di inginocchiarmi.
Finché, come purtroppo troppo spesso avviene, vengo trafitto dal dio minore della razionalità che mi sussurra una verità così banale (che fa rima con “brutale”!) che mi viene da piangere: costui è un sosia, un impostore. Sì, alla cassa non c’è mica Bellow, ma una delle sue tante parodie disseminate sul territorio americano: un perturbante apocrifo in carne e ossa. È come trovarsi di fronte a un falso Picasso dopo averlo acquistato fantasticando su insperate ricchezze. Che delusione!
Costui non è altri che il signore del Pastrami. Ecco tutto. Uno che con questa Deli deve aver fatto un mucchio di quattrini. Non accetta carte di credito. Solo cash: verdi, fruscianti, odorose banconote come in un libro di Mark Twain!
Lui, forse, anzi certamente, è nato in America. Ma sento che suo padre è giunto qui, dopo aver traversato l’Europa. Sento l’eco malinconica di violini, le urla di cosacchi ubriachi, il miasma abbrustolito dei pogrom. Sento la Russia zarista scorrere nelle sue vene.
Il signore del pastrami è uno dei tanti confratelli di Bellow di origine russa che l’America ha avuto la bontà di accogliere e di nutrire doviziosamente.
Dicevo, la Russia.
Di recente Antonio D’Orrico (un po’ il padre spirituale di noialtri Bellow-maniaci) sottolineava una coincidenza: la letteratura americana, nel dopoguerra almeno, è stata influenzata in modo determinante da due scrittori di origine russa che avevano il vezzo di detestarsi vicendevolmente. Sì, mentre l’America di Eisenhower e di McCarthy processava un mucchio di intellettuali accusandoli di simpatie sovietiche, due scrittori come Vladimir Nabokov e Saul Bellow – da tribune  così diverse ma così intrinsecamente legate – imprimevano una svolta decisiva alla letteratura nordamericana di cui a tutt’oggi è impossibile valutare gli effetti: non c’è libro partorito da giovane scrittore contemporaneo che non paghi pegno a quei due giganti e alla loro madre patria: la Russia.
così diverse ma così intrinsecamente legate – imprimevano una svolta decisiva alla letteratura nordamericana di cui a tutt’oggi è impossibile valutare gli effetti: non c’è libro partorito da giovane scrittore contemporaneo che non paghi pegno a quei due giganti e alla loro madre patria: la Russia.
Di questi tempi la Russia è di moda negli Stati Uniti. Mi vengono in mente almeno tre titoli recenti di altrettanti romanzieri dedicati alla Russia: Ogni cosa è illuminata di Jonathan Safran Foer, Il manuale del debuttante russo di Gary Shteyngart, Il compagno Astapov di Ken Kalfus.
D’altra parte non si può dire che la Russia sia una passione recente in America. Lo stesso Bellow ne Il dono di Humboldt ricorda la New York degli anni ‘30 come una specie di succursale di Mosca: “A quell’epoca New York era molto russa, la Russia era in gran voga. Si dava il caso – per dirla con Lionel Abel – di una città che agognava d’appartenere a un altro Paese. New York sognava di abbandonare il Nord America e fondersi con la Russia Sovietica”.
 Insomma, i due (Bellow e Nabokov) si detestavano senza alcuna cordialità. In un modo franco, che non lascia spazio ad equivoci, Nabokov scriveva a un editore: “Saul Bellow, penosa mediocrità, non sarebbe mai dovuto apparire su una copertina che parla di me”. E certo Bellow non andava per il sottile quando, alludendo a Lolita, armato della sua proverbiale ironia schiacciasassi, scriveva: “Mettiamo pure che non sia una cosa troppo orribile che uomini di mezza età copulino con le bambine, ma bisogna proprio che ne facciano filosofia? Io sarei capace di scrivere un libro migliore dal punto di vista di Lolita”.
Insomma, i due (Bellow e Nabokov) si detestavano senza alcuna cordialità. In un modo franco, che non lascia spazio ad equivoci, Nabokov scriveva a un editore: “Saul Bellow, penosa mediocrità, non sarebbe mai dovuto apparire su una copertina che parla di me”. E certo Bellow non andava per il sottile quando, alludendo a Lolita, armato della sua proverbiale ironia schiacciasassi, scriveva: “Mettiamo pure che non sia una cosa troppo orribile che uomini di mezza età copulino con le bambine, ma bisogna proprio che ne facciano filosofia? Io sarei capace di scrivere un libro migliore dal punto di vista di Lolita”.
La cosa realmente affascinante di questi giudizi è quanto essi siano ottusi e meschini. Come se entrambi gli scrittori fossero endemicamente non attrezzati a comprendersi, incapaci di riconoscere la grandezza dell’altro. O fossero allergici a qualsiasi forma di autentica acribia critica. Anche il più intellettualmente depresso tra i lettori di Lolita saprebbe capirne la grandezza, ma Bellow ne sembra incapace. Tale gioia (la gioia di amare incommensurabilmente Lolita, “senza se e senza ma” si direbbe oggi) gli è preclusa!
Trovo davvero sorprendente la risentita e umorale grossolanità delle argomentazioni con cui l’uno demolisce l’altro.
Come spiegarla?
Martin Amis, che idoleggia Bellow e Nabokov in modo infantile, ha provato a spiegare tale reciproca antipatia in modo non molto persuasivo. Sostenendo che i due si conoscevano poco. Tesi debole e un po’ troppo indulgente e che soprattutto fingendo di risolvere un problema ne pone un altro non meno angoscioso.
Perché due lettori così avidi e raffinati non trovarono il tempo e la voglia di leggere Lolita e Herzog? Cioè i due più importanti romanzi americani usciti in quel ventennio?
Raffaele Manica ha provato a fornirmi una spiegazione assai più interessante. Facendomi notare, anzitutto, come ricorrano, nella storia della letteratura, antipatie e incomprensioni tra scrittori illustri (il caso Joyce-Proust è emblematico), eppoi spiegandomi come sia insito nella natura d’un eminente scrittore, completamente immerso nel proprio universo, il difetto di non poter capire e amare altro che se stesso. Sì, insomma è come se l’universo d’un eminente scrittore si presentasse come un’aggressiva convessità refrattaria a piegarsi alla spavalderia d’una convessità diversa se non addirittura contraria. E, in effetti, si stenta a immaginare due universi più inconciliabili di quelli di Nabokov e Bellow.
O chissà che non funzioni una tesi biecamente classista? Chissà che non si possa dire che le differenze sociali che non avrebbero consentito ai nobili avi di Nabokov di frequentare o perfino di stringere la mano agli antenati ebrei di Bellow nella Russia zarista, spieghi semplicemente tutto? In fondo (e non solo in letteratura) le diversità di classe sociale sono sempre un’ottima spiegazione.
Che distanza tra l’aristocratico snob, stilista nevrotico, con la sua infanzia fiabesca, l’inglese impeccabilmente ingessato e le geometrie sintattiche, e quel campione di pungenti ironie ebraiche, attratto dalle donne, dai gangster, dalle idee profonde e dai massimi sistemi: dalla vita insomma nel suo svolgimento (lo stile di Nabokov, invece, ha il potere flaubertiano di irrigidire la realtà fino a cristallizzarla).
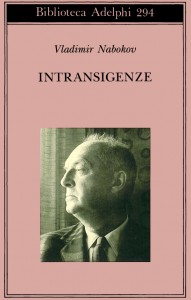 Nelle lezioni e nelle interviste – quest’ultime oggi contenute nel volume Intransigenze (scrigno pieno di idee caustiche e fenomenali) – Nabokov non fa che prendere le distanze da qualsiasi tentativo letterario di cosmologia. A un certo punto, con uno dei suoi tipici giochi di parole, arriva a dire che, per lui, la sola differenza ravvisabile tra “comico” e “cosmico” è la lettera “s”. Chiara l’allusione demistificante e nichilista: la letteratura, per Nabokov, è esercizio stilistico sofisticato. Rebus enigmistico. E nient’altro. E forse questo è il suo limite più vistoso. Nella sua prosa non c’è mai alcun cedimento. È come se lui usasse il diaframma dello stile per tenere a bada la realtà. Come se la sua proverbiale misantropia fosse salvaguardata dalla scrittura così ingemmata. Cioè l’esatto contrario di Bellow: che si tuffa nel mondo con curiosità balzacchiana, e che non si tira mai indietro quando si tratta di interpretarla attraverso le grandi linee del pensiero moderno. Bellow è attratto dalla volgarità delle idee generali, Nabokov ne ha orrore. Bellow non ha alcuna vergogna di prendere di petto le tragedie che hanno coinvolto il popolo ebraico nel Ventesimo Secolo e per farlo non ha paura di ricorrere a tutti i registri, anche quelli più apparentemente magniloquenti, perfino i più lacrimevoli. Nabokov della grande tragedia della sua famiglia non parla mai, se non in modo raffinatamente implicito. Bellow è un sentimentale platonico, Nabokov un aristotelico crudele. È necessario leggere l’epistolario tra Nabokov e Edmund Wilson per intuire la tristezza e la rabbia di un aristocratico cacciato dall’eden. Ma a parte le sue confessioni epistolari, nella sua opera, è come se Nabokov avesse scelto di indossare il cilicio della discrezione: come uno di quei bambini umiliati e orgogliosi che giurano su Dio che non piangeranno mai, e pur di non farlo si rifugiano in un’ironia piena di amarezza. Ricorrendo a una generalizzazione potremmo dire che mentre Nabokov scrivendo non fa che parlare della propria scrittura perché il resto non conta, anzi: non esiste, Bellow, muove proprio da quel resto inviso a Nabokov. Quindi se Nabokov si lascia incantare dal lessico, dalla sintassi, dalla retorica, Bellow è drogato di vita.
Nelle lezioni e nelle interviste – quest’ultime oggi contenute nel volume Intransigenze (scrigno pieno di idee caustiche e fenomenali) – Nabokov non fa che prendere le distanze da qualsiasi tentativo letterario di cosmologia. A un certo punto, con uno dei suoi tipici giochi di parole, arriva a dire che, per lui, la sola differenza ravvisabile tra “comico” e “cosmico” è la lettera “s”. Chiara l’allusione demistificante e nichilista: la letteratura, per Nabokov, è esercizio stilistico sofisticato. Rebus enigmistico. E nient’altro. E forse questo è il suo limite più vistoso. Nella sua prosa non c’è mai alcun cedimento. È come se lui usasse il diaframma dello stile per tenere a bada la realtà. Come se la sua proverbiale misantropia fosse salvaguardata dalla scrittura così ingemmata. Cioè l’esatto contrario di Bellow: che si tuffa nel mondo con curiosità balzacchiana, e che non si tira mai indietro quando si tratta di interpretarla attraverso le grandi linee del pensiero moderno. Bellow è attratto dalla volgarità delle idee generali, Nabokov ne ha orrore. Bellow non ha alcuna vergogna di prendere di petto le tragedie che hanno coinvolto il popolo ebraico nel Ventesimo Secolo e per farlo non ha paura di ricorrere a tutti i registri, anche quelli più apparentemente magniloquenti, perfino i più lacrimevoli. Nabokov della grande tragedia della sua famiglia non parla mai, se non in modo raffinatamente implicito. Bellow è un sentimentale platonico, Nabokov un aristotelico crudele. È necessario leggere l’epistolario tra Nabokov e Edmund Wilson per intuire la tristezza e la rabbia di un aristocratico cacciato dall’eden. Ma a parte le sue confessioni epistolari, nella sua opera, è come se Nabokov avesse scelto di indossare il cilicio della discrezione: come uno di quei bambini umiliati e orgogliosi che giurano su Dio che non piangeranno mai, e pur di non farlo si rifugiano in un’ironia piena di amarezza. Ricorrendo a una generalizzazione potremmo dire che mentre Nabokov scrivendo non fa che parlare della propria scrittura perché il resto non conta, anzi: non esiste, Bellow, muove proprio da quel resto inviso a Nabokov. Quindi se Nabokov si lascia incantare dal lessico, dalla sintassi, dalla retorica, Bellow è drogato di vita.
Insomma come avrebbero potuto amarsi?
Eppure resta il fatto che, pur detestandosi, abbiano cambiato il volto della letteratura americana, e che lo abbiano fatto attingendo e interpretando la propria matrice europea in una chiave completamente nuova.
E come spesso avviene in letteratura, il cambiamento passa attraverso la comparsa nel mondo di due personaggi. Sui quali sarebbe perfino inutile soffermarsi se essi non nascondessero segrete corrispondenze che avrebbero fatto infuriare i rispettivi creatori ma che non smettono di eccitare la mia fantasia.
Sto parlando di Humbert e di Herzog naturalmente.
È elettrizzante pensarli contemporanei. Mentre il primo è lì a patire per la sua Dolores Haze alias Lolita, l’altro è ancora sposato con la nevroticissima Madeleine ignaro dei tradimenti di costei con il suo migliore amico, il bislacco cialtrone di nome Gerbach. Per quanto possa apparire strano, Humbert e Herzog vivono e soffrono nella stessa America, nel medesimo giro di anni. Talvolta si trovano anche l’uno a pochi chilometri dall’altro. Anche se possiamo ipotizzare che se si incontrassero avrebbero poco da dirsi, e anzi proverebbero una reciproca ripugnanza. È plausibile che Humbert rimarrebbe disturbato da quel modo un po’ sciatto di vivere di Herzog, dalla sua esibita svagatezza, così come quest’ultimo resterebbe infastidito dallo snobismo di Humbert e dalle sue perversità sessuali (ricordo che Herzog è padre d’una bimba piccola e che ha un forte senso della paternità).
Assai più utile rilevare le palesi affinità tra Humbert e Herzog, quelle inequivocabili, intendo: anzitutto notando come si tratti di intellettuali dalla forte impronta europea, e allo stesso tempo di due disadattati (anche se per ragioni diverse) che guardano al grande paese in cui vivono con un misto di curiosità, incredulità e paura.
Si narra che quando a metà degli anni Trenta buona parte dell’Intellighenzia europea si trasferì a Hollywood, non  fosse così difficile trovare a un garden-party in casa Gershwin, ai bordi della piscina, una fauna di individui con il cappotto inforcato. Quegli abiti ridicolmente incongrui rispetto al clima testimoniavano la difficoltà di quegli uomini di adattarsi a un mondo così diverso da quello in cui erano cresciuti.
fosse così difficile trovare a un garden-party in casa Gershwin, ai bordi della piscina, una fauna di individui con il cappotto inforcato. Quegli abiti ridicolmente incongrui rispetto al clima testimoniavano la difficoltà di quegli uomini di adattarsi a un mondo così diverso da quello in cui erano cresciuti.
Ebbene diciamo che Humbert e Herzog, in modo meno spettacolare forse, sembrano due stranieri che non riescono a smettere il cappotto neppure nel pieno d’un’estate californiana. È come se guardassero alla realtà americana, alla società affluente, con le lenti offuscate del mito: mitologie d’un altro continente e d’un altro secolo. Come se entrambi fossero una nuova versione di Don Chisciotte, più consapevoli di quest’ultimo della propria follia ma non per questo meno donchisciotteschi (L’incipit di Herzog è emblematico: “Se sono matto per me va benissimo”).
Follia appunto, che si presenta sotto le spoglie fascinose e un po’ ridicole d’una letterarietà integrale.
Sia Humbert sia Herzog non fanno che offrire una peculiare versione della follia universale tramite la propria specifica pedanteria letteraria: il primo trasfigurando – come solo un serial killer ben avviato saprebbe fare – una bimbetta volgare in una ninfa dell’antichità promessa di piaceri metafisici, il secondo inviando lettere improbabilmente colte a uomini e donne della sua vita, a colleghi cattedratici, a politici influenti, ma anche a grandi personaggi storici ormai deceduti.
Forse sembrerà un po’ troppo semplicistico, ma sembra proprio che la follia di entrambi funzioni da schermo. È come se essi mettessero questo opaco diaframma tra la propria coscienza e il mondo americano. E per la solita ragione: per non soffrire troppo.
Naturalmente in tale contesto, trovandomi ancora faccia a faccia con l’uomo del Pastrami, il quale si stupisce che io abbia tirato fuori il computer ma soprattutto che io abbia iniziato a scrivere lasciando raffreddare il sandwich… Dicevo, in tale contesto, sono costretto ad abbandonare Humbert per dedicarmi totalmente a Herzog. Lui, Moses Herzog, almeno per il momento, è il nostro uomo.
Si può dire che sia nato pazzo?
Direi di no. Moses lo è diventato in seguito a un trauma abbastanza comune. La moglie bellissima – corredata di quelle idiosincrasie nevrotiche che trasformano molte donne belle in autentici Draghi Medievali – lo ha prima tradito poi piantato per il miglior amico di Herzog: l’ampolloso Gerbach che ha non pochi debiti nei confronti di Moses. Sicché i due amanti sono andati a vivere da soli, strappando una figlia al padre legittimo più per dispetto nei confronti di Moses che per amore della piccola, e ora non fanno che litigare. In ogni modo Moses ha reagito veramente male a questo trauma: l’odio omicida per la moglie e l’ex amico gli hanno messo a dura prova il senno. E ora lui, in preda a questa follia lucidissima non fa che girare l’America: dalla casa in campagna alla vecchia cara Chicago, per tornare repentinamente a New York. Non riesce a stare fermo. Herzog è un libro di viaggio senza meta (proprio come Lolita in fondo), ma non quel viaggio avventuroso glorificato dalla beat generation. Herzog (proprio come Humbert) è un fuggiasco. Uno strano fuggiasco, perché non inseguito da nessuno. E tuttavia un fuggiasco.
Ebbene il viaggio inutile di Moses è scandito dalle sue lettere, che sono espressione del modo malato e allo stesso tempo affascinante di ragionare, o per meglio dire, di rimuginare. Moses è uno che ha un desiderio patologico di esprimersi e di mettere il punto. E tuttavia sembra non riuscirci mai. Perché i pensieri alla fine gli sfuggono. Per lui l’atto di pensare somiglia a una caccia alla volpe, in cui la volpe è più veloce dei cani e dei cavalli. Non solo, ma perseguendo nella metafora, è come se un certo punto le volpi si decuplicassero aprendo un ventaglio di altri sentieri impossibili da seguire. Proprio perché qualsiasi pensiero di Moses si trasforma in occasione per nuove divagazioni. Anche i suoi ragionamenti sono un viaggio senza meta.
Il segreto dello stile di questo romanzo straordinario è tutto in una stratagemma di Bellow: è come se lui avesse accelerato la realtà. Il mondo è eccitato e veloce come la mente di Moses. I suoi occhi ci consegnano un universo impazzito che corre, in cui ogni impressione, anche la più sofisticata, attraversa la mente del personaggio in un modo vorticoso per subito scomparire ed essere sostituita. Ma non alla maniera joyciana. Non è il meccanismo della coscienza che interessa a Bellow. Diciamo che lui si contenta di dar conto, attraverso la sovreccitazione intellettuale di Moses, dell’assurda progressiva velocità del mondo contemporaneo. I suoi vasi sanguigni sono come ingolfati di adrenalina e di serotonina! Moses è uno dei tanti americani viziati dalla smania di coprire distanze. E la cosa singolare è che lui non è un manager, né un agente di commercio, né un pilota di Jet. Herzog è un intellettuale, e pure uno tra i più raffinati che abbia mai solcato le scene del romanzo americano. Eppure anche lui che dovrebbe trovare requie nella lentezza della concentrazione, e in una sorta di stoica rilassatezza, si lascia sedurre dall’incessante eracliteo scorrere della vita americana. Non a caso il suo genere è la lettera, non il racconto, non il romanzo, non il saggio. La lettera: veloce, diretta, sbrigativa, breve… Per intendersi, se Moses nascesse oggi probabilmente sarebbe un maniaco delle mail e delle chat.
(Il testo è originariamente apparso in due puntate sui numeri 27, luglio-settembre 2004, e 28, ottobre-dicembre 2004, della quinta serie di Nuovi Argomenti)
Carlo Carabba è nato a Roma nel 1980. Ha pubblicato le raccolte di poesia Gli anni della pioggia (peQuod, 2008 – Premio Mondello per l'Opera Prima), Canti dell'abbandono (Mondadori 2011 – Premio Carducci e Premio Palmi) e il memoir Come un giovane uomo (Marsilio 2018 – selezionato al Premio Strega). Lavora nell'editoria.
