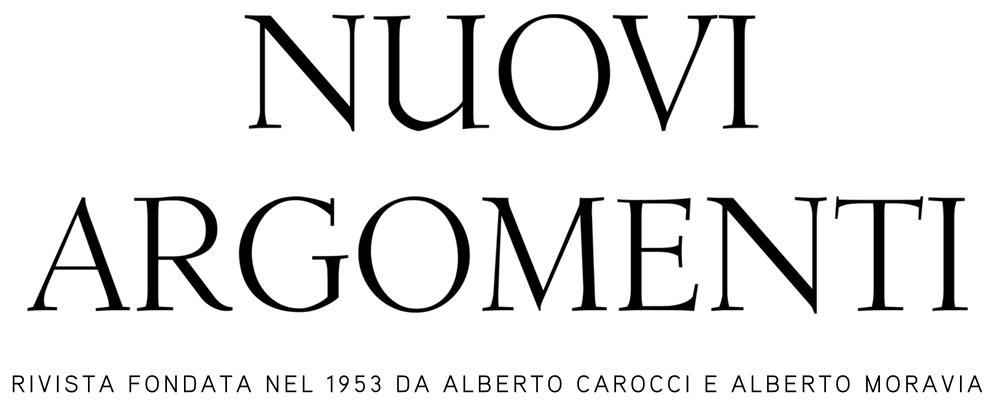Sabato 24 maggio, ore 9
È un’ora assente. Mi guardi. Si vive ancora, sì, si vive ancora.
Ma non c’è la mano da darti. Guardi gli occhi della malinconia.[1]
È primavera inoltrata e l’aria comincia a essere più calda, anche in provincia, alle porte di Milano: sul tavolo Tersa morte (2013), l’ultimo libro di Mario Benedetti, per l’incontro che domani terrà a Treviglio. Al termine del volume si arriva con un percorso che sembra piano, per quanto i versi sono cesellati, ma che invece è un attraversamento estenuante: gli intenti sono dichiarati già dal titolo e così la volontà di rendere chiaro il più ossessivo e tremendo dei processi umani.
«La mia via per uscire dalla falsificazione della vita banalizzata
passa attraverso l’osservazione concreta, quasi scientifica, della mortalità».[2]
Dall’ultima pagina risalgo alle prime. È un verso a definire la cifra scelta da Benedetti: “Le parole sono nelle storie che mi hai fatto vedere”[3]. L’autore abdica al ruolo di deus ex machina, di rivelatore, per immergere le mani nel reale, potenziando la parola attraverso la coscienza della sua caducità: “Morire e non c’è nulla, vivere e non c’è nulla, mi toglie le parole”[4], dice Benedetti in una ineludibile esplorazione del male. La morte è in ogni pagina, assedia il lettore, dopo aver attorniato il poeta. Tersa morte è una scoperta di territori-limite in cui le cose si fanno mute, senza catarsi, trascendenza o sollievo: resta l’autore solo, o meglio il suo sosia, che osserva quel che la vita ha deciso; restano le assenze dei corpi e dei paesaggi, che non sono più. Attraverso questo percorso, la perdita diventa realtà condivisa, “una storia per tutti”[5], mentre nel libro si manifesta un paradigma letterario nuovo, in cui l’esperienza sopravanza ogni possibilità di stile.
Recupero attenzione, qualche nota scritta a mano su un foglio che ora è colmo di scarabocchi: la mattina ha lasciato posto a un caldo umido, c’è ancora molto da leggere.
Sabato 24 maggio, ore 15
Ma nessuno è qualcuno, niente la notte, nessun mattino.[6]
Si prova a ripercorrere l’opera di un autore a ritroso, cercando risposte, collegamenti e significati partendo dal delta finale, per risalire alle sorgenti. Pitture nere su carta (2009) non sembra rispondere al ruolo di libro-di-mezzo che mi piacerebbe affidargli in questa indagine. Semmai è una scheggia impazzita nella storia letteraria di Mario Benedetti.
«È partito tutto da un quadro: mi ha aperto un mondo e in poche settimane
ho scritto continuamente, quasi di getto, tutto il libro. Un libro difficile, da matti».[7]
Ci si immerge nelle prime pagine delle Pitture nere e subito si capisce che servirà dragare il fiume, piuttosto che guadarlo. Innanzitutto, la sequenza: capitolare, ripetitiva (8 sezioni con – rispettivamente – 11, 11, 10, 10, 9, 9, 9 e 9 poesie), è l’elogio del frammento sincopato che dice il dolore della morte (ancora, sì, ma stavolta in modo icastico e ornamentale), che si affaccia come un grido esile senza calore. Quella che si affronta è scrittura per guizzi, nervosa, saltellante. Ci sono colori e sfarzo, come dicono i titoli di due sezioni, ma sono quelli degli ornamenti funebri; attorno ci sono soprattutto lacrime e reliquiari, come ci ricordano i titoli di altri due gruppi di testi. I paesaggi, che in Tersa morte sfuocano sullo sfondo, qui si svuotano fino ad acquisire le sembianze di reperti, proprio come chi li abita, salme che assumono il significato delle proprie tombe, degli stucchi e degli arredi. Lo sguardo del poeta si muove all’interno di questi confini, le parole rimandano alle basilari percezioni corporee, le uniche in grado di vagliare la materia. Le dimensioni fisiche[8] richiamate nel testo sono l’orizzonte, il dolore che dobbiamo fare nostro. Gli slanci emotivi si azzerano, si asciugano; l’infanzia è seccata e il reale diventa qui un nulla espanso, onnipresente: “Dietro di te, e davanti, oltre, non c’è niente”[9]. Benedetti prova a tratteggiare le sembianze di questo niente, dell’ esterno dell’esterno[10] in cui (sopra)vivere, lasciando gli spettatori-lettori in bilico: come avviene nei suoi bozzetti messi su carta dal bordo di un abisso. Del linguaggio e del sentire.
La luce si dissolve in garze rosse-azzurre-blu che introducono la sera: osservare nel suo insieme le Pitture nere, piccole rifrazioni di un enorme dipinto di Goya, lascia fiato secco in gola e una sensazione di smarrimento linguistico, toponomastico, tattile: è tutto ridotto all’osso, scarno, incalzante. Come un tramonto di pianura, con il punto in sospeso: “qui / oh”[11].
Sabato 24 maggio, ore 22
Povera umana gloria
quali parole abbiamo ancora per noi?[12]
Approdo a Umana gloria (2004) quando fuori è buio e gli appunti accumulati in giornata si sono diramati su post-it, taccuini e libri, come indicazioni per una strada nascosta.
«Io voglio indagare il corpo e la sua vita, nonostante la vita muoia: il resto non mi interessa.
Io vivo con gli occhi, vivo con il tatto, con i sensi, vivo con la mia intelligenza, se c’è.
Questo è tutto».[13]
La luce e la direzione che mancano al percorso vengono restituite in dosi abbondanti dalle pagine del primo libro di Mario Benedetti per un editore di portata nazionale. Umana gloria è una mappa: geografica, innanzitutto, con i rimandi ai luoghi dell’infanzia e della giovinezza del poeta, snodata tra il Friuli e la Slovenia, che passa per Milano e arriva fino all’amata Bretagna; antropologica, poi, con la volontà – e la necessità – di indagare senza falsificazioni (etiche e poetiche) la vita com’è; linguistica, infine, con il verso che si distende, si spoglia degli sperimentalismi per abbandonarsi a una scrittura tenue, prosastica. Tutto questo va a costruire un percorso che, in sordina ma con forza, attraverso la sensibilità del linguaggio accomuna l’esperienza del singolo (il poeta) a quella comunitaria (dei lettori). Il mondo che si svela all’occhio del lettore è un quotidiano in cui le verità, i valori e i sentimenti sono legittimati attraverso una poesia che dà spessore all’esistenza prendendone le distanze, percependola in difetto. Un’umanità fatta propria essenzialmente nell’esperienza della perdita, tra sassi, posti di erbe, resti.
In questo aggancio dell’inizio, non riesco a ridurre niente a frammento, a citazione, avvolto come sono dai paesaggi della memoria, mantenuti fertili grazie alla quotidianità reiterata, ai volti amati chiamati a raccolta dal poeta. Mi resta appiccicato un testo, tra gli altri, a spiegare il calore soffuso di Umana gloria. Tanto basta.
Che cos’è la solitudine.
Ho portato con me delle vecchie cose per guardare gli alberi:
un inverno, le poche foglie sui rami, una panchina vuota.
Ho freddo, ma come se non fossi io.
Ho portato un libro, mi dico di essermi pensato in un libro
come un uomo con un libro, ingenuamente.
Pareva un giorno lontano, oggi, pensoso.
Mi pareva che tutti avessero visto il parco nei quadri,
il Natale nei racconti,
le stampe su questo parco come un suo spessore.
Che cos’è la solitudine.
La donna ha disteso la coperta sul pavimento per non sporcare,
si è distesa prendendo le forbici per colpirsi nel petto,
un martello perché non ne aveva la forza, un’oscenità grande.
L’ho letto in un foglio di giornale.
Scusatemi tutti.[14]
Domenica 25 maggio, ore 8
«Mi interessa molto far vedere, mostrare, come un pittore – non astratto, materico –
che permette di avere una visione più vera e tangibile della realtà:
la poesia si tocca, è qualcosa da toccare e da vedere».[15]
Ora non resta che attendere: che Mario Benedetti si muova da Milano, la sua città, attraversando i sobborghi a est della metropoli, l’Adda, uno scorcio di campagna, fino a questa città, poco più di un borgo; aspettare che il pubblico lo raggiunga e sperare in un’intesa spontanea, immediata. Oggi, e non solo oggi, gli interlocutori di Benedetti devono essere disposti a “vedere nuda la vita / mentre si parla una lingua per dire qualcosa”[16], accettando la resa e la scoperta dettate dalla parola.
Nota: tutti gli appunti riportati qui riprendono i temi emersi nell’incontro con Mario Benedetti avvenuto lo scorso 25 maggio 2014 nel corso del festival Trevigliopoesia, a Treviglio (Bg).
***
Intervista a Mario Benedetti (Trevigliopoesia 2014)
Oggi ci confrontiamo con i tuoi tre libri, un percorso letterario multiforme e denso. Proviamo a passarli in rassegna.
Nella mia poesia, innanzitutto, c’è una sorta di autobiografismo.
In Umana gloria ci sono persone e soprattutto paesaggi in cui ho vissuto, come il Nord della Francia, o la Slovenia; ci sono anche situazioni milanesi (come in Che cos’è la solitudine, Ndr).
Pitture nere su carta, invece, è un libro abbastanza complesso, anche nei riferimenti: è difficile capire il senso del discorso. C’è una sezione che si intitola Reliquiari che è un po’ il nodo del libro: parla di quel che resta, i resti della mia vita, del mondo che ho conosciuto. Uno sguardo ultimo, dall’alto, una specie di film, come Fata Morgana di Werner Herzog.
Tersa morte, infine, comincia parlando dei miei lutti, come nella sezione che si intitola Madre, però poi prosegue con delle riflessioni più ampie sulla mortalità.
Come è cominciata la costruzione della tua lingua poetica?
Nella poesia italiana classica del Novecento, diciamo nei versi di Ungaretti e altri, con i quali siamo cresciuti, il discorso verteva soprattutto sulla lettura del piano stilistico formale senza, per me, pensare a cosa stava dicendo il poeta, alle azioni. E allora mi è venuto in mente, con altri amici, di cercare una forma più plastica, dove la sintassi, il ritmo, il timbro delle parole potessero riportare più concretamente la vita e le cose di cui si parla in poesia. Mi interessa molto mostrare, come un pittore – non astratto, materico – che permette di avere una visione più vera e tangibile della realtà: la poesia si tocca, è qualcosa da toccare e da vedere.
C’è un riferimento da cui ha preso il via questo processo?
Fino a Cesare Pavese, la poesia è stata una forma linguistica pura, che si avvicinava a un ideale linguistico formale che era preminente: in Pavese troviamo uno stile, ma questa forma permette – leggendolo – di vedere svolgersi delle azioni. Questo per me è fondamentale, perché la poesia deve far vedere l’oggetto di cui parla: è un compito importantissimo.
Dove è approdato, oggi, questo tuo stile?
Ora non credo più a nessuno stile. In Tersa morte c’è una poesia, per me molto importante, scritta da mia mamma che non ha mai scritto o letto poesia in vita sua. L’epigrafe dice: “Quel nulla che noi non saremo / porta con sé e cancella tutto”. E quindi cos’è quella poesia? Come si fa a pensare una poesia scritta da nessuno? Pensatelo, provateci. Quella poesia non è stata scritta da nessuno, eppure è lì.
Come si dispiega la memoria che torna ricorrente nei tuoi versi?
Non so cosa ci voglia per sentire le cose di cui scrivo, se un po’ di saggezza o consapevolezza. Ci sono questi ricordi, sempre ricordi, che però fanno pensare che anche tu sia già un ricordo. Anch’io sono, o sarò, un ricordo.
Una volta che hai detto Tersa morte, cosa c’è poi nella tua poesia?
Ah, non lo so. In quel libro c’è un testo con un riferimento esplicito alla Ginestra di Leopardi, che mostra tutta la delusione nell’aver capito che la vita è una falsificazione: la natura matrigna che ci illude, come dice Leopardi, amara, amarissima, con il mondo che va in una sua direzione, che afferma continuamente la vita nonostante la vita muoia. La mia via, da persona che osserva la realtà, in maniera anche serena se vogliamo, è quella di una visione molto concreta delle cose, per evitare qualsiasi falsificazione. Così in poesia: io seguo un percorso che non so dove mi porterà. La via d’uscita dalla vita banalizzata, dalla falsificazione, passa attraverso l’osservazione quasi scientifica della mortalità. Io voglio indagare il corpo, il resto non mi interessa. Io vivo con gli occhi, vivo con il tatto, con i sensi, vivo con la mia intelligenza, se c’è. Questo è tutto.
[1] Cit. in Benedetti, Mario, Tersa morte, Mondadori, Milano 2013, p.86.
[2] Mario Benedetti, dall’intervento a Trevigliopoesia, 25.5.2014.
[3] Cit. in Benedetti, Mario, Tersa morte, Mondadori, Milano 2013, p.13.
[4] Id., p.15.
[5] Id., p.27.
[6] Cit. in Benedetti, Mario, Pitture nere su carta, Mondadori, Milano 2009, p.7.
[7] Mario Benedetti, dall’intervento a Trevigliopoesia, 25.5.2014.
[8] Cit. in Benedetti, Mario, Pitture nere su carta, Mondadori, Milano 2009, p.107.
[9] Id., p.104.
[10] Id., p.107.
[11] Id., p.107.
[12] Cit. in Benedetti, Mario, Umana gloria, Mondadori, Milano 2004, p.112.
[13] Mario Benedetti, dall’intervento a Trevigliopoesia, 25.5.2014.
[14] Cit. in Benedetti, Mario, Umana gloria, Mondadori, Milano 2004, p.53.
[15] Mario Benedetti, dall’intervento a Trevigliopoesia, 25.5.2014.
[16] Cit. in Benedetti, Mario, Tersa morte, Mondadori, Milano 2013, p.43.
Maria Borio è nata nel 1985 a Perugia. È dottore di ricerca in letteratura italiana contemporanea. Ha pubblicato le raccolte Vite unite ("XII Quaderno italiano di poesia contemporanea", Marcos y Marcos, 2015), L’altro limite (Pordenonelegge-Lietocolle, Pordenone-Faloppio, 2017) e Trasparenza (Interlinea, 2019). Ha scritto le monografie Satura. Da Montale alla lirica contemporanea (Serra, 2013) e Poetiche e individui. La poesia italiana dal 1970 al 2000 (Marsilio, 2018).