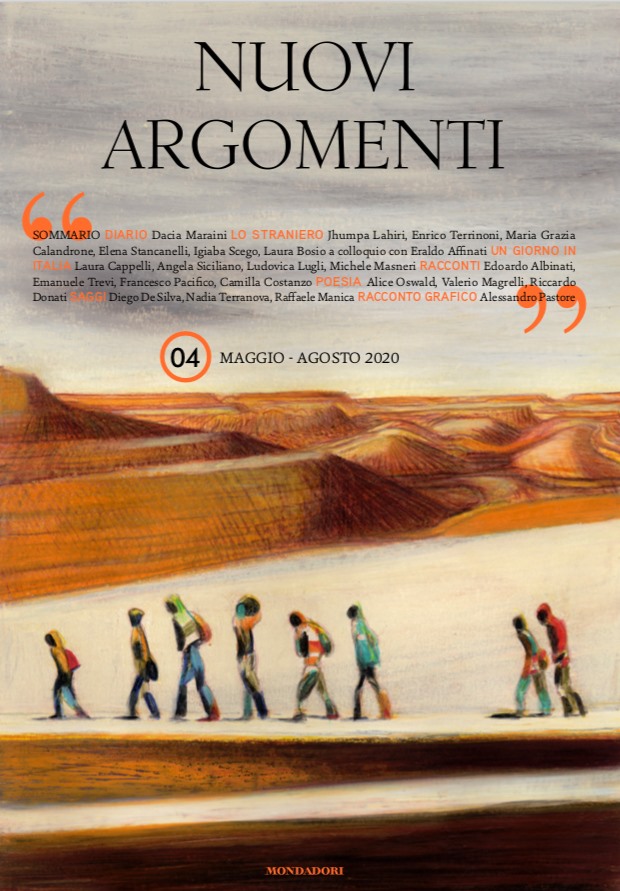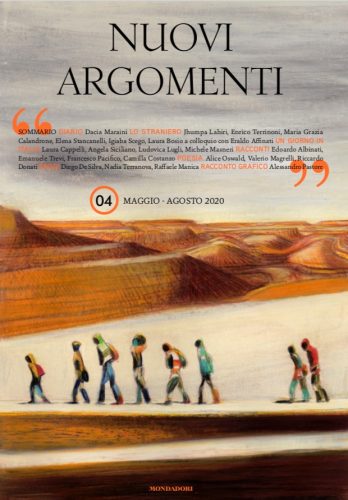Dalla sezione ‘Poesia’ del nuovo numero di «Nuovi Argomenti», appena uscito, pubblichiamo un poemetto inedito di Valerio Magrelli e la postfazione al testo di Riccardo Donati.
Valerio Magrelli
Navigare
Navigare necesse est, vivere non est necesse
I.
“Devo proprio buttarmi?”,
avrei dovuto dirmi.
Ma intanto ero già in acqua:
non si trascorrono dodici anni nuotando
avanti e indietro nella propria mente,
senza che il nuoto invada tutto il resto,
senza che la bracciata abbracci il mondo.
Più grandi le onde, più viva
la voglia di morirne, ché tanto non si muore
(non muore certo in acqua chi ci è cresciuto dentro
come un pisello dentro il suo baccello).
E senza nemmeno pensarci, mi tuffo dagli scogli
nello champagne di roccia e sale e fumo,
brividi, freddo e sole che scarifica,
che cicatrizza il mare,
un’altra forma di casa, casa mia,
la stessa forma di nausea, nausea mia.
II.
Avanti e indietro, ma anche molto alto e basso,
shakerato su e giù dalla violenza,
dall’idro-brutalità di una Jacuzzi impazzita,
e ridevo felice nella mia immunità,
in quell’impunità che sa sfidare il mondo
perché leggera, più leggera del mondo:
felice il tappo che galleggia e ride
mentre i flutti ruggiscono lì sotto!
Anche l’amico sorrideva da terra,
vedendomi danzare sulle acque,
tappo, sì, amo, o piuttosto galleggiante
che segnala se infine il pesce abbocca.
E come, se abboccò!
Dieci minuti dopo, esausto, ebbro,
fatto, strafatto, ubriaco di endorfine,
mi avvicino alla costa per uscire,
quando mi accorgo che non c’è piscina,
bensì, vetrificate da acqua e vento, rocce,
carta vetrata, e soprattutto un’onda
lenta, feroce, cieca, da metronomo.
Atroce è il fulmine, che non si fa annunciare (Schumann),
ma questo prevedibile gonfiarsi e ritirarsi,
venire e sospirare, sfracellare e succhiare,
non mi sembrò da meno.
Una, due, tre; però, alla quarta volta,
mentre afferro la fune che l’amico mi lancia,
capisco quanto persuasiva, gelida,
sia la forza degli elementi: elementare.
Mi trascina sott’acqua, due, tre metri,
mi sbatte sugli scogli come un polpo da ammorbidire.
E difatti ne esco ammorbidito,
una striscia di sangue sulle costole.
Gli occhialetti? Inghiottiti dal nulla,
come un nemico che te li strappi via
per umiliarti, arrogante, offensivo […].
III.
Potevo riprovare una quinta volta.
Potevo riprovare una quinta volta?
Stavo per riprovare una quinta volta.
Questo è il momento che più mi fa paura,
se ci ripenso; questo, il più grande rischio:
Ripetizione.
Ipnotizzato dal mostro, mi ero arreso:
avrei provato e riprovato all’infinito,
una di quelle macchinette-giocattolo che,
caricate a molla, sbattono contro il muro
fino all’esaurimento.
Idiota, idiotizzato dalla sfida,
restavo cieco ad ogni alternativa: come uscirne?
La paura era tale da impedirmi
di pensare alla fuga, anzi, di pensare.
Devo la vita all’amico che, da sopra,
mi scongiurò di andarmene, scappare,
e arrivare nuotando all’altro capo della baia.
Lo feci.
IV.
Mentre le onde mi sballonzolavano
sempre su e giù,
stupido cane che non smette di giocare
a un passo dalla morte del padrone,
riprendo conoscenza del sole smagliante,
della giornata aerea, della mia insensatezza
nell’espormi a un pericolo del genere:
ma si può essere più idioti di così?
Ottimista inguaribile, io ritengo di sì.
Intanto, comunque, nuotavo.
Mi metto a dorso, guardo il cielo, sospiro,
e ora accarezzo la groppa del mio cane
mentre scivolo via, verso la riva,
veloce come un fuso, filante piroga infrangibile.
Sto bene, forse un po’ alticcio,
visto quell’acqua salsa che ho bevuto
e che fa l’effetto del vino.
Ritornano i consigli di un vecchio marinaio
che ricordava come la salvezza
fosse soltanto lontano dalla riva.
Tutto finito? Sembra, perché io sto bene,
volo che è una bellezza, nessun dolore,
e poi guarda che luce, azzurra, oro.
Ora il metronomo è quello delle braccia,
le pale eoliche che scandiscono il moto,
le mani che si alternano alla voga,
alte, slanciate, e le dita…
Ma, quel dito?
V.
Pronto soccorso. Tre ore d’attesa e due chiacchiere.
Il dito a zig-zag non preoccupa, dice il dottore,
ma il nostro frullino si è rotto.
Così me lo vedo arrivare
con le tronchesi in mano,
con le tronchesi usate per i furti
dei motorini.
È l’unica, mi spiega: tagliare via la fede.
Perché, si ruba pure il matrimonio?
Il clac dell’oro (mai più rimesso, da allora),
e il circolo che diventa linea aperta – profanazione.
L’opposto dell’anello che il Doge offriva al mare:
a me, il mare si prese l’anulare.
Poi mi sono operato, ma da allora quel dito,
testimonianza d’alto contrappasso,
è diventato un pezzo di legno irrigidito,
con me, mezzo monco, lì accanto.
Eppure non ho ancora rimpianto quell’errore:
“Natare necesse est, vivere non”.
***
Aliena sin dagli esordi a ogni chiusura nella purezza del codice lirico, la poesia di Valerio Magrelli ha conosciuto un significativo scarto all’altezza degli anni Novanta in ragione – auspice Gianni Celati – della contaminazione con la prosa, muovendo nel corso degli anni sempre più verso una testualità ibrida, duttile e polimorfa. Tra gli esiti espressivi di questo meticciato testuale rientra la pratica del poemetto di matrice autobiografica, con andamento narrativo e increspature riflessivo-morali, ora declinato nei modi dell’invettiva, ora in quelli di una pensosa riflessione sulle abitudini individuali e sociali. Ferma restando la postura percettiva di una palpebra costantemente rovesciata, ripiegata in interiore homine, si potrebbe allora osservare come, col passare degli anni, sia avvenuto uno slittamento da un’introversione interiorizzata a una esteriorizzata, da uno sguardo-analitico che forma e mette a distanza a uno sguardo-confessione che sforma e avvicina. Nel passaggio, l’istanza conoscitivo-definitoria non si eclissa ma cede terreno a una sempre più significativa tensione rammemorante-meditativa.
Mi pare che il testo sopra riprodotto, Navigare necesse est, vivere non est necesse, ben esemplifichi alcune caratteristiche della seconda stagione di Magrelli, senza che questo tuttavia comporti l’abbandono di alcuni motivi originari, anche solo per il fatto che ne è protagonista il sé-giovane. L’ambientazione e le immagini prescelte richiamano infatti elementi assolutamente primari, per non dire primordiali, della sua opera: la dialettica mente/paesaggio/anatomia, la corporeità parcellizzata di contro a un impossibile recupero della salute/integrità, il rapporto sia fisiologico sia cerebrale con l’acqua e con la pratica natatoria in particolare. Basterebbe riprendere in mano le prime sillogi, oggi raccolte insieme al resto della produzione in versi nel volume Le cavie (Einaudi, 2018), per ritrovarvi in abbondanza onde, corpi-ruscello, parole-barca e acque fluenti nelle circonvoluzioni del cerebro (noto en passant come questo sia, forse, il solo campo semantico che rechi traccia, nell’opera di Magrelli, d’una tensione erotica). Del resto in Navigare necesse est come già in precedenti luoghi poetici e prosastici affiora distintamente un profilo, quello di Narciso, che Andrea Cortellessa ha acutamente identificato come la figura d’elezione di Magrelli: un doppio o presenza-specchio qui evocato in absentia attraverso alcuni dei “tu” interpellati dal soggetto poetante (laddove altri interrogativi paiono rivolti al lettore, simile e fratello invitato a empatizzare, condividere, approvare).
Tipicamente riconducibile ai caratteri del secondo tempo dell’opera magrelliana è invece la pratica, sorniona e divertita, di inserire qua e là tessere culturali destinate a ispessire, per risonanza, il discorso poetico: non si tratta tanto di citazioni, quanto piuttosto di esercizi di ars combinatoria variamente declinata. Si pensi al titolo, eco della celebre frase con cui (stando alla Vita plutarchiana) Pompeo avrebbe esortato i soldati romani a prendere il mare nonostante l’infuriare d’una tempesta; massima poi divenuta emblematica del più ardente e umidiccio sentire vitalistico (mi riferisco naturalmente alle Laudi dannunziane). Il motto eroico sbandierato dal Vate è ora volto – con un sorriso che però non implica degradazione o parodia – a siglare il ricordo d’un episodio privato, legato a un sentimento d’immortalità («immunità», «impunità») e a una certa dose di improvvida incoscienza giovanile. Una tessera più ricercata è rappresentata dalla reminiscenza, al v. 38, di una battuta di Robert Schumann. Magrelli allude qui alla risposta con cui l’impetuoso Florestano (ovvero, il compositore stesso) ribatte al giudizio di un organista retrogrado, critico nei confronti delle sconcertanti battute di apertura del movimento finale della Nona sinfonia di Beethoven: «si guardi dai temporali! Il fulmine non manda innanzi a sé un servitore in livrea prima di scoppiare, tutt’al più lo precede un uragano e lo segue poi un colpo di tuono». Altrettanto raffinato è poi, nei versi conclusivi, il richiamo antifrastico a un’antica cerimonia marinara – lo Sposalizio del Mare, evento culminante nel calendario rituale della Serenissima – parimenti scalata a misura della propria vicenda privata (l’anello nuziale).
Considerati nel loro complesso, i centodiciotto versi del componimento, diviso in cinque movimenti – cinque come le dita della mano: e infatti di quella parte del corpo stavolta si tratta (l’anulare, il quarto a sinistra, finirà sacrificato proprio nella penultima strofa) – sono giocati su uno scarto spaesante: fuori dal consueto, circoscritto perimetro della piscina, il soggetto poetante si confronta con i pericoli d’un mare in burrasca. L’imprevisto dérèglement sensoriale causato dal trovarsi in balia degli elementi è come il fulmine che Beethoven scaglia sull’ascoltatore: spalanca la coscienza del gouffre – ossia il terrore, ma ancor più il fascino, per la dismisura, la stessa cui ha dedicato pagine e disegni di ineguagliata potenza uno scrittore di poco più anziano di Schumann, Victor Hugo (si legga a proposito il magistrale Ninfa profunda di Georges Didi-Huberman). Sta qui, credo, la chiave di volta della lirica, da leggere come uno scherzo, un capriccio in senso musicale. Imbastita su un tema da titanismo preromantico, è la storia di un librarsi sull’abisso dettato non già da tentazioni mortifere («ché tanto non si muore») bensì dal bisogno vitale di liberarsi, sia pure per un attimo, dall’ordinato recinto euclideo-cartesiano della mente-piscina e sprofondare nelle pieghe barocche dell’ubriacante, eccedente marea del non-pensiero. L’incauto gesto istintivo che i primi versi, oggettivamente, registrano («ma intanto, ero già in acqua»), è celebrato, con una sorta di riottosa gnome rovesciata, e a dispetto della menomazione subita, negli ultimi («eppure non ho ancora rimpianto quell’errore»).
Anche da un punto di vista stilistico, il testo ben condensa alcuni aspetti peculiari dell’opera di Magrelli. Esemplari risultano in tal senso la scelta della medietas lessicale, con qualche innesto di vocabolario tecnico-scientifico («scarificare», «endorfine»); l’uso del passato narrativo (remoto e imperfetto) alternato a un presente altrettanto diegetico (per tacere degli sterniani, misteriosi tre punti che chiudono il secondo movimento); la natura fluttuante degli espedienti retorici, ora di natura fonica, propriamente lirici, ora di matrice visiva (penso all’establishing shot del v. 100: «Pronto soccorso»); le analogie ad alzo zero (il mare quale shaker, vasca idromassaggio o «stupido cane»; il corpo come tappo, galleggiante, polpo da ammorbidire, giocattolo a molla); e, ancora, l’impiego perlopiù narrativo-argomentativo della sintassi, opportunamente movimentata da giochi ritmici, rime, assonanze che inclinano alla cantabilità (anche in senso pop, con echi canzonettistici), ma intervallata da effetti di pausato quali scatti interiettivi, parole-verso e siglature sentenziose («questo, il più grande rischio: / Ripetizione»). Infine, non meno rilevante e rappresentativa, la componente metaletteraria, sia nel senso della criptocitazione («forma di casa» al v. 16 riecheggia la sezione proemiale di Nature e venature, La forma della casa), sia nel senso dell’implicita metafora creativa. Si veda infatti cosa si ottiene dai versi 4-11 solo che si sostituisca al nuoto la scrittura, alla bracciata il cursus della penna o, appunto, del cursore digitale. E siamo così tornati al primo Magrelli, a quello della scrittura come esercizio di autoriconoscimento studiato da Tommaso Lisa.
Riccardo Donati