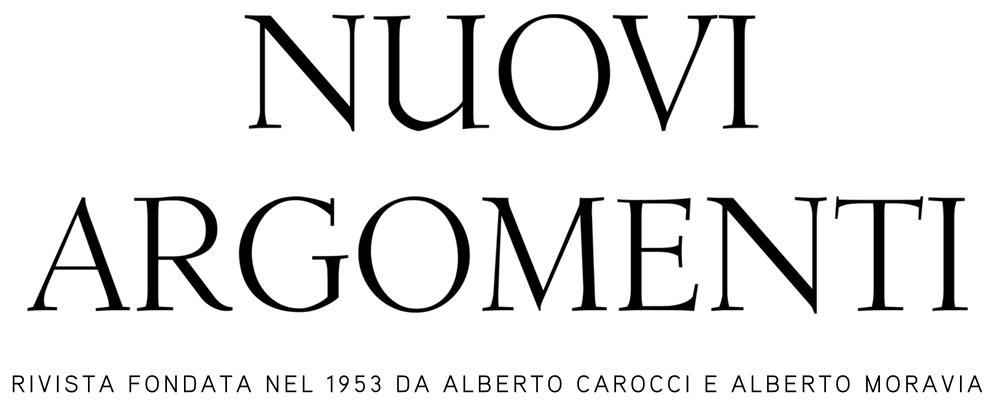E’ appena uscito l’Oscar Mondadori Tutte le poesie di Giorgio Orelli, a cura di Pietro De Marchi, con Introduzione di Pier Vincenzo Mengaldo e Bibliografia di Pietro Montorfani. Di seguito una scelta di poesie e un estratto dall’Introduzione di Pier Vincenzo Mengaldo.
***
da L’ora del tempo
SERA A BEDRETTO
Salva la Dama asciutta. Viene il Matto.
Gridano i giocatori di tarocchi.
Dalle mani che pesano
cade avido il Mondo,
scivola innocua la Morte.
Le capre, giunte quasi sulla soglia
dell’osteria,
si guardano lunatiche e pietose
negli occhi,
si provano la fronte
con urti sordi.
*
CARNEVALE A PRATO LEVENTINA
È questa la Domenica Disfatta,
senza un grido né un volo dagli strani
squarci del cielo.
……………….Ma le lepri
sui prati nevicati sono corse
invisibili, restano dell’orgia
silenziosa i discreti disegni.
I ragazzi nascosti nei vecchi
che hanno teste pesanti e lievi gobbe
entrano taciturni nelle case
dopocena: salutano con gesti
rassegnati.
…………….Li seguo di lontano,
mentre affondano dolci nella neve.
*
A UNA BAMBINA TORNATA AL SUO MARE
Ti dirò, Grazia, che
posso pensare a capre,
a sere scivolate lungo schiene
curve di vacche ai pascoli.
Da quanto tempo è chiusa
la stanza dove ho inciso il mio nome
senza superbia,
scritto i miei primi versi. Fermi i groppi
del soffitto, che un tempo erano occhi.
Morte le vecchie zie.
……………..Ma i ruscelli hanno agli orli
del loro canto il più giovane verde.
E raggio insieme a raggio
del sole posso sentire posarmi
in quest’ora sul corpo, e non mi lagno
se come un vecchio dentro ne risuono.
Volentieri perdóno
al vento e in un esiguo prato
m’arresto a ricordare
te che immersa nell’erba mi gridavi:
«Guarda, nuoto nel mare».
*
A MIA MOGLIE, IN MONTAGNA
Dal fondo del vasto catino,
supini presso un’acqua impaziente
d’allontanarsi dal vecchio ghiacciaio,
ora che i viandanti dalle braccia tatuate
han ripreso il cammino verso il passo,
possiamo guardare le vacche.
Poche sono salite in cima all’erta e pendono
senza fame né sete,
l’altre indugiano a mezza costa
dov’è certezza d’erba
e senza urtarsi, con industri strappi,
brucano; finché una
leva la testa a ciocco verso il cielo,
muggisce ad una nube ferma come un battello.
E giungono fanciulli con frasche che non usano,
angeli del trambusto inevitabile,
e subito due vacche si mettono a correre
con tutto il triste languore degli occhi
che ci crescono incontro.
Ma tu di fuorivia, non spaventarti,
non spaventare il figlio che maturi.
***
da Sinopie
A GIOVANNA
C’era una gran calma. E poiché
non eri riuscita a mangiare il carillon
né il leprotto né il barboncino bianco
né quell’altro bestiolo che neanche tua madre
sa se sia un asinello o un cavallino
o altro che ai nostri tempi scarseggia,
dopo l’amen del rutto ti portammo un po’ fuori.
C’era proprio una gran calma domenicale, e una nebbia
leggerissima, tinta d’azzurro
donde a un tratto emergevano castelli
senza una goccia di sangue, pali
da vigna bianchi, toccati
di verderame, fuggenti sui pendii,
rocce striate di sonno.
………………..Oh non vacillavamo nella nebbia
tua madre ed io, tu ci tenevi d’occhio
anche dormendo, andavamo pian piano,
molto di qua dal fiume andavamo pian piano
su quell’isola appena riemersa, tra quei pascoli alti,
per campi lieti di trasudare,
e dalla nebbia innocente giungevano gridi
simili a quelli dei tuoi piccoli animali,
e avessi visto come correva l’agnello
colore del prato invernale
dov’era rimasto solo.
A metà strada incontrammo altre madri,
altri padri, con la Paola nata
poco prima di te, con la Maura nata poco dopo,
ma tu ti chiamavi Giovanna, e, mentre le mamme
che non si conoscevano, nemmeno dalle lezioni serali
di ginnastica (senza cappello la tua, quel cappello
per cui cento pernici sono morte),
dicevano il colore degli occhi e dei capelli
e il tempo non passava, noi padri, vecchi amici, un po’ più [in là,
per far qualcosa ci coprimmo di nebbia
a segno che le madri ci chiamarono
come fossimo andati lontano.
Tornammo per la strada maestra
e fu tutt’altra cosa: la nebbia inghiottiva i palazzi,
convocava timori intorno a noi.
*
DON GIOVANNI
«Non so più chi pensavo d’andar a trovare. Che ramo
(che dente del rastrello) prenderò?» Si chiedeva,
anche, se gioia o infamia avrebbe tinto il suo giorno.
Miseria ce n’era abbastanza, a cominciare
da quel cavallo, nero lucido, ma scarso, intricato
come una mosca defunta nel bicchiere.
«Riempi bene i vuoti», si diceva, e intanto, là, seduto
su una piccola seggiola, le gambe allungate sul prato,
mungeva il nulla, offrendo or una guancia or l’altra
a un sole pallido che, d’improvviso, scaldava
sino a fendere i fichi per le vespe.
Sentiva, ogni tanto, alle spalle, rumore di tacchi,
ma non si voltava; poi, da una chiesa inghiottita dal verde,
scaglie d’una toccata, d’una fuga, e una donna: «Che bella
sposa, che lusso».
………………«Oh Elvira, Elvira.»
*
DAL BUFFO BUIO
Dal buffo buio
sotto una falda della mia giacca
tu dici: «Io vedo l’acqua
d’un fiume che si chiama Ticino
lo riconosco dai sassi
Vedo il sole che è un fuoco
e se lo tocchi con senza guanti ti scotti
Devo dire una cosa alla tua ascella
una cosa pochissimo da ridere
Che neve bizantina
Sento un rumore un odore di strano
c’è qualcosa che non funziona?
forse l’ucchetto, non so
ma forse mi confondo con prima
Pensa: se io fossi una rana
quest’anno morirei»
«Vedi gli ossiuri? gli ussari? gli ossimori?
Vedi i topi andarsene compunti
dal Centro Storico verso il Governo?»
«Vedo due che si occhiano
Vedo la sveglia che ci guarda in ginocchio
Vedo un fiore che c’era il vento
Vedo un morto ferito
Vedo il pennello dei tempi dei tempi
il tuo giovine pennello da barba
Vedo un battello morbido
Vedo te ma non come attraverso
il cono del gelato»
«E poi?»
«Vedo una cosa che comincia per GN»
«Cosa?»
«Gnente»
(«Era solo per dirti che son qui,
solo per salutarti»)
*
MEMENTO TICINESE
... virumque
terrea progenies duris caput extulit arvis
VIRGILIO, Georg. II 340-1
Benché non fosse tra Carnevale e Pasqua
(forse anche per via di certi fiori
noti-ignoti, rampicanti sul pallido,
che ci adocchiavano dalle case, o perché
inevitabile, a volte, l’andare
tra le immondizie e l’odore di fieno),
il tempo (il vuoto) era come di quaresima.
Ci fermammo su un prato in pendio,
avevamo di contro il calmo campanile
d’un villaggio deserto, e a sinistra, sul versante
d’un’altra delle cento valli, un altro
paese, un gregge zuppo, trattenuto
da una chiesa bianchissima sul baratro.
Ci mettemmo a mangiare, ma c’era un silenzio
che a me pareva di far troppo rumore,
e tornando a guardare i brevi
villaggi e lunghi, semplici come frasi musicali,
non so più chi di noi, ma quasi fosse
un altro per la voce alterata,
disse: «Son vuoti; sembra che aspettino,
rassegnati, qualcuno che li saccheggi».
Proprio allora suonò mezzogiorno, s’udirono gridi
di bambini, e dall’ombra del nostro campanile
apparve, coperto di lamine per gli uccelli dei ronchi,
un vecchio.
………..Ed io ora mi chiedo: a che serve ricordare
come lampeggiava nel sole? come,
senza vento, strideva?
*
SINOPIE
[…]
mentre in disparte l’umiltà dei vinti
[…]
C. REBORA, Framm. XXXIV
Ce n’è uno, si chiama, credo, Marzio,
ogni due o tre anni mi ferma che passo
adagio, in bicicletta, dal marciapiede mi chiede
se Dante era sposato e come si chiamava sua moglie.
«Gemma», dico, «Gemma Donati.» «Ah sì, sì, Gemma»,
fa lui, con suo sorriso, «grazie, mi scusi.»
………………………………….Un altro,
più vecchio, che incontro più spesso, son sempre io a [salutarlo
per primo, e penso: forse si ricorda
d’avermi aiutato, una notte di pioggia e di vento ch’ero [uscito
per medicine, a rimettermi in sesto con suoi ferri (a [quell’ora!)
una ruota straziata dall’ombrello.
Un terzo, quasi centenario, sordo, per solito
se appena mi vede grida: «Uheilà, giovinotto», e dal gesto
[si capisce
che mi darebbe, se potesse, una pacca paterna sulla spalla,
ma talora si limita a sorridermi, o, ad un tratto, eccitato
esclama: «Ha visto! La camelia è sempre la prima a fiorire»,
o altro, secondo la stagione.
…………………………………..D’altri
pure vorrei parlare, che sono già tutti sinopie
(senza le belle beffe dei peschi dei meli)
traversate da crepe secolari.
***
da Spiracoli
VERSO BASILEA
La tetraclordibenzodiossina
trovata nel latte
di una donna di Amburgo che abita
vicino a un inceneritore
mi attraversa la mente nell’istante
che il treno rallenta come senza perché
e un signore laconico gettato un occhio fuori
soffia Hoffmann-La Roche alla quasi assopita compagna.
Vacche brucano in fila tra lunghe strisce d’un giallo
vicinissimo a un tratto, abbacinante.
Flachs, dice il compito signore, ma sbaglia, o vede azzurro,
è Raps, colza, già l’olio adulterato
della seconda sillaba ha mietuto
vittime in Spagna.
………………Da un affisso una donna
invita a non prendere troppo sul serio la vita.
*
DAL BUFFO BUIO (II)
Come alzo un dito non so perché la coccinella che da un po’ ti tiene compagnia lascia il soffitto e viene a posarvisi, non so perché nel viaggio breve dall’orlo al centro del tuo piatto alla formica son cadute le ali.
Paperoso? Carìcido? E adesso è oggi, adesso è domani, tu non devi piangere se il pollice non è all’altezza delle altre dita, non devi prendertela perché ci sono le ore.
*
IN RIPA DI TESINO
Nel mondo delle fiabe in primavera
quando più forte odorano lungo il Ticino i sambuchi
e sui sentieri gli amenti dei pioppi s’ammucchiano
come neve soffiata, aumenta il numero
dei suicidi, specie a causa del Föhn
Seduti tra i cespugli si ha un bel ridere
vedendo passare con l’acqua timbri attrezzi d’ufficio, si [finisce
con lo star male come alla stazione
quando fra un treno e l’altro un colombo si posa
sulle rotaie
Più ricca del Kuwait la Svizzera ha il primato
dei suicidi in carcere, cinque su mille,
un ingegnere delle ferrovie dice che molti si gettano
sotto al treno, due in un mese a Bellinzona,
l’altr’anno sessanta lungo la sola linea del Gottardo
Si resta perplessi si guarda l’amico
di fuorivia perplesso se a un tratto
sul mezzodì vien incontro tra i pallidi tronchi dei platani
un anziano signore sconosciuto che chiede garbato
da che parte è il Ticino, il fiume
Il fiume? Si addita dicendo che il ponte più vicino
l’hanno tagliato e gli altri
sono un po’ tanto a nord, a sud
Ma non meno inattesa la gioia di vederci salutare
con quasi festoso trasporto da chi credevamo travolto
e invece passeggia, pietosamente toccato d’eterno,
sulla diga, la giacca sottobraccio per caldo
***
da Il collo dell’anitra
SYDNEY 2000
Laura Belpiè-Belfianco che nel tuffo
si gira come a letto.
Il cavallo che bacia il cavaliere
dopo un percorso netto.
Dalla vittoria ha la faccia stravolta
un nuotatore e il mondo intero irride,
ma nel triplo la bulgara Teresa
di là dai quindici metri sorride.
Un mio sogno era vincere nel salto
in alto, non fosbury, a forbice
come prima del millenovecento
trentotto, grazie a un trucco,
una molla speciale che dal tacco
spronava il tallone in tal modo
che non era d’Achille ma il mio punto
forte.
*
Come quando di là dal Gottardo
sul diretto salirono due donne
che con capelli di lichene si misero a sedere
dov’ero solo con Maria, e subito l’una s’appese
a un giornale da cui per tutto il viaggio
non si staccò ritagliando ogni poco con cura
chi sa cosa
………….(Maria la guardava
come se da un momento all’altro dicendo «Magia!»
le volesse mostrare sue nuove pregiate cosette:
il dentino che manca, il coleottero
verde fosforescente, la conchiglia
di lumachella appena sditinata
nel bosco)
………….mentre l’altra, intenerita
da tanto biondeggiare azzurreggiare,
conversava in tedesco con Maria
senza risparmio di finto stupore,
ach so! wie so?, fin quasi alla stazione
che non volava via, quando la piccola
scostò «die Zeit» alla silente e chiese:
«Kennst du die schnellste Maus von Mexico?».
***
da Verso «L’orlo della vita» (Poesie edite e inedite)
LOMBARDIA
Da Milano a Pavia
ci sono treni che hanno così poca
fretta che, a volte, in primavera, quando
spuntano i primi cespi smerlettati,
prendono la campagna lenti lenti
e dove forse qualche giornatante
s’aspetta, senza scosse
si fermano, il tempo che basta
perché non pochi viaggiatori possano
scendere e, senza allontanarsi troppo,
cogliere cicorietta per purgare
il sangue, guardati da santi
che in cima a campanili alzano un piede
come per volar via.
*
DUE RAGNI
Da quando? se da giorni
e giorni, mesi ormai,
mentre riposo li osservo
e scordo e non senza stupore
riscopro: ombre d’acheni,
più piccoli di mezza formichetta
smarrita nell’acquaio: sempre lì,
lontano quanto basta dalla lampada
che ha bruciato l’incauto calabrone,
diàfani a furia di guardarli, quasi
trascoloranti in rosa:
chi sa mai se lo sanno
d’essere l’uno a una spanna dall’altro
come due nèi su una spalla,
inquilini abusivi del soffitto,
strani compagni della mia vecchiaia:
sempre lì, sempre soli, senza preda;
una volta soltanto
è arrivato dal Nord
un ragno d’altro rango,
quasi robusto, nerastro,
è passato col fare inquisitorio
d’un commissario
tra i due come se fossero
sorvegliati speciali,
senza distrarli è sparito
in fretta nel gran bianco
e dunque non li ha visti
calarsi a un tratto
sincronici, sostare penzolando
nel vuoto, dove nemmeno si sognano
di cercare un appiglio
per una tela: intenti alle filiere
troppo presto esaurite? saggiando
il peso d’essere, il mistero?
Un attimo, già stanno
per risalire divorando filo
e distanza: per fingersi di nuovo
due disperse crisalidi,
due punti nei dintorni
di me.
*
DORINA
Non sapevo: tuo padre
è morto prima che tu nascessi:
Dorina figlia di Isidoro
detto il Monco, guardiano del Tremorgio.
Che un giorno d’autunno (già qualche fagiano
andava in pianta) era in barca sul lago
per il solito giro idroelettrico
e dalla capanna s’è messo a suonare il telefono
e il suono non cessava; né s’è dovuto affrettare
a piedi, tanto durava la squilla sulla lacrima
azzurra, su tutto.
***
da Appendice
Spesso così, tra loro, distesi nella morbida
erba presso un ruscello sotto i rami d’un albero alto,
poco bastava al giocondo riposo dei corpi,
e meglio se il cielo rideva e la bella stagione
tingeva il verdeggiante prato di fiori. Tempo
di giocare, parlare, tempo di ridere allegri.
Regnava allora la musa agreste, allora una lieta baldanza
li spingeva ad ornare la testa e le spalle
di ghirlande di fiori intrecciati e di foglie
e senza ritmo avanzare movendo duramente
le membra e percuotere col duro piede la madre terra;
donde rompeva la gioia di ridere e scherzare,
perché tutto era nuovo per essi, tutto era meraviglia.
De rerum natura, V 1392-1404
***
Giorgio Orelli: un’introduzione
di Pier Vincenzo Mengaldo
Giorgio Orelli è stato senza dubbio il maggior poeta che il Ticino abbia avuto, il che vuol dire anche uno dei maggiori della generazione italiana, alquanto diversificata, che comprende Risi, Zanzotto, Erba, Giudici, Cattafi ecc. Molto più di costoro, egli è partito dal solido molo d’attracco che sono Le occasioni di Montale, del resto attive in lui fino a tempi recenti (vedi ad es., ne Il collo dell’anitra, Sydney 2000), e s’intende sempre spolpate del loro lusso formale, ma invece spingendosi, in Sera a Bedretto dell’Ora del tempo, fino al nominalismo di Keepsake.
Per l’essenziale, anche il suo pascolismo è filtrato attraverso Montale. Questo fatto dà ragione della sua sostanziale estraneità, fin dall’inizio, all’ermetismo (semmai qualche tangenza è con poeti solo confinanti con l’ermetismo come Penna o Caproni; degli ermetici o postermetici il più vicino è forse Erba, ma in questi l’oggettivismo lombardo ha carattere molto più aleatorio), nonché mette in dubbio la sua assegnazione alla cosiddetta “linea lombarda”, cui appartiene più natione che moribus, e lo stesso suo legame con la tradizione poetica ticinese, che non è affatto marcato, sulla quale viceversa lui stesso ha poi molto influito, specie su Pusterla (per tutto questo, oltre che per la nitidezza del suo segno, Contini l’ha felicemente definito per tempo come un «toscano di Svizzera»).
Dunque Orelli, mentre la poesia ticinese anteriore è arretrata rispetto alla poesia italiana del tempo, anche con tratti “provinciali”, a quella è subito e spontaneamente contemporaneo, senza provincialismo alcuno. C’è in lui fin da subito una sorta di extraterritorialità che convive quasi paradossalmente col fatto che i suoi temi e il suo ethos sono stretti alla provincia ticinese. Questa modernità avrà certo qualche rapporto col salto qualitativo compiuto all’epoca della sua formazione dalla cultura del Ticino, per merito di molti ma soprattutto per la presenza lunga e magistrale di Gianfranco Contini, di cui Orelli è stato allievo, cioè un uomo se altri mai europeo e messaggero dell’Italia migliore: il quale ha prefato acutamente in un’epistola in versi (ora in Amicizie, Scheiwiller, Milano 1991) il primo volume orelliano, Né bianco né viola: «i suoi cauti sugheri», «collezione di silenzi soffiati»…
[…]
L’attenzione, unita a una straordinaria memoria poetica, dà conto di alcuni dei caratteri tipici dello stile del poeta, maturissimo fin dagli esordi. Il primo è la sicurezza netta e sobria nel mettere a fuoco non tanto i colori quanto le linee della realtà (è stato detto: «incide a graffito secco»), a volte in forma di arazzo (Orelli intitolerà la sua seconda raccolta Sinopie), quasi alternando continuamente, come s’è accennato, cannocchiale e microscopio: aiutato da una ricchissima nomenclatura specifica, che gareggia con quella di Pascoli e di Montale, e fa anche di lui un poeta dell’oggetto, quasi che nessun sentimento personale potesse esprimersi se non attraverso il tramite, e forse lo schermo, dell’oggetto. L’altro è l’esattezza nel taglio del verso, con un ritmo perspicuo quasi da percussione di nocche, che si può subito verificare negli eccellenti endecasillabi filati dell’Ora del tempo, di matrice fra dantesca e montaliana, come (velocizzati pure dallo slancio degli sdruccioli) «Nella gloria castissima del sole» o «Se levo gli occhi dal suo prato, fuggono / come in tempesta i giri della Torre», o ancora, più impuntato, «Grida un tacchino i suoi coralli, il fumo», che si rovescia nel verso successivo. Né mancano a contrappunto i novenari cantabili di tipo pascoliano, come «e un sole silvestre s’avvera». Si noterà anche da questi pochi esempi che la lingua di Orelli è, a dir così, fortemente consonantica (ad esempio «La biglia azzurra, la biglia turchese»), come succede ai poeti dialettali della sua area, e ciò più per ricerca di consistenza che di asprezza fonica o petrosità. Ma predominano gli effetti ritmici, poiché la poesia di Orelli, benché sia una poesia dell’oggetto, non si sofferma sul dettaglio ma fila via alacre, insieme veloce e robusta: il particolare è incastonato, non sbalzato fuori, e vive pur sempre in quel tutto o in quello squarcio che il poeta contempla, però quasi alludendovi.
[…]
Orelli, per la fortuna dei suoi lettori, è un poeta che ha sempre somigliato molto a se stesso (anche e nobilmente a se stesso uomo): stanziale senza velleità di fuga (vedi ancora Quasi un abbecedario, p. 17), come vivesse sempre entro una metafora del suo antico, perfetto titolo: Nel cerchio familiare; di casa senza mai fughe nella punta estrema di chi parla italiano (Bellinzona) e nello stesso tempo nella punta della poesia italiana del suo tempo che ha potuto perciò guardare ma anche ignorare; volutamente chiuso entro un numero e una qualità di temi limitati, ma sempre con l’abilità non solo di variarli, ma di guardarli ogni volta con occhio diverso e diversa intensità (eppure quelle minute occasioni sono insieme immagini e sottrazioni del tutto); grande tecnico ma maestro nel celare la tecnica (come nel gioco a nascondino con le rime); maestro anche nel sotterrare il linguaggio poetico (Contini) ma rafforzandone, non eliminandone, tanti elementi; capace di deliziosi scontri fra linguaggio alto e basso, però tenendo sempre a fronte a loro gli episodi e le apparizioni di una vita mezzana e comune, se non trita, e dunque poeta sperimentalista nella lingua e nella tecnica ma non nella selezione tematica (altro e notevole suo tratto individuale). E bisogna pur dire che, anche in virtù di quanto accennato finora, Orelli è un poeta che non assomiglia a nessun altro. È anche per questo che continuiamo a leggerlo, o piuttosto ad ascoltarlo, come a sentir discorrere rapiti un amico unico, che non mente.
Maria Borio è nata nel 1985 a Perugia. È dottore di ricerca in letteratura italiana contemporanea. Ha pubblicato le raccolte Vite unite ("XII Quaderno italiano di poesia contemporanea", Marcos y Marcos, 2015), L’altro limite (Pordenonelegge-Lietocolle, Pordenone-Faloppio, 2017) e Trasparenza (Interlinea, 2019). Ha scritto le monografie Satura. Da Montale alla lirica contemporanea (Serra, 2013) e Poetiche e individui. La poesia italiana dal 1970 al 2000 (Marsilio, 2018).