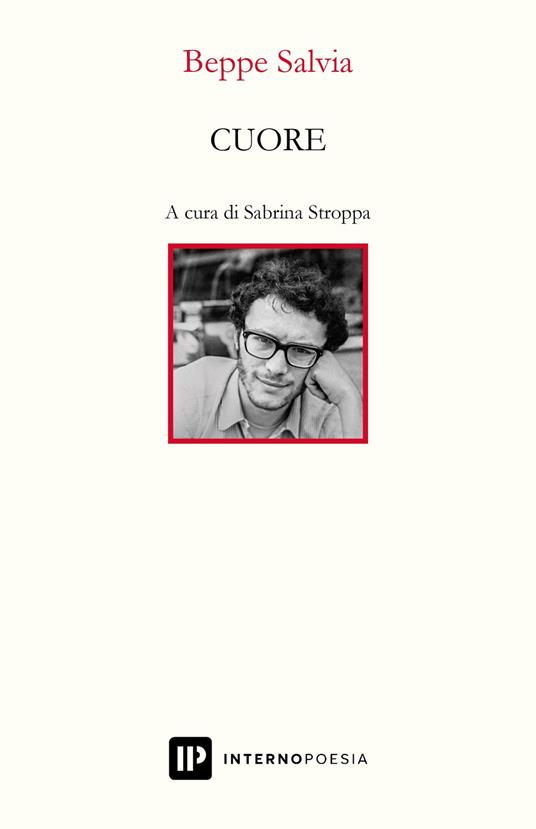Pubblichiamo in anteprima alcuni estratti dell’introduzione di Sabrina Stroppa alla nuova edizione di “Cuore” di Beppe Salvia, in uscita per Interno Poesia.
In quel «clima vibrante di philia» che è la Roma degli anni Ottanta, «luogo d’adozioni» in cui convergono giovani poeti provenienti dal centro e sud Italia, nascono due riviste destinate a lasciare un segno profondo nel decennio: «Prato pagano», fondata da Gabriella Sica, e «Braci», fondata da Claudio Damiani insieme a Beppe Salvia, Arnaldo Colasanti, Gino Scartaghiande e Giuseppe Salvatori. Entrambe caratterizzate da «una pluralità di voci che pure si muovono su uno sfondo comune», saranno il «luogo effettuale» di un numero nutrito di giovani poeti, il centro della sperimentazione di una poesia intonata alla «rigenerazione» di se stessi e della tradizione.
Beppe Salvia era nato a Potenza nel 1954, e a Roma era andato a vivere con la famiglia all’inizio degli anni Settanta. Rapidamente impostosi nel panorama culturale, tra il 1976 e il 1979 aveva pubblicato poesie e prose su riviste come «Nuovi Argomenti» (sostenuto da Dario Bellezza che ne apprezzava la poesia) e «Lettera». Se su «Prato pagano» è presente con regolarità fin dal secondo numero (ottobre 1980), con versi naturalmente, ma anche prose, come il tombeau di Tommaso Landolfi, su «Braci» scrive fin dall’inizio. Nel primo numero (novembre 1980), «fatto con un ciclostile, a mano», nello scantinato della casa di Colasanti, firma quella sorta di apertura programmatica che è Il lume accanto allo scrittoio. Ne ricordo le prime righe, in cui emerge la posizione di una ‘nuova’ e giovane letteratura che vuole rimettere a fuoco il portato emotivo e vitale della poesia, contro il suo culto formale (e si veda, anche, l’attitudine a usare i ribattimenti fonici come scheletro del discorso, qui dolore… valore… calore):
Noi proviamo in questa notte a scrivere della vita e della morte. La letteratura ufficiale ancora adombra con grave e dimessa incuria la volontà di lenire […] e ispira, subito pentita, nuove rinnovate schiere di verseggiatori sentimentali e scolari giustamente beffardi. In queste nostre pagine dunque noi proviamo a far vivere ogni nostro dolore o limite o sofferenza o gioia perché vogliamo ridare allo scritto, un pensiero vergato perché rimanga, il suo più immediato valore che è quello di partecipare esso stesso del vivere, e far vivere anche noi che fuggiamo altrimenti, nel suo duplice calore di ricordo e d’attesa. Poiché del presente il pensare è fuggiasco.
All’inizio del 1984 escono su «Braci» sedici poesie sotto il titolo di “Cuore”: diventerà il titolo generale di un libro che Salvia prepara nei primi mesi del 1985, e che raccoglie una serie di poesie pubblicate in rivista tra il 1979 e il 1984. La sezione eponima comprende una delle sue liriche più belle, «A scrivere ho imparato dagli amici»; e saranno proprio gli amici, dopo la morte di Beppe, avvenuta il 6 aprile dello stesso anno, a ritrovarne i dattiloscritti preparatori tra le sue carte. Il libro apparve solo alla fine del 1987, postumo, per l’editore Rotundo, a cura di Arnaldo Colasanti, come primo numero della collana di poesia «Novelettere», da lui diretta. Nella premessa, Colasanti indicava nei versi di Salvia «lo spalancarsi di una potenza e di una unità lirica» sostenute da «una lingua di magistero, di studio delle cose e degli uomini».
Gino Scartaghiande, che contribuì all’allestimento del volume, ragionando su quella «grande poesia» degli anni Ottanta e Novanta che ebbe le sue radici nei Settanta parla di “Cuore” come di uno dei ‘veri libri’ dell’epoca: «un libro straordinario, miracoloso, impensabile dieci anni prima».
Il volumetto ebbe, subito, almeno due lettori d’eccezione. Pietro Tripodo, in una presentazione del luglio 1988, indicava in Cuore la capacità di «disporre diversamente da prima l’attuale, giovane universo della respublica literarum»; leggendo minutamente i versi, sottolineava l’affollarsi di una «iperattività retorica» che è «a un tempo risultato e sostanza di poesia», una «rabbia della forma» espressa da varie e insistite «tessiture formali», sole in grado di sopportare «l’urto nervoso […] di un’intollerabile urgenza». Andrea Zanzotto, riconoscendo nell’autore una voce importante tra quelle dei giovani poeti che stavano facendo un «salto qualitativo […] verso nuove forme», ravvisava nella poesia di Salvia una «sconcertante luce», capace di creare un «inquietante sfondo di allontanamento», e insisteva sul quid arduo e sfuggente che leggeva nelle sue prove più composte.
Pensando al titolo, passibile di un sospetto di compromissione con il patetismo di De Amicis, Zanzotto lo definiva «volutamente provocatorio, in un certo senso». Non so, ammetteva, «se sia stato dato dai redattori che hanno curato questa pubblicazione, o se Salvia avesse già ordinato queste carte con un titolo simile». Il fatto è che la sua poesia, che ha una luce di giovinezza e di alba e nello stesso tempo qualcosa […] di terribilmente teso verso lontananze imprendibili, lascia una parola lacerata fra gli uomini e la volontà di riprendere contatto con il “cuore” del mondo.
Il titolo era stato dato effettivamente dall’autore: lo si legge in cima all’indice manoscritto. Nella sua intenzionale e provocatoria semplicità conteneva «tutta la novità sfolgorante e scandalosa» della poesia di Salvia. L’aggiunta del sottotitolo “Cieli celesti” tra parentesi – era il titolo della sezione più cospicua del libro – è il frutto, come ricorda Arnaldo Colasanti, di un «compromesso nato dalle rimostranze di Rocco Salvia», fratello del poeta, che «non amava il titolo semplicemente “Cuore”, nell’idea che fosse sentimentale», e chiese di modificarlo in vista della pubblicazione. In realtà l’aggiunta non lenisce di molto il peso della novità di quel titolo, perché anche il ribattimento fonico di “Cieli celesti”, e l’aggettivo desueto e spirituale, rimandano a una certa maniera, insieme semplice ed espressionista, e intenzionalmente ‘antica’.
[…]
Quanto alla lettura di Zanzotto, si ha l’impressione che colga nel segno. La poesia di Beppe Salvia non nasce dalla poesia dei padri, almeno nelle sue parvenze esteriori, ma tenta spesso di risillabare il mondo (da cui la «luce di giovinezza e di alba»), aggrappandosi a termini disusati (cretto, aire, usbergo) che tuttavia non rimandano all’indietro alla tradizione, ma davvero tendono a «lontananze imprendibili», immergendo i versi in un’aura di atemporalità nella quale potrebbe essere ravvisata la maniera più autentica di essere contemporanei. «Appartiene veramente al suo tempo», scriveva Giorgio Agamben in pagine celebri, «è veramente contemporaneo colui che non coincide perfettamente con esso né si adegua alle sue pretese ed è perciò, in questo senso, inattuale; ma proprio per questo, proprio attraverso questo scarto e questo anacronismo, egli è capace più degli altri di percepire e afferrare il suo tempo».
[…]
Non inganni, quindi, la parvenza di poeta adolescente che spira dalle pagine salviane. È in ogni caso anch’essa il frutto di un compromesso con la tradizione, magari con quel côté corazziniano – evocato da Marco Lodoli in uno dei tre interventi pubblicati su «Paese Sera» il 18 aprile 1985, dopo la morte improvvisa di Salvia – che è pur sempre una postura altamente letteraria. Così, negli anni, Arnaldo Colasanti si è trovato a parlare di una «grazia scontrosa» (di sabiana memoria); Eraldo Affinati di un «sentimento crepuscolare»; più d’uno, come Claudio Damiani, riconosceva la presenza del “fanciullino” in Salvia: un lungo susseguirsi di aneddoti e ritrattini dai quali esemplarmente emerge, oltre il lavoro del lutto, il costituirsi di un vero e proprio mito.
Se ne sottrae, subito, Franco Fortini, che nel 1986 su «l’Espresso», in una famosa recensione al secondo numero della nuova serie di «Prato pagano», insieme alla sua stigmatizzazione di certa intenzionale leziosità dei versi di quell’«area romana» di giovani poeti («Codesti finti infanti e queste ingenue libertine sono invero dei post-diluviani candidi e volpini, maestri in arti di elusione ma anche esposti al rischio della dissoluzione del sé»), si mostrava contrario a «ogni costituzione di culto letterario attorno al defunto confratello suicida», come espressione di un «ricatto sentimentale» teso a imporre il «mito del genio poetico come angelo cadente e cercatore di Euridice».
Dai racconti degli amici emergeva in effetti il ritratto di un genio sofferto, di poesie scritte per urgenza di scrivere, con continui pentimenti e vergogne, noncuranze, distrazioni e distruzioni: poesie che, secondo una vulgata dura a morire, Beppe teneva appallottolate nelle tasche, come imponeva il canone montaliano del poeta “che ha cambiato mestiere”. Così lo ritraeva Edoardo
Albinati:
Salvia recalcitrava a mettere ordine tra le sue poesie, che conservava in fogli spiegazzati nelle tasche della giacca; spesso leggeva ai redattori delle riviste letterarie liriche bellissime che poi distruggeva, o che finivano smarrite. Toccherà a quegli amici ricostruire un’opera che il suo stesso autore faticava a tenere con sé, come fossero sassi che l’appesantivano.
Fin troppo facile, come dicevo, riconoscere in questi racconti i lineamenti del poeta che forse vorrebbe cambiare mestiere; o che, come nel caso di Salvia, quando un mestiere – un lavoro vero – l’aveva ottenuto, si era subito dipinto come incapace di rinunciare a quell’azzardo rappresentato dalla vuotezza funambolica e rischiosa della vita di prima27, e l’aveva riabbracciata. Lo racconta, nel cuore della sezione «Cuore», il dittico di pseudo-sonetti «I miei malanni si sono acquietati» e «M’innamoro di cose lontane e vicine», a cui si potrebbe accostare un passaggio della sezione «Mestieri» di Elemosine eleusine che nella sua iterazione svela un’ossessiva, tragica disperazione:
ogni giorno sotto ogni riguardo progredisco sempre di più ogni giorno sotto ogni riguardo progredisco sempre di più ogni giorno sotto ogni riguardo progredisco sempre di più.
Nel mito salviano, le poesie scritte e poi trascurate disegnano la conseguente difficoltà a costituirsi come autore di un libro, dato che il frammento, la provvisorietà, la pubblicazione di singole sequenze in rivista si costituiscono a lungo come orizzonte prediletto per il suo esercizio di poesia. Eppure, dalle carte oggi consultabili per merito della generosa donazione del fratello Rocco alla Biblioteca nazionale centrale di Roma, si scopre non poi così rispondente a verità che Beppe «recalcitrasse a mettere ordine tra le sue poesie». Anzi, sembra vero il contrario: come del resto attestava anche Colasanti, accennando, nella breve premessa all’edizione di “Cuore”, a quelle carte «ordinatissime» sulla base delle quali era stato pubblicato il libro.
Salvia si era in effetti annotato un indice, enumerando le varie sezioni in ordine grosso modo cronologico, segno che la disposizione doveva seguire una sorta di evoluzione dei vari nuclei poetici. Aveva suddiviso le poesie in fascicoletti spillati. Aveva conservato le versioni dattiloscritte con le revisioni precedenti l’uscita in rivista, e poi fotocopiato queste versioni e iniziato a lungamente rivederle, limarle, correggerle (con successivi pentimenti sulle correzioni, che risultano a volte molto stratificate). Aveva conservato, e scrupolosamente registrato, la successione delle «corone di sonetti» descritte in “Elemosine eleusine”. Tutt’altro atteggiamento, dunque, rispetto a quelle sprezzature ricordate dagli amici.
Una lettera indirizzata da Salvia a Gabriella Sica, dattiloscritta con correzioni autografe a penna, e datata 18 settembre 1980, registra le sue reazioni alla ricezione delle bozze di “Lettere musive”, una sequenza di quindici poesie pubblicata nel secondo numero di «Prato pagano», poi inclusa in “Cuore” come seconda sezione. Salvia si dichiara «contento» di aver potuto vedere le bozze,
«in fondo le prime» per lui, giacché per le precedenti uscite in rivista, ad esempio su «Nuovi Argomenti», non c’era stata questa possibilità. Annota di non aver trovato molti errori, tranne che il compositore ha pensato bene di eliminare tutti i “trattino a capo” che io mi ero lungamente studiati meno per ragioni metriche, questi lavori io li ho sempre chiamati “quasi sonetti” e non “sonetti”, che per ragioni squisitamente prosodiche.
[…]
Una «tensione ricostruttiva» anima comunque il poeta, così come i versi dei giovani amici di quell’ambiente romano a cui partecipa così intensamente. Come rende evidente la molteplicità di registri e di temi di “Cuore”, Salvia condivide con loro quella visione della tradizione come «strumento che possa far approdare a un nuovo concetto di “umanesimo”, in cui l’uomo ritorni finalmente ad essere padrone della sua lingua»: una lingua «chiara e luminosa come era stata quella della poesia italiana e classica», che trova la luce attraversando lo scavo e la prigione, e che «affranca la cultura poetica italiana dall’ermetismo».
Le riflessioni più recenti sulla poesia delle nuove generazioni fiorita tra la fine dei Settanta e l’inizio degli anni Ottanta hanno indicato in Beppe Salvia l’autore di «un rinnovamento della nostra poesia, un cambiamento di rotta che sarà poi gravido di conseguenze». Il libro “Cuore” è una delle testimonianze più compiute di questo cambio di rotta, e alcuni suoi versi finiscono per diventare il manifesto della nuova generazione. Nella «nuova casa, bella» di «Sillabe» che tutti i lettori di Salvia amano e hanno amato si incarna, a dire di chi ha vissuto quegli anni, il senso stesso della poesia di quei giovani45. «L’altrove non viene da una situazione eccezionale. La casa d’ombra è in un pomeriggio in una casa qualunque di Roma, e il tempo eterno è nel tempo normale».
In realtà, nell’inquietudine sotterranea, nella fêlure che percorre i versi di «Adesso io ho una nuova casa, bella» risiede forse l’immagine più giusta della poesia di Salvia, una poesia che reca i segni di un guasto a cui non si è ancora pienamente «messo mano», ma che dalla sua calma forza interna, che s’indovina dalla struttura ancora sana, consente di gettare lo sguardo verso «quasi / tutta la città» che si staglia all’orizzonte – tanto che la vista si fortifica e la vita, da quella radice, si raddoppia:
Sembra d’aver
qui nella casa un’altra casa, d’ombra,
e nella vita un’altra vita, eterna.
Quell’altra vita, eterna, al poeta è assicurata dalla sua poesia, nella quale riversa ogni suo «dolore o limite o sofferenza o gioia», come recitava la prosa del “Lume accanto allo scrittoio”: una poesia ‘fuggiasca’ del presente, e classicamente o petrarchescamente protesa tra i due tempi inafferrabili del passato e del futuro (il «duplice calore di ricordo e d’attesa»): i più veri spazi d’esistenza del cuore.