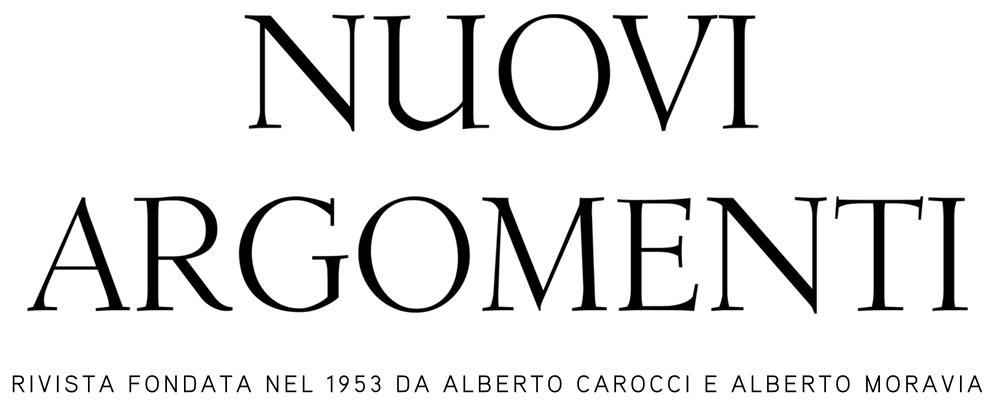Parlare dello spirito e del percorso delle anime. Recuperare «la radice» nelle sue plurime contraffazioni. Ripescare la cifra mitica della filosofia. Queste sembrano essere le ispirazioni che muovono Luigia Sorrentino nello scrivere Olimpia. Si tratta di una scrittura estremamente coraggiosa che, nei suoi moti verticali, non teme di cavalcare la curva dell’idealità, non ha l’inibizione del legame con lo spazio. Il suo obiettivo infatti è quello di esplorare una terra mitica che abita nell’uomo come idea innata, che non sottostà al tempo e che si configura come salvezza spirituale.
Si potrebbe dire che la raccolta abbia quasi un’impronta cristiana se l’autrice non si mettesse al riparo da questa eventualità trincerandosi dietro il fascino del mito, che trascina il lettore in un territorio primitivo e primigenio ben distante dal moralismo religioso. La dimensione temporale è data da un tempo assoluto: «i tempi s’intrecciano, entrano in un’epopea dove tutto è così nostro da diventare remoto, tutto è così perduto da diventare presente». Così Milo de Angelis sottolinea nella efficace prefazione.
«Siamo colui che sprofonda a un passo da noi, / di padre in padre siamo stati / quella tua età sparsa nella casa». I testi che precedono l’entrata in Olimpia, la città mitica, preparano lo spirito ad un momento quasi sacro. L’anafora «siamo sempre più vicini al cielo» contribuisce a dare questa sensazione di progressivo avvicinamento alla meta, che corrisponde quasi ad una metamorfosi che ci trasforma in soffio, voce, vento, cicale. L’arrivo alla città è stigmatizzato dal passaggio alla prosa poetica, una descrizione che sa di racconto. «Si allargava così pacatamente quel luogo di bagliore e di sonno». Ancora una volta richiami alla filosofia, ci sembra di sentire i dormienti di Eraclito che, in questo caso con la loro inconsapevolezza, varcano la soglia di quella città che è coincidentia oppositorum, è bella, giovane e vecchia allo stesso tempo. Per varcare la soglia, si ritorna al verso. L’uomo viene da «troppa lontananza» e conquista a questo punto una dimensione onirica. La luce accecante spegne la vista e lascia spazio ad una percezione più fine. «Enorme il tempo appoggiato ai muri». La Sorrentino ci suggerisce in modo lapidario la monumentalità di uno spazio-tempo che non appartiene più alla dimensione mortale, stiamo effettuando l’accesso al trascendente che è precipitato nella pietra. Compare a questo punto una «maschera salita sulla montagna», il luogo per eccellenza della rivelazione, mentre «noi siamo tornati per scomparire / intorbidare il fondo».
Segue una descrizione del giardino da cui emerge il gusto classico, l’arte che è mimesis della natura e che in questa riconosce il suo ideale di bellezza. In questa sezione, c’è un richiamo piuttosto forte al terreno, ormai unico elemento concreto in una realtà ormai mitica, nella quale anche le piante sembrano monumenti eterni. Segue un’altra prosa poetica sul lago che «avremmo ricordato come un transito»; e ancora, «Siamo scesi qui per vedere l’ombra e il traguardo dell’ombra». A questo punto, viste le origini partenopee della Sorrentino, mi sembrerebbe quasi di sentire un sapore nostrano in questa descrizione. Sembra quasi di avvertire l’odore della Solfatara non lontana e di sentire le leggende silenziose della Sibilla cumana. Credo che il Lago D’Averno si sia figurato in maniera più o meno inconsapevole nella mente di Luigia, perfettamente in linea con la tradizione, come «ingresso» ad una dimensione nuova e misteriosa, o comunque iniziatica.
Nella sezione seguente, il passaggio è avvenuto. «Lo spazio fu questo sprofondare / in un tempo in cui furono solo / il saccheggio e la voce». Siamo già al di là e si fa spazio, ripetitiva la domanda orfica «è quella la porta?». Luigia Sorrentino gioca molto sulle anafore e anche in questo svolgersi di reiterazioni mi sembra voglia rievocare quasi una componente liturgica che, spogliata dai contesti abituali, risulta più assoluta che non simbolica e rituale. Nei testi successivi, invece, si presentano richiami puntuali alla filosofia presocratica. Si parla dell’acqua e dell’«inaudito volto della fonte»; chiaro il riferimento a Talete, che proprio nell’acqua individuava l’archè, verso la cui ricerca tutta la filosofia antica era orientata. Poi si tocca Anassimandro e l’apeiron quando l’autrice riporta di spazi dilatati e di tempo infinito. La fiamma, elemento eracliteo, che nella sua dinamicità, riassumeva il principio del mondo. I riferimenti della Sorrentino, mai pedanti, sono animati da un vigore ricreato ex novo, non è la loro storia a renderli affascinanti, quanto il loro sistematico calarsi in un discorso sempre vero ed immanente, in procinto di compiersi. Non mancano espressioni filosofiche più vicine a noi, penso a Schopenhauer e a Bergson, al suo «tempo sospeso tra mente e cuore». Di particolare bellezza è il coro numero 6. In questo testo si stabilisce il legame tra città e abitanti, legame capovolto. Per Luigia è infatti la città ad amare i popoli, e aggiunge che senza questo amore ogni stato «scheletrisce e annera». Da questo punto in poi, ha inizio la sezione del libro permeata da maggiore dualismo, si è sempre in bilico tra eternità ed immanenza, tra unione e separazione, tra eros e polemos. E’ in questi versi che viene fuori la cellula madre della scrittura della Sorrentino, si percepisce chiaramente che qui c’è il nodo da cui si dispiega la poesia. Giunge in sordina il tema della morte come riduzione a frammento, in maniera evanescente. Morire è un passaggio di stato, come l’acqua passa al vapore, la vita passa alla morte. Dunque il destino è già inglobato nell’origine, lo portiamo con noi da sempre: «tutto quanto era lì, l’aveva / custodito per molti anni / nella piccola quiete domestica». Inoltre essa giunge come qualcosa di piacevole che una madre natura benigna ha pensato per noi: «caro ci fu ingoiare / il rimasuglio della nostra vita». E allora dopo la disaffezione graduale alle cose e lo spaesamento del passaggio, «ritorniamo arcaici, al servizio di ciò che siamo stati».
Il tempo abbandona il suo ritmo biologico per approdare ad un tempo assoluto, un’età che racchiude in sé il prima e il dopo. Ed è a questo punto che la speranza fa il suo ingresso nella coscienza, è «quello spirito del futuro sopra le rovine». Con il suo respiro ambizioso, Olimpia è una raccolta che sfida le linee editoriali. Lo fa ammiccando alla nostra coscienza e al nostro intelletto e iniettando nello spirito un siero di lungimiranza.
Maria Borio è nata nel 1985 a Perugia. È dottore di ricerca in letteratura italiana contemporanea. Ha pubblicato le raccolte Vite unite ("XII Quaderno italiano di poesia contemporanea", Marcos y Marcos, 2015), L’altro limite (Pordenonelegge-Lietocolle, Pordenone-Faloppio, 2017) e Trasparenza (Interlinea, 2019). Ha scritto le monografie Satura. Da Montale alla lirica contemporanea (Serra, 2013) e Poetiche e individui. La poesia italiana dal 1970 al 2000 (Marsilio, 2018).