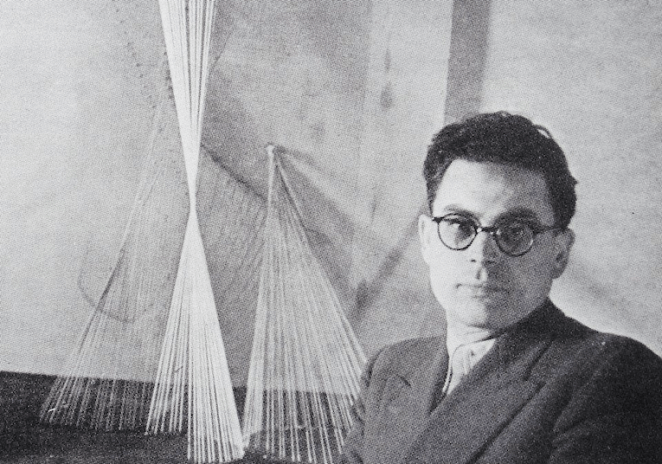Esce oggi l’Oscar Mondadori che raccoglie i racconti di Leonardo Sinisgalli, a cura di Silvio Ramat. Pubblichiamo alcuni estratti.
da FIORI PARI FIORI DISPARI
Questo libro è dedicato ai miei amici
Roma, 3 dicembre 1942
Forse io ho troppo premuto sulla mia vita
col peso del mio cuore
(Da una lettera a *)
I
Ho ritrovato i miei compiti del tempo della guerra, i compagni di scuola, l’aula del convento, il mio maestro maniaco e distratto che aveva lo stesso nome di mio padre e morì avvelenato dal fumo. Per molti anni le nostre mamme continuarono a parlare di lui come di un uomo rovinato dai vizi. Ritrovo in queste pagine l’ombra della sua mano, larga come i fogli che portano diverse date tra il gennaio e il giugno 1917. È un quaderno smilzo che ha sulla copertina un’illustrazione dell’eccidio di Serajevo e poche righe di leggenda. Quell’anno, a star dietro ai ricordi e ai dettati del maestro, dev’essere stato gravido di minacce.
[…]
VI
Quando migrano le mandrie dalle terre alte al tepore dei paesi di marina i buoi entrano all’alba tra i muri delle case. I bambini, scossi nel sonno dal clamore dei campani, si buttano scalzi dal letto alle finestre, a guardarli. Coperti di velli i pastori si appoggiano alle lunghe aste. Fuma la pelle alle bestie ruminanti. Le donne corrono ai balconi a strappare i panni colorati. I buoi stanchi del cammino e indolenti perdono la strada diritta e restano ammassati nei vicoli ciechi, su un panno di sole, abbattuti. Allora i nostri uomini escono dalle case in maniche di camicia e armati di pali cercano di alzare da terra i colossi dirupati. Ma è fatica inutile, ché bisogna correre alle funi, attorcigliarle alle corna e lavorare di polso come se si alzasse una campana. Il toro si fa trascinare fino all’imbocco del vicolo, poi si mette diritto a guardare il sole. I nostri padri allora, per asciugare il sudore, cominciano a bere. Il bue che lascia la mandria per stendersi al sole è una bestia
malinconica: bisogna ammazzarla per evitargli di soffrire. Così si fa pure ai cavalli che si slogano le ginocchia. Un colpo alle tempie. (Le tempie degli uomini si chiamano sonno e quelle degli animali, salvo i cani che sono i soli a saper dormire su una guancia, non hanno nome.) Per i buoi si evita il colpo. Basta una lama bene affilata e robusta da spingere nella nuca. Noi aspettavamo, da ragazzi,
il passaggio dei buoi (mille, duemila; talvolta se la testa era in piazza, la coda si trovava ancora fuori dell’abitato) per vedere i nostri padri tracannare bicchieri fumanti di sangue col pretesto che serviva a scampare dalla malaria. Il bue moriva senza muggire. Lo si scuoiava e si faceva a
pezzi in mezzo alla strada. La pelle poi si metteva a seccare e per qualche giorno i colombi abbandonavano i tetti. Quando i buoi entrano in lotta, il ferito scompare, scornato. Si nutre, s’ingrassa fino a riprendere forza, poi torna alla mandria e va in cerca del suo nemico e lo punge, lo stizza fino a costringerlo a un nuovo combattimento. Io ho visto in un giorno di festa togliere gli stendardi dalle finestre e i festoni per far passare i buoi. I buoi diritti sulle zampe posteriori si appoggiavano ai muri e strappavano i garofani dai vasi. Quando giunsero in piazza avvenne
l’incontro col vessillo di San Giorgio. I buoi si divisero in due file, mansueti, e il Santo passò a cavallo in mezzo a quelle corna. Solo più tardi si seppe che un bue aveva calpestata una bambina vestita a festa e la bambina era salva, con la pelle intatta e la veste fiammante ridotta in cenci dalla furia matta di quella bestia nemica del fuoco. Il miracolo era accaduto e la bestia fu sacrificata. Nello stesso giorno i ricchi devoti organizzarono una questua. Furono comprati due buoi e due vacche e legati al tesoro del Santo. La piccola Carmina e una sorella furono votate a custodirli, e guai all’uomo che avesse loro arrecato molestia con l’occhio. Ora le bambine son fatte donne e i
buoi non si contano tra le rupi numerose. Quando il sole è forte esse scendono a bagnarli nell’acqua del fiume. Poi dispongono i vitelli in cerchio sul prato e li fanno giocare con le loro gonne. Quelli si azzuffano come i ragazzi attorno alle bandiere.
XI
Si fumava all’ombra deliziosamente. Si fumavano sigarette pessime lassù in collina, ma l’aria era così buona che il fumo ne conservava il sapore. Si fumava da mattina a sera come dei carcerati. S’era detto di smetterla con le carte perché più si giocava a carte più si fumava. Si giocava a carte tutte le sere dopo la cena e all’una di notte si usciva a guardare la luna e le stelle cadenti. Il tenente R. riusciva a contarne dieci in pochi minuti: a me capitava di trovarmi sempre con le spalle rivolte da quella parte del cielo dove la stella era caduta. Facevamo a gara tutte le notti per indovinare il punto preciso dell’orizzonte dove la luna sarebbe apparsa, ed eravamo riusciti a sbagliare di pochi minuti il tempo che la luna metteva a svelarsi tutta quanta. Che lunghe discussioni sul colore delle stelle! Sono rosse, sono bianche, sono verdi come i fichi. Il tenente R. sosteneva che Sirio ha gli occhi celesti. Un cavallo con gli occhi celesti! Ma Sirio non è un cavallo! Sirio è un cane o un cacciatore che tutte le sere fa la guardia alla luna. Di cavalli con gli occhi celesti noi ne avevamo uno tra i cinquecento cavalli del gruppo. Unoria, la cavalla di carica del capitano O. Unoria era l’unico cavallo gazzuolo del gruppo, una rarità. Ma aveva ancora altri vezzi, un labbro bianco e una macchia rosa alla narice. Il tenente R. sosteneva che Santola era più bella di Unoria, anche se era visibilmente più vecchia. Santola è purosangue e Unoria una meticcia! Poi ci si metteva a fare il conto dell’età sulle dita e diventava veramente difficile trovarsi d’accordo. Si sapeva che l’iniziale F rispondeva quell’anno al nome dei puledri di quattro anni. Si partiva allora dalla S e si contava sulle dita S, T, U, V, Z, A, B, C, D, E, F: undici. Undici più quattro, quindici: Santola ha quindici anni, esclamava R. Ma non ci si trovava d’accordo sull’età dei cavalli. A me piacevano quei discorsi. In mancanza di altro, fumando, mi piaceva sentir parlare di cavalli. Avevo imparato a distinguere un sauro da un baio, un brocco da un saltatore. Sam mi aveva descritto una monta e le sue parole m’erano rimaste impresse nella memoria. Mi piaceva anche discutere di andature e pensare ai miei versi. Mi dicevo sottovoce, anzi non dicevo nulla per non far scoppiare tutti a ridere: io scrivo come un cavallo cammina, come un cavallo che cammina ad ambio. Se avessi detto quella frase ad alta voce tutti si sarebbero messi a ridere e il tenente P. avrebbe detto che scrivevo versi coi piedi. Ma quelli erano i discorsi che più mi piacevano, perciò ero diventato amico del tenente Sam. Dicevo a Sam, che mi piaceva molto la puledra grigia che mi era stata assegnata, e aggiungevo, per farlo ridere, che ero geloso delle guardie di scuderia. Se qualcuno una sera torna ubriaco fa la festa a Florinda. Sam non mi dava retta, non mi dava retta quand’io parlavo per parlare e dicevo delle cose così per dire. Se non provvedono a mandarci delle donne vedrai che i soldati faranno la festa alle nostre puledre, vedrai che nell’isola dei nani e dei ciclopi avremo una generazione di centauri. Prima di cena, a sera erano di rito i discorsi sulle cavalcature. Facevamo gruppo davanti alla porta della mensa: qualcuno tirava fuori le sedie, un altro si accosciava sui gradini e ci si offrivano le sigarette, ci si complimentava per una bella cravatta, per un paio di guanti nuovi, per una frusta. Che belle sere! I cavalli tornavano dall’abbeverata legati per tre. Tutti i giorni veniva fatta la toletta dei quadrupedi, si guardavano il pelo e gli zoccoli, si lavavano gli occhi e gli ani con una spugna. Ma da una settimana all’altra i cavalli calavano. Mi pare che siano un po’ calati, diceva seriamente Sam al tenente C.; pure non fanno un gran lavoro, dovrebbero inquartarsi e almeno tirar fuori un po’ di pancia. Ma li fate bere questi cavalli? Cinque volte al giorno, rispondeva C., quasi venti litri di acqua, e qui l’acqua vale oro, ce n’è meno del vino. Ma Sam non era convinto. Ecco arrivare il sottotenente F., un ragazzo di vent’anni, una firma, dicevamo noi. Adesso anche lui aveva preso la cotta per i cavalli e stava in sella da mattina a sera. Sta in sella anche quando piscia, aveva detto il maresciallo maniscalco. Sam cos’è questa storia? Il tenente N., detto Sam perché veterinario di Samugheo, era molto benvoluto dalla subalternaglia. Avevamo fatto di tutto per convincerlo a prendere anche la direzione della mensa, e Natalini che da cinque anni si trovava nell’isola e conosceva tutti i pastori e i cacciatori del Mandrolisai riusciva a combinarci dei pranzi eccellenti. Tornava con le bisacce piene di pernici o di conigli selvatici, con barili di vernaccia. Del resto era quello l’unico modo di combattere la zanzara. Sam riusciva a camuffare, a furia di prezzemolo e di origano le carni più vili, a far passare un castrato per una vitella. Noi arrivammo perfino a pensare che certi squisiti piatti egli aveva dovuto ricavarli dai lombi dei cavalli morti.
XII
Forse si può vivere anche senza donne, anche senza amore: noi eravamo felici quella primavera in collina, così soli come non lo saremo mai più, così amici quando i soldati ci buttavano secchi d’acqua gelata dopo i primi bagni di luce isolana. Stavamo sdraiati coi piedi nel trifoglio e la testa quasi nelle nuvole, tanto ci sembrava di vivere in alto su quel poggio dove s’era accampata la batteria, coi cannoni nascosti tra i sugheri. C’erano i falchi a ore fisse che comparivano a coppie, ed erano allegri e pazzi come farfalle, c’erano le mucche che venivano fin sotto le tende a brucare, e gli asini beati e divini, chiusi come cani nelle tanche, gli asini che ci comparivano di notte lungo un viottolo all’improvviso, e facevano caldo d’intorno col loro soffio, col loro lungo pelo. Quei giorni a noi sembravano vuoti: vuoti e bellissimi perché noi eravamo lassù senza pensieri, senza pensieri e senza amore come i nostri cavalli, che diventavano lucenti al crescere dei giorni, cambiavano pelo e unghie insensibilmente giorno per giorno. I soldati preferivano vivere lassù e scrivere lettere sulle ginocchia piuttosto che scendere in paese a guardare le ragazze, preferivano starsene in tenda la sera in attesa del turno di guardia a leggere, a leggere a voce alta romanzi
pornografici. I soldati non erano certo castrati come Nivasio, come Quario, come Oppido, i più bei cavalli del gruppo: i soldati non ne potevano più e si buttavano a segnare coi coltelli sulle gavette delle astruse immagini di donne, sulle gavette dove mangiavano e sulle pareti di legno delle
garitte, scavavano coi temperini figure immaginarie ed oscene, scavavano l’inguine colla punta del coltello fino a far passare la lama dall’altra parte della parete. Noi sapevamo ammansirli. Ordinavamo per quindici giorni dalle sei alle otto del mattino una ripresa a cavallo in circolo. Ci
si metteva al centro colla frusta, e giù, un quarto d’ora di passo, un’ora di trotto senza le staffe, una mezz’ora al galoppo. Le bestie facevano fumo e schiuma, le vene venivano fuori evidenti sotto la pelle: i soldati restavano buoni per un po’ di giorni. Una volta venne in mente anche a noi di andare a far l’amore ad O*, piccola città di mare che distava una ventina di chilometri dalle nostre tende. Eravamo nella corriera, io e il mio vecchio capitano, un siciliano che aveva avuto una gioventù sportiva e avventurosa, vincitore di una targa Florio e di vari concorsi ippici. Ricordo che mi mostrò alcune fotografie di quella sua età e mi parve irriconoscibile. La corriera scendeva a picco sulla roccia lungo la rotabile che a valle s’incontrava col fiume. Il capitano era grasso e floscio a quaranta anni, ma, a sentir lui, straordinariamente vivo e virtuoso in amore. Eravamo in pianura: il fiume ci stava a lato stretto tra le rive di pietra e immobile. La landa era sterile e infinita. Si alzavano altissimi gli steli delle ferule palustri, fioccose come finocchi, superbe come girasoli. Ci sono le zanzare, signor capitano, dissi io. Ci sono le anitre, disse il capitano, e attaccò a parlarmi di alcuni processi celebri, dello studente Conguenos, del tenente Paternò, della contessa Trigona. Egli conosceva particolari minutissimi di quelle storie e provava certo un particolare gusto a eccitare
la mia fantasia. Non so come il discorso cadde poi sulla guerra e ognuno di noi ebbe modo di ricordare gli amici che erano al fronte, gli amici che non erano come noi imboscati nell’isola. Sono i ragazzi più belli, disse il capitano, quelli che muoiono in guerra; è strano come siano veramente
i più belli a morire. E ognuno di noi ebbe modo di confermare quella verità, ognuno di noi aveva avuto un amico più bello di tutti gli altri che era già caduto. Eravamo nel punto più basso della vasta pianura: si capiva dalle larghe pozze che arrivavano fin sotto il pelo della strada. Si sentiva già aria di mare e le poche nuvole in cielo erano nuvole marine. Quando arrivammo ad O* i vetturini, che la sapevano lunga, si offrirono in massa per accompagnarci. La gente della città ci vedeva in carrozza leggermente esilarati: la gente sapeva che tutti gli ufficiali in carrozza venivano dall’interno dell’isola per godere un’ora d’amore a O*. Il vetturino ci chiese conferma delle nostre intenzioni, e, al trotto lungo, ci portò fuori della città in un cortile dove alcune ragazze giocavano a buttare pezzi di pane alle anitre che natavano nella vasca. Le ragazze ci vennero incontro, presero i guanti, le fruste, le bustine, poi scomparirono per ricomparire subito a piedi nudi in lunghe vesti sfolgoranti.