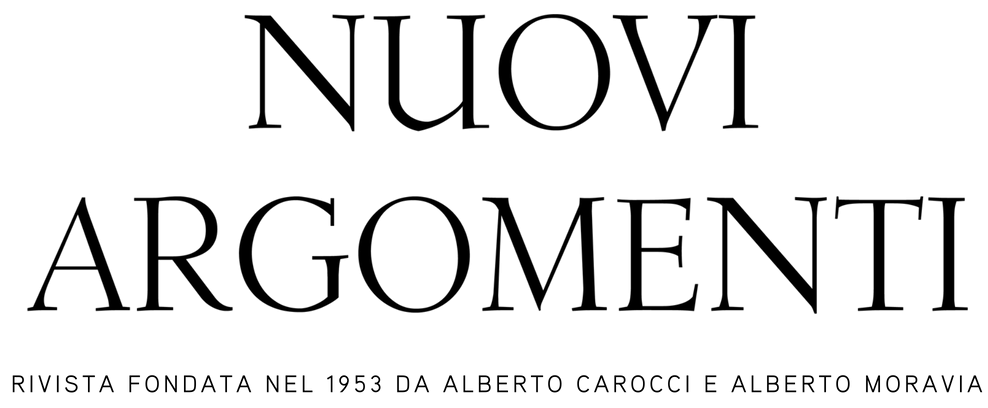Esiste una particolare fenomenologia della lettura delle poesie di Mallarmé a cui, fino a oggi, molti critici hanno fatto indirettamente riferimento con i diversi tentativi di analisi. Non vi è dubbio, infatti, che ci sono alcuni fenomeni distinti, i quali, come microeventi, agiscono insieme, e che, seppure rivestano un valore variabile da un lettore all’altro, possono essere descritti in modo tendenzialmente oggettivo e, per comodità, persino riordinati in gruppi. Nel primo gruppo rientra quella grande quantità di suggestioni immediate che procurano, a volte, anche un effetto di ridondanza. Si tratta in buona parte di suggestioni foniche: allitterazioni, assonanze, parole arcaiche o comunque rare – dunque percepite come fossero dei puri significanti (il lettore ne ignora il significato). Le rime hanno in tal senso un’importanza cruciale, perché a partire da Mallarmé, e poi in ambito simbolista, sono dei veri punti di raccordo tra il livello puramente sonoro e i vari strati semantici: questi «giochi di rima», come sono stati definiti (1), sono un ottimo viatico per entrare nel cuore della poesia mallarmeana, e permettono di scoprire interessanti retroscena del processo compositivo (2). Vi sono poi le suggestioni di tipo visivo, nel senso detto sopra: visioni frammentarie, oggetti enigmatici, scenari inconsueti, incoerenze rappresentative. […] Non si può certo dire che la poesia di Mallarmé si muova attraverso ragionamenti astratti o concetti. Al contrario, proprio questo ricco repertorio di visioni, ancorché problematico da maneggiare, è uno dei maggiori motivi del suo fascino. Accanto a tutto ciò, vi è un altro gruppo di sollecitazioni per l’intelligenza, strettamente legato a una tessitura sintattica quanto mai impegnativa, per cui il lettore si ritrova spesso a inseguire – cercando di indovinarla come in un gioco enigmistico – la costruzione della frase, ben dissimulata dietro una fitta rete di inversioni e ritardi. Lo sguardo si fissa sul testo per individuare il soggetto, il verbo principale, il complemento, l’apposizione (che spesso è formata da un intero verso). Tutto questo al fine di comprendere, certo, ma anche di immaginare meglio. Com’è noto Mallarmé ha disseminato nei suoi scritti – non solo nelle poesie – una quantità di piccole trappole, di anfibologie, ovvero, per riprendere la formula di Derrida, di luoghi «indecidibili» (3). Per non parlare delle espressioni ellittiche, dei vuoti improvvisi, dei salti analogici: tutti elementi che, a partire dalla sintassi, segnano un progressivo straniamento della parola poetica rispetto al linguaggio comune (pp. 19-20).
Note
1) André Guyaux, «Jeux de rimes et jeux de mots dans les poésies de Mallarmé», in aa.vv., Mallarmé. Actes du colloque de la Sorbonne, Paris, Presses de l’Université de Paris-Sorbonne, 1998, pp. 191-200.
2) È cosa nota (e il manoscritto de Les Noces d’Hérodiade lo rivela chiaramente) che Mallarmé componeva le sue poesie seguendo il procedimento dei «bouts rimés». Come osserva Richard, la rima è per Mallarmé «articolazione attiva, cerniera, elemento generatore di mobilità», costituendo così «l’architettura prima del poema». Jean-Pierre Richard, L’Univers imaginaire de Mallarmé, Paris, Seuil, 1961, p. 583.
3) Jacques Derrida, La Dissémination, Paris, Seuil, 1972.
***
Il pomeriggio d’un Fauno
EGLOGA
IL FAUNO
Quelle ninfe, le voglio perpetuare.
…………………………………………….Sì chiaro,
Lieve il loro incarnato, che volteggia nell’aria
Assopita fra sonni folti.
,……………………………………..Ho amato un sogno?
Il mio dubbio, accumulo di notte antica, sbocca
Su ramoscelli i quali, rimasti gli effettivi
Boschi, provano, ahimè, che da solo m’offrivo
Il difetto ideale di rose per trionfo –
Riflettiamo…
………………..le donne di cui discuti forse
Figurano un auspicio dei tuoi sensi fantastici!
Questa illusione sfugge agli occhi blu ed algidi,
Come una fonte in pianto, fauno, della più casta:
Però, tutta sospiri, l’altra, dici, contrasta
Come brezza del giorno che il vello ti accalora?
Macché! nell’indolente e immobile torpore
Soffocante di afe il fresco del mattino
Se lotta, non sussurra che l’acqua dal mio piffero
Versata al bosco intriso d’accordi; e solo il vento
Oltre le mie due canne ad esalare lesto
Prima che il suono sfumi in una pioggia arida,
È, all’orizzonte che non una ruga altera,
Il soffio artificiale visibile e quieto
Dell’ispirazïone, che riguadagna il cielo.
O sponde siciliane d’una palude cheta
Che a gara con i soli vanitoso saccheggio,
Tacito sotto i fiori di scintille, narrate
«Che mentre i cavi giunchi dal talento domati
Tagliavo, sulla glauca doratura di fronde
Lontane che consacrano la loro vigna a fonti,
Un biancore animale in abbandono fluttua:
E che al preludio lento, esordio degli zufoli,
Quel volo, non di cigni! di naiadi si tuffa
O scappa…»
…………………..Inerte, tutto brucia nell’ora fulva
Celando con che arte insieme se l’è data
Troppo imene voluto da chi ricerca il la:
Mi sveglierei al fervore originario allora,
Sotto un antico fiotto di luce, dritto e solo,
Gigli! e uno di voi quanto ad ingenuità.
Altro che il dolce niente sparso dal loro labbro,
Quel bacio, fievolmente garante delle perfide,
Il mio seno, di prova vergine, un morso attesta
Misterioso, dovuto a qualche augusto dente;
Ma basta! un tale arcano elesse a confidente
Il giunco vasto e gemino che all’azzurro si suona:
Il quale, a sé deviando l’affanno della gota,
Ci immagina, in un lungo assolo, a dar sollazzo
Ai luoghi tutt’intorno con confusioni false
Tra il nostro canto credulo e la bellezza loro;
E a fare, in alto quanto si modula l’amore,
Svanire da quel sogno ordinario di dorso
O fianco puro ch’io a occhi chiusi rincorro,
Una sonora, vana e monotona linea.
Prova dunque, strumento delle fughe, o maligna
Siringa, a rifiorire ai laghi ove m’attendi!
Fiero del mio bruire, a lungo delle dee
Io parlerò; e, mediante idolatre pitture,
Toglierò all’ombra loro ancora altre cinture:
Come quando dell’uva ho succhiato la luce,
Per bandire un rimpianto dal mio fingere eluso,
Gaio, innalzando il grappolo vuoto al cielo d’estate
E, le sue luminose bucce gonfiando, avido
D’ebbrezza, fino a sera sto a guardarvi attraverso.
O ninfe, diamo fiato a ricordi diversi.
«Il mio occhio, bucando i giunchi, dardeggiava
Ogni scollo immortale, che annega nelle acque
Il bruciore, gridando rabbia al cielo degli alberi;
E lo splendido bagno di capelli scompare
O gemme prezïose! tra i guizzi e i tremolìi.
Corro; quando, ai miei piedi, s’avvinghiano (sfinite
Dal languore gustato al male d’esser due)
Delle dormienti sole tra le braccia fortuite;
Io le rapisco, senza slacciarle, e volo via
A quel cespuglio, odiato dall’ombreggiare frivolo,
Di rose il cui profumo tutto al sole s’evapora
Dove il diletto al giorno consumato sia pari.»
T’adoro, virginale corruccio, aspra delizia
Del nudo peso sacro che sgusciando si svincola
Dal mio labbro di fuoco che beve, come un lampo
Trasalta! l’apprensione segreta della carne:
Dai piè dell’inumana al cuore della timida
Che al tempo stesso lascia un’innocenza, intrisa
Di lacrime sfrenate o men tristi vapori.
«Rallegrato dal vincere quegli infidi timori,
Il mio torto fu sgiungere il ciuffo scapigliato
Di baci dagli dei tanto ben mescolato;
Infatti, non appena nascosto un riso ardente
Tra le pieghe gaudiose di una sola (tenendo
Con un semplice dito, ché al suo plumeo candore
Il turbarsi dell’altra accendesse un colore,
La più piccola, ingenua e che non arrossava:)
Dalle mie braccia, sfatte da quei vaghi trapassi,
Si libera, per sempre ingrata, quella preda
Sprezzante del singulto di cui ancora ero ebbro.»
Poco male! annodando la loro treccia ai corni
Della mia fronte, altre m’indurranno alla gioia:
Tu lo sai, mia passione, che ogni mela granata,
Purpurea e già matura, si spacca e bruisce d’api;
E che il sangue, invaghito da chi se lo va a prendere,
Cola per l’infinito sciame del desiderio;
All’ora in cui cinereo si fa il bosco e dorato,
Una festa si anima tra lo spento fogliame:
È da te, Etna!, quando, giunta in visita Venere
Sulla lava posandoti i suoi talloni ingenui,
Un sonno triste tuona e si smorza la fiamma.
Ho la regina!
………………..O certo castigo…
……………………………………………No, ma l’anima
Di parole vacante e il mio corpo infiacchito
Tardi cedono al fiero silenzio del meriggio:
Presto occorre dormire nell’oblio dell’oltraggio,
Sulla sabbia assetata disteso e a volontà
La bocca aprire all’astro efficace dei vini!
Addio, coppia; vedrò l’ombra che divenisti.
Immagine: Nicolas Poussin, Paesaggio con Orione cieco in cerca del sole, 1658.
Maria Borio è nata nel 1985 a Perugia. È dottore di ricerca in letteratura italiana contemporanea. Ha pubblicato le raccolte Vite unite ("XII Quaderno italiano di poesia contemporanea", Marcos y Marcos, 2015), L’altro limite (Pordenonelegge-Lietocolle, Pordenone-Faloppio, 2017) e Trasparenza (Interlinea, 2019). Ha scritto le monografie Satura. Da Montale alla lirica contemporanea (Serra, 2013) e Poetiche e individui. La poesia italiana dal 1970 al 2000 (Marsilio, 2018).