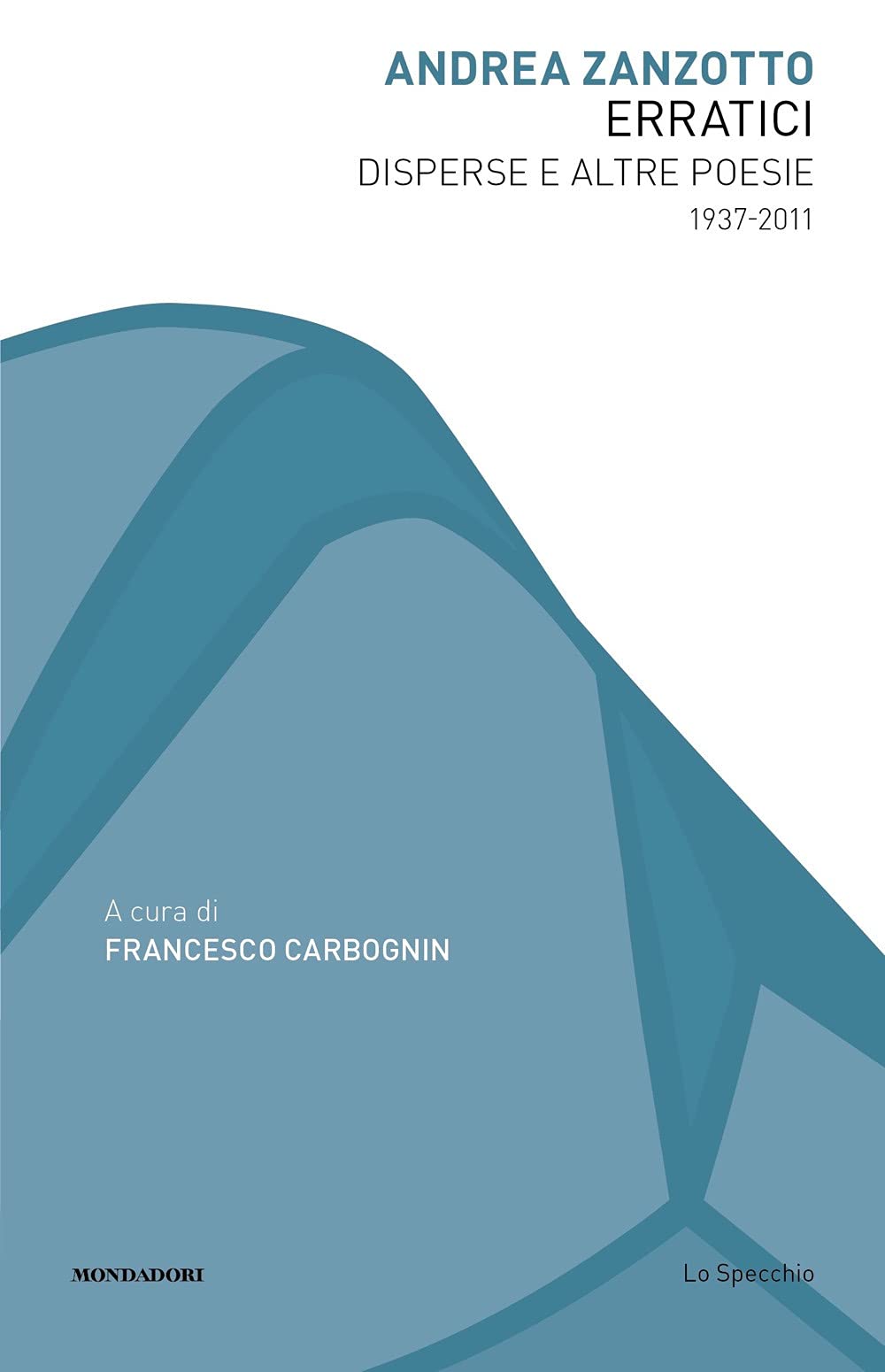In occasione del centenario della nascita (10 ottobre 1921) e del decennale della morte (18 ottobre 2011) escono in questi giorni nello «Specchio» Mondadori due libri di Andrea Zanzotto, Erratici. Disperse e altre poesie 1937-2011, a cura di Francesco Carbognin, e Traduzioni trapianti imitazioni, a cura di Giuseppe Sandrini. Numerose le altre pubblicazioni occasionate dal centenario fra le quali un numero della rivista «il verri», il 77, intitolato (con ironiche parole della Beltà) E l’avanguardia ha trovato, ha trovato? e dedicato ai rapporti polemici e ambivalenti di Zanzotto coi Novissimi (il fascicolo contiene fra l’altro estratti dai suoi carteggi inediti con Luciano Anceschi a cura di Francesco Carbognin, con Vittorio Sereni a cura di Silvia Volpato, con Pier Paolo Pasolini a cura di Gian Maria Annovi, con Elio Pagliarani a cura di Andrea Cortellessa e con Cesare Vivaldi a cura di Chiara Portesine; e a cura di Giovanna Cordibella la trascrizione di un intervento televisivo di Zanzotto su Paul Celan, nel 1976 alla trasmissione «Settimo giorno» condotta da Enzo Siciliano); una «Pietra d’angolo» dell’editore Aragno che contiene la grande prosa del 1964, Premesse all’abitazione, e altre rare pagine coeve dedicate alle arti visive e all’architettura, accompagnate da un saggio di Andrea Cortellessa intitolato Abitare, Zanzotto; oltre a un’ampia monografia dello stesso Cortellessa pubblicata da Laterza col titolo Andrea Zanzotto. Il canto nella terra. A lui abbiamo chiesto di presentare questo suo lavoro adattando il suo articolo su Erratici e Traduzioni trapianti imitazioni, in uscita in forma integrale sul numero di ottobre della rivista «Poesia» diretta da Nicola Crocetti, che ringraziamo.
***
Zanzotto, un secolo. Questo il titolo dato a quello, fra i tanti incontri in programma in tutto il mondo (calendario aggiornato su www.andreazanzotto.it), che si svolgerà dall’8 al 10 ottobre nella Heimat di Pieve di Soligo: per ricordare i cent’anni dalla nascita – il 10 ottobre 1921 – del maggior poeta italiano del secondo Novecento. Un secolo non è niente, nella scala mostruosa dei tempi geologici che – sulla scorta di Ernst Bloch, ma anche di Leopardi e dell’abate Zanella – sin dai suoi primi passi ha vagheggiato Zanzotto. Che nel suo primo grande saggio, L’inno nel fango, dedicato nel ’53 al più decisivo dei suoi maestri, Montale, già si riferisce ai «miliardi di anni messi al posto dei millenni»: quelli che in Filò – con la «terra […] “desolata” non in superficie, ma in profondità» che s’è scrollata di dosso, in Friuli nel ’76, migliaia di superbi umani di superficie – chiamerà «megasecoli».
Ma il tempo di Zanzotto, come il suo spazio, non è mai uniforme. È invece, per dirla con Bloch, un multiversum: dove «passato e futuro», si legge nella Beltà, sono in «oscura combutta». Sempre la strepitosa nota senza titolo che mette capo a Filò evoca «un tempo dalla freccia e durée diverse», il quale governa non solo il poemetto che finalmente “erutta” il dialetto màtrio a lungo represso, ma anche la formidabile terna di libri scritti in contemporanea in quei vulcanici Settanta, Il Galateo in Bosco, Fosfeni e Idioma: che infine comporranno, a cavallo del decennio successivo, la «pseudo-trilogia» capolavoro. E dunque, se un secolo non è che un battito di ciglia in questa prospettiva “megasecolare”, corrisponde a una quasi-eternità nella scala temporale opposta, quella microparticellare del vissuto d’ogni giorno, che pure Zanzotto mette a fuoco come nessun altro (nella grande prosa del ’64, Premesse all’abitazione: in questi giorni di nuovo in volume nella collana «Pietre d’angolo» di Aragno e, nella traduzione di Martin Rueff, nell’antologia “geografica” Venise, peut-être pubblicata da Nous):
ogni luogo ogni albero ogni casa ogni ombra o luce che s’alzi cada scompaia può […] portarmi dalla stabile ferma esaltazione allo spolpamento, al cavernizzarsi dell’anima, all’erosione del senso dell’essere. Rapidi e imprevedibili sono i mutamenti del mio tempo interiore con le decine e decine di immagini del mio paese che si legano a una via o a un’altra; ore e giorni che in apparenza si sovrappongono in uno screziatissimo e inestricabile tessuto, ma che invece scattano fuori acremente distinti l’uno dall’altro, col loro aggressivo sapore di guasto o di paradiso, solo per minime mutazioni o movimenti.
Assomiglia più a questo spolpamento, a questa erosione del senso dell’essere il circuito imbambolante della social-doxa attuale. Anche in una materia che, come quella poetica, in teoria dovrebbe esserle refrattaria: e che nel decennio che ci divide dalla sua morte – appena compiuti i novant’anni, il 18 ottobre 2011 – ha fatto invece a gara a “ridimensionarlo”, Zanzotto (come Tintoretto in una gag di Woody Allen), quale “tipico” esponente di un secolo magari omaggiato ma ingombrante e, diciamolo, tanto antipatico. Meglio continuare a spararla sempre più grossa, per serialmente épater non si sa quale “conformismo”-voodoo, coll’anteporgli questo o quel minore, o minimo, che non ci sfida con le sue spericolatezze linguistiche e concettuali, e ci conforta col dono a buon mercato d’un significato prêt-à-porter, docile a ridursi a cioccolatino del senso comune.
Laddove la sfida radicale di Zanzotto – uomo del suo tempo, certo, che il suo tempo ha trasceso con tutte le oltranze e tutti gli oltraggi – è la stessa dei massimi: la stessa che al senso comune hanno lanciato Mallarmé e Pound, Montale e Rosselli, Char e Rimbaud, Dickinson e Stevens, Mandel’štam e Chlebnikov, Celan e Hölderlin (tutti suoi phares, et pour cause); e sì, certo, la stessa del “padre” Dante quest’anno tanto mass-banalizzato. Lo dice un componimento di Pasque, Misteri della pedagogia, ambientato in un luogo, tanto vero quanto allegorico, che ha per nome «Centro di Lettura»: l’oscuro poeta di oggi vi viene chiamato a spezzare per i pargoli il pane così nutriente, ma al primo morso così coriaceo, della parola giusto di Dante. La «maestra Morchet» lo provoca, lo irride: «lui quello sì, Dante!», lui che proclama che «Lume non è se non vien dal sereno / che non si turba mai». Ma questa legge è pronunciata, nel XIX del Paradiso, dal lume di Dio in persona: il quale aggiunge che ogni pretesa d’illuminazione umana è invece «tenèbra / od ombra de la carne o suo veleno». Ma è appunto coll’ombra della carne, e colla sua tenèbra, che tocca sempre fare i conti a noi sublunari: il lume di quel senso lo possiamo solo inseguire, a tentoni, coi nostri poveri strumenti umani – per speculum et in ænigmate (anche Paolo è un riferimento chiave per Zanzotto, che negli anni Sessanta ne traduce diverse lettere – ora nel “quaderno di traduzioni” ricostruito da Giuseppe Sandrini).
Rispondendo a studenti appena più grandicelli di quelli di Misteri della pedagogia, qualche anno dopo dirà Zanzotto:
spero che abbiate capito che, se sono qua e là difficile, lo faccio malvolentieri; è una necessità di essere, non una volontà di imbrogliare il gioco.
La comprensibilità si verifica a vari livelli. C’è una comprensibilità che si realizza in modo immediato, ma è quella che può avere un articolo di giornale, anzi che è indispensabile in un articolo di giornale. Nella poesia non è così, perché qui si trasmette per una serie di impulsi sotterranei, fonici, ritmici, ecc. Pensate al filo elettrico della lampadina che manda la luce, il messaggio luminoso, proprio grazie alla resistenza del mezzo. Se devo trasmettere corrente a grande distanza, mi servo di fili molto grossi e la corrente passa ed arriva senza perdita a destinazione. Se metto, invece, fili di diametro piccolissimo, la corrente passa a fatica, si sforza e genera un fatto nuovo, la luce o il colore.
Sicché le stesse poesie che «25-30 anni fa sembravano molto difficili […] può accadere che […], con l’evolversi della cultura e con l’aumento dell’informazione abbiano a risultare più accessibili». La resistenza opposta dalla materia linguistica, dalle ombre della carne, è dunque funzionale allo sprigionarsi del messaggio luminoso della poesia. Una comprensione tanto più illuminante quanto più torbido e tortuoso il percorso fatto per raggiungerla: «flash flash» o «lamp lamp», lampadina che «anglofumettistica» s’accende, all’improvviso, nelle partiture più ispide della Beltà o degli Sguardi i Fatti e Senhal. Così nella Commedia di Dante, certo – dalle tenèbre dell’Inferno all’Empireo del Paradiso –, ma pure presso moderni a Zanzotto cari come i surrealisti o Gadda: sempre, psicoanaliticamente, après coup.
Leggere un poeta come Zanzotto, allora, vuol dire ri-leggere. Rileggere i suoi testi, certo (come non mi stanco di fare da più di vent’anni), ma anche ri-leggere attraverso il suo filtro creativo la tradizione del pensiero e della poesia d’Occidente: che tutta quanta pare metabolizzata, e infinitamente ricoagulata (come il sangue di San Gennaro nella Beltà), al suo vaglio onnisciente. Per questo il già citato “quaderno” di Traduzioni trapianti imitazioni (terna squisitamente zanzottiana che si legge su uno dei suoi appunti) – che si aggiunge agli esemplari storici di Sereni, Fortini, Giudici e Luzi, più quello del pari postumo di Caproni– rappresenta la miglior guida al Pantheon di Zanzotto (a partire dagli archetipici Rimbaud e Hölderlin scoperti a diciassette anni, a Padova, insieme alla psicoanalisi e all’esistenzialismo nel decisivo 1938: lo stesso anno in cui escono, a Milano, i primi versi che Zanzotto abbia conservato, e che inaugurano l’altro preziosissimo addendo bibliografico offertoci dal main publisher Mondadori, il volume di poesie disperse curato da Francesco Carbognin) e, insieme, quasi un manuale del poeta come – lui, proprio – universale Centro di Lettura.
Seguendo i fili di Traduzioni trapianti imitazioni incontriamo per esempio uno Zanzotto “erotico”: che nei suoi testi, schermati, la vulgata ancora ignora ma che, a ri-leggere in questa chiave libri come Gli Sguardi o Il Galateo, fa sobbalzare sulla sedia. Non solo i nobili slanci dell’amatissimo Éluard verso «la beltà del tuo corpo», le grazie eleganti di Ronsard e la congiunzione metafisica di Salinas, ma anche l’occhieggiare malizioso della Civettuola di Ibn Hamdîs (poeta arabo di Sicilia, XI secolo) e quello della Ragazza d’osteria dell’Appendix Vergiliana (dove una pseudo-classicità già elegiaca strizza l’occhio a Kafka).
Se è un infinito intrattenimento che dà il massimo diletto, passeggiare nei boschi di questo Divano Occidentale-Orientale guidati dalle pepite luccicanti del Pollicino del Quartier del Piave, ci consente di ri-passare tutte le sue stagioni – sessant’anni di raccolte “ufficiali”, da Dietro il paesaggio a Conglomerati, precedute da quindici di “archeologia” Trenta e Quaranta, ma anche sino a sforare nei Duemiladieci, con l’après-lude della plaquette Il Vero Tema pubblicata nel 2010 e nel 2011, alla vigilia ormai del congedo – l’altro libro, con un titolo a sua volta irresistibile come Erratici. Sino all’inizio del 2009, a pochi mesi dalla pubblicazione di Conglomerati, in effetti era questo il titolo della raccolta-explicit; e il passaggio dall’una all’altra metafora geologica (entrambe attestate pure nel “fratello” Paul Celan) dice molto, a ben vedere, del valore testamentario di questo libro ultimo: tanto complesso e straordinario quanto in sostanza, sino ad ora, mai letto davvero.
Ce n’è per tutti i gusti: da uno Zanzotto ludico e mondano (il sonetto à la manière di Borges prelude allo scatenamento manieristico, in gara con Fortini, dell’Ipersonetto incastonato nella plaga “informale” del Galateo in Bosco; ma c’è pure una poesia in francese, su Hegel enfant, da leggere insieme alla versione da Eleusis contenuta nell’altro libro…) a uno Zanzotto pensoso esistenzialista da manuale, dal pioniere dell’ecopoetry al remixatore sanremese (dopo Modugno e Nilla Pizzi, è la volta di Celentano), dal poeta civile al fenomenologo-meteorologo da fantascienza (una Ballata dell’escursione termica – 10 + 33). E c’è, soprattutto, Il Vero Tema. Se solo ora cominciamo a leggere Conglomerati, ancora stentando a familiarizzarci coi modi della «trilogia dell’oltremondo», come l’ha definita Stefano Dal Bianco, che riprende e insieme scandalosa rovescia luoghi e significati della «pseudo-trilogia» d’antan, perfettamente segreta e incòndita risulta la rarissima plaquette terminale che le tiene dietro, riportata per intero nel corpus di Erratici.
In un numero in parte dedicato a Zanzotto, il suo centesimo, dalla rivista «Studi Novecenteschi» (anche le nostre riviste fanno a gara a celebrarlo) una sua interprete storica, Niva Lorenzini, dà una lettura leopardiana di questi versi conclusivi. E non c’è dubbio che il Leopardi «arcano e stupendo», quello delle pagine più vertiginosamente materialistiche delle Operette morali e della Ginestra, sempre più vicino si sia fatto, col tempo, all’immaginario di Zanzotto. Confrontarsi col «volto mezzo tra bello e terribile» della morte – testa di Medusa che si accampa, qui, come Beltà postrema – vuol dire, dopo averla tante volte evocata miticamente o fobicamente (a partire dall’incredibile voce sepolta di Fuisse, in Vocativo), contemplarla finalmente “dal vivo”, se ci si passa il paradosso: davvero facie ad faciem (A faccia a faccia, proprio, paolinamente s’intitola il primo saggio da Zanzotto dedicato a Leopardi, nel ’63).
Memorabile vi suona il conio, nello strepitoso «stile tardo» del vecchio leone, di una dimensione sconosciuta: quella dell’«ininfinito». Se l’«idillio» del 1819 è in realtà – ha dimostrato Gilberto Lonardi – una meditazione sulla morte, condotta sul ciglio di un ultimo precipizio nell’indistinto; e se Leopardi sceglie di non farlo, quel salto estremo (a differenza dell’avatar Saffo, nell’Ultimo canto di qualche anno dopo); Zanzotto sa che le «lievissime rotelle del 2000», sulle quali pattina sempre più precipitoso nella sua “seconda trilogia”, lo hanno condotto a un passo che non può più essere rinviato. Ma se infinito è mot-valise, immagine dialettica che comprende e sussume, negandolo, il finito (la topica Siepe) – come fa il perturbante Unheimlich freudiano con le penombre di ogni nostra casa, e con quelle della Casa dell’Essere –, ininfinito è doppia negazione: enigma-lampo che, negandola, afferma la vita nella morte. Dietro la Siepe, sì. Cioè, sempre, Dietro il paesaggio.
Proprio il tentativo-hybris di andare dietro Zanzotto, cioè chi dal principio del suo percorso è voluto andare Dietro il paesaggio, è stata la sfida del libro su di lui che ho iniziato a scrivere nel 2006 – ma che solo oggi, complice la coazione celebrativa, giunge a compimento (?). Ricordo bene l’impressione che mi fece, più di vent’anni fa, la recensione di Massimo Raffaeli al «Meridiano» di Zanzotto uscita su «Alias», il supplemento del «manifesto» al quale cominciavo allora a collaborare. Vi risuonava una protesta che, in termini ben più confusi, per tempo avevo cominciato a formulare per mio conto: era venuto il tempo, scriveva Raffaeli, di smettere di descrivere i modi, del resto polimorfi sino a frastornare il più apparecchiato dei critici stilistici o dei semiologi, di quello che sino ad allora era stato solo e sempre «il Signore dei Significanti»; e di cominciare a leggere, invece, le «asprezze della “realtà rugosa” che la maggioranza degli interpreti considera invece alla stregua di un ingombro». Nella propria introduzione al «Meridiano» lo affermava con decisione, in effetti, Fernando Bandini. Il quale parlava del «predominio del significante», in un certo Zanzotto, come di «un episodio»: in contrasto con «parti poetiche dominate dal significato, e comunque di una incessante, anche se latente, ricerca del significato».
Come quella a tal riguardo ancora più problematica di Amelia Rosselli, la poesia di Zanzotto è dominata – dall’inizio alla fine, e anche nei momenti che più sembrano flirtare col «puro non-senso» (come lo chiama a proposito del poemetto “lunare” del ’69, Gli Sguardi i Fatti e Senhal), o piuttosto la traumatica «ustione del nonsenso» (come definisce quella cui risponde la «poesia visiva» di Microfilm, in Pasque) – con un’inesauribile tensione a voler dire. Il rapporto fra significanti e significati, in questa poesia è sempre in tensione: mai risolto in una pacifica quanto illusoria comunicazione diretta, ma neppure mai annullato in una altrettanto semplificatoria, a ben vedere, abolizione del significato. La mia lunga fedeltà inizia non a caso, nel 1998, con l’inclusione di una delle poesie di Zanzotto che più chiaramente e tormentosamente vogliono dire – Rivolgersi agli ossari, nel Galateo in Bosco – alla fine del mio primo libro: un’antologia dei poeti italiani della, e anzi «nella», Grande Guerra.
Ho conosciuto tardi Stefano Agosti: che tanto avevo ammirato e altrettanto, nel mio foro interiore, avevo contestato. Solo frequentandolo di persona, però, ho potuto capire quanto la sua «lunga complicità» con Zanzotto si fondasse su una mutua seduzione, un reciproco divertimento, un gioco a rimpiattino dell’uno con l’altro. Se si leggono gli ultimi interventi fra quelli raccolti nel 2015 nel volume intitolato Una lunga complicità, si capisce come lui stesso – leggendo lo Zanzotto degli anni Novanta e oltre – avesse corretto la mira: le sue ultime pagine sono fra le più sottili e preziose di un libro che, comunque lo si giudichi, è un monumento della critica italiana del Novecento. Ma non c’è dubbio che sia stata la sua lettura di testi come La Beltà, Gli Sguardi e Pasque la prima responsabile del mito, che tanto era stato d’intralcio e tuttora continua a esserlo, del «Signore dei Significanti». Il suo era il Lacan degli Écrits che, secondo Agosti, certifica «l’impossibilità del mondo di offrirsi altrimenti che come verbalizzazione». Ma Lacan più avanti aveva detto cose diverse; alla fine del suo percorso, anzi, predicava pressappoco il contrario.
Certo Zanzotto era molto in sintonia, allora, con questa prospettiva. Probabilmente avrebbe consentito con la lettura del titolo La Beltà come allusiva al francese béance («il vuoto in cui si risolve la realtà», secondo Agosti; ma béance può voler dire anche, e quasi al contrario, «apertura, lacerazione»), che in seguito invece spiegherà in modo diverso. Da sempre ho inchiodata nella testa, fra le mille citazioni più o meno esplicite dal Nume Persecutore, questa che appunto nella Beltà splende oscura in Sì, ancora la neve: «Hölderlin: “siamo un segno senza significato”». A quell’altezza Zanzotto parrebbe coonestare un’interpretazione nichilista, diciamo, della tormentosa variante di Mnemosyne: «Ein Zeichen sind wir, deutungslos». Un verso che, nella storia della critica e nella fattispecie delle diverse traduzioni italiane (e francesi) accessibili a Zanzotto propende ora per senza significato, ora per senza interpretazione. Nel primo caso la poesia, chi la scrive e chi la legge, sono «una storia che uno scemo la racconta, che è piena di rumore, di furore, e che però poi significa… niente» (così Edoardo Sanguineti ha tradotto una volta la battuta ominosa del Macbeth); nel secondo invece la poesia, chi la scrive e chi la legge, un significato ce l’hanno: e sta a noi spiegarlo.
In un’occasione importante (la conferenza “elettrica” dell’80, che citavo prima) Zanzotto ha distinto la propria «oscurità» da quella di chi sottragga artificialmente il referente a fini “esoterici”, o di semplice reticenza (come gli Ermetici di Toscana ai quali, agli esordi, sin troppo era vicino): la sua è «oscurità da eccesso, non da difetto». Anche Montale aveva spiegato la sua «apparente oscurità» (nel celebre pezzo sui Due sciacalli al guinzaglio, incluso in Sulla poesia) con «una estrema concentrazione» e «una confidenza forse eccessiva nella materia trattata» (mio il corsivo); ma in una poesia tarda di Conglomerati («Tante, tante odi, scritti, emblemi») aggiungerà Zanzotto che il suo, più precisamente, è un «eccesso di convergenza»: cioè un sovraffollarsi di rinvii sovrapposti (le famose sovrimpressioni), ciascuno dei quali fa capo a una filiera concettuale, oltre che stilistica, proveniente da luoghi diversissimi.
Fra le carte della Beltà è rimasto un appunto prezioso (lo ha riportato Sara Bubola): «anche nel trasmettere il più bello / chiaro e semplice dei messaggi emozionali c’è sempre un ATTO DI FEDE nella ricezione: importa forse più questo che quella quando si tratta di poesia». La fede di Zanzotto, così condivisibile al di là di tutte le possibili religiosità, è rivolta dunque a una trascendenza materiale: quella della ricezione. Il vero Dio a venire è il senso prefigurato in quello iato insopprimibile che separa, in ogni atto di parola, chi dice da chi ascolta: «l’inesprimibile nulla» che nell’Allegria Ungaretti scopre «tra un fiore colto e l’altro donato». In questo senso, diceva Celan, «non c’è differenza fra una poesia e una stretta di mano»: entrambe hanno il potere di colmare quel vuoto (e sì, aveva ragione Benjamin, è «l’attenzione» la «preghiera naturale dell’anima»: chi legge poesia lo sa).
Si giunge così alla terminale Conglomerati, dove si legge quella che è una vera e propria palinodia di Sì, ancora la neve: «siamo / appunto qualcosa da decifrare» (la sottolineatura d’autore vuole evidenziare il rinvio al «Wir» di Hölderlin; mentre la traduzione per la quale opta infine Zanzotto ricorda quella a suo tempo data da Gianfranco Contini: «Un segno noi siamo, indecifrato»).
Poesia? è il titolo, geniale, di un saggio pubblicato da Zanzotto, all’inizio del ’76, sul «verri». Una sua possibile valenza è questa:
può segnare per lo meno uno stato di allarme, evidenziare una faglia che ci riguarda e che noi non vediamo; può esprimere un sottinteso di minaccia: o forse di speranza? Si può rovesciare il segno; si è costretti, nel momento stesso in cui ci si lascia andare allo scrivere, ad ammettere che tale gesto possa avere un significato. Ma ciò che viene richiesto non è la ricezione di una comunicazione immediata: piuttosto un contagio, se possibile. Non da colui che scrive viene richiesto tale contagio, tale profondo rischio, ma tramite colui che scrive: il quale – si noti bene – non solo non si ritiene un privilegiato, o migliore di altri, o uno che abbia doti particolari, ma piuttosto uno che ha un particolare rapporto con un modo dell’emarginazione. Non c’è poesia che non abbia a che fare con l’emarginazione e, appunto quando vi è coinvolta in pieno, questa forza da cui viene la poesia tocca il «margine», il limite, e forse va al di là di tutto quello che si poteva sospettare o prevedere all’inizio.
L’emarginazione, allora, non è (solo) un connotato sociologico della poesia del nostro tempo; è un suo aspetto strutturale e necessario. È quanto può renderla, secondo Zanzotto, un segnale di allarme (il «segnalatore d’incendio» di cui parlava Benjamin o il canarino che, raccontava Gore Vidal, portavano con sé i minatori nelle viscere della terra perché pre-avvertissero l’odore del gas venefico, immagine di recente applicata da Georges Didi-Huberman a Pasolini: mentre scrive queste parole con ogni probabilità Zanzotto non sa ancora della sua sorte tragica, consumatasi alla fine del ’75, altrimenti l’avrebbe ricordata; ricorda però quella di Celan, suicida nel ’70).
Dunque quanto più la poesia ci appare superflua, ineffettuale, marginale, tanto più la scopriremo misteriosamente necessaria. Più è eccentrica più è segretamente centrale. Sarà il caso di tenere a mente questo avvertimento di Zanzotto, quando saremo tentati di strumentalizzare le sue parole riguardo ai temi più “centrali” della nostra attualità. Per esempio quando discutiamo – come è sempre più sacrosanto fare – di ecologia. Non diversamente da quanto deliberò di fare a suo tempo Primo Levi, «usando» il proprio “caso” e la sua opera «come strumento» contro il pericolo di un nuovo fascismo (così, esplicita, un’intervista del ’73), è stato Zanzotto per primo a strumentalizzarsi, banalizzarsi e ridursi a slogan: quando per esempio ha coniato l’aforisma «prima c’erano i campi di sterminio, ora c’è lo sterminio dei campi ed è la stessa logica», che è oggi il suo ‘testo’ di gran lunga più citato sul web (c’è da chiedersi quanti, fra quelli che lo ripetono, conoscano la sua problematica matrice heideggeriana). Sarà bene ricordare sempre quest’altro suo caveat (pronunciato nell’80): «Il poeta suscita, piuttosto, dubbi salutari, segnala terreni scivolosi. Alcuni pensano che la poesia possa essere una forma di intervento politico; io non lo credo, almeno nella forma diretta, immediata. Nei tempi lunghi, sì».
Nella forma diretta, immediata “interveniva” Zanzotto, certo, come intellettuale e appunto cittadino. Il suo pensiero, e l’intonazione sempre inimitabile della sua voce, sono in tal senso efficacissimi: nelle interviste e negli interventi, in particolare, dei suoi ultimi anni. La sua poesia, invece e per fortuna, è del tutto irriducibile a quest’uso diretto e “frontale”, come piace dire oggi: perché, se la si legge davvero, proprio sui temi della “natura”, dell’“ambiente” e del “paesaggio” (tre nozioni assai diverse, peraltro, l’una dall’altra) si scopre che non c’è poesia, forse, più della sua scivolosa e piena di dubbi. Nei tempi lunghi anche la sua poesia getta un allarme: non con la comunicazione immediata – rispetto alla quale si pone agli antipodi – bensì, magari, col contagio. Cioè con la trasmissione, a chi venga dopo di lui, del destino di quel particolare individuo-specie che la poesia s’è trovato a pronunciare.
La poesia dell’ultimo Zanzotto, quello di Sovrimpressioni e Conglomerati, certo mette a tema le questioni che più stavano a cuore all’uomo Zanzotto. Eppure quando questa poesia descrive la fine del mondo, come a suo tempo aveva fatto Ernesto de Martino e negli stessi anni faceva Jean-Luc Nancy, è non solo e non tanto il mondo materiale, naturale o ambientale appunto, a venire allarmato: è in primo luogo la fine del mondo interiore e sociale, antropologico insomma, a trovarsi così segnata a dito. E in questo si avverte una consonanza, a posteriori, con l’ultimo Pasolini (a lui pare rispondere l’epigramma che ha dato il titolo al libro-intervista con Marzio Breda: «in questo progresso scorsoio / non so se vengo ingoiato / o se ingoio»). Quello venuto meno è un rapporto equilibrato dell’uomo non solo con l’elemento non umano, ma in primo luogo con sé stesso.
Ha detto bene Robert Harrison: il paesaggio di Zanzotto, come nell’immagine fondante di Baudelaire, è «una foresta di fenomeni di cui il linguaggio e la storia sono parte integrante». È l’intreccio inesauribile dell’elemento umano con quello che Zanzotto chiama «aumano», «la foresta […] che l’epoca attuale sta distruggendo». È tanto fatuo e inutile vagheggiare – rivolgendosi da esseri umani ad altri esseri umani – una ri-natura finalmente monda dell’uomo brutto sporco e cattivo, di quanto sia criminale e inutile rapinare devastare crocifiggere un ambiente del quale questo essere umano, piaccia o meno, fa parte integrante.
Un episodio di Pasque mi pare, fra tutti, il più rivelatorio: quella del «Centro di Lettura» in Misteri della pedagogia. Spiega la nota che «questi centri sono organizzati a cura del Ministero della Pubblica Istruzione per integrare le attività scolastiche delle elementari e sono aperti a tutti». A scuola Zanzotto ha passato una vita e la pedagogia (nella quale iscriveva, per esempio, tutta l’esperienza di Pasolini), non solo in questo libro, è un suo grande tema. Ma quelli celebrati in questo luogo, stavolta, sono i suoi misteri. I quali hanno a che fare col problema fondamentale della comprensione, o forse della stessa comprensibilità, della poesia («le poesie di suo nipote si capiscono poco», protesta «la signorina Morchet»: «oh lui, quello sì, Dante!»).
È proprio lui, l’Eccentrico per antonomasia, il Centro di Lettura del nostro tempo: come Dante lo fu del suo. Poeti davvero “continenti” entrambi, in primo luogo per capienza, hanno raccolto nel rispettivo «Vas d’elezïone» la quantità più vasta e polimorfa possibile di materia concettuale e linguistica. Ed entrambi, con la generosità più folle che si possa concepire (il maestro siglando tale funzione nel suo stesso nome), ce l’hanno restituita: non prima di imprimervi, indelebile, il proprio sigillo.
Entrambi poi hanno mostrato le facoltà della poesia in generale. Cioè il suo luogo. Che è davvero e nient’altro che la Terra. Il luogo della poesia nel mondo è infatti, molto semplicemente, il luogo dell’uomo. Un filosofo del nostro tempo, Peter Sloterdijk, ha sostenuto che forse dovremmo smetterla di chiederci cosa siamo, per interrogarci – più concretamente, se non più modestamente – dove siamo. Cosicché, magari, ci metteremmo finalmente al posto nostro. Che non può essere in alcun modo fuori del mondo: non ci è consentito togliere il disturbo, infatti, più di quanto potremmo sopravvivere una volta che il mondo lo avremo ucciso.
Dunque non serve la Unterthänigkeit di Scardanelli. Non è il caso di affettare soggezione, umiltà, né deferenza (queste le ipotesi di traduzione zanzottiane della formula di saluto del folle avatar di Hölderlin). A servire semmai, se possibile, è di nuovo un colloquio: il nostro accordo col mondo, che è quello della poesia col mondo, ma anche il nostro nei confronti della poesia – e del suo «dono a doppio risvolto». Questa lingua, malgrado-tutto viva, è la lingua della vita in un mondo malvivo, ancora, che ogni giorno muore: come quella che ancora e malgrado-tutto si muove nella sepoltura di Fuisse. È poco, si dirà; quasi niente, forse. E forse tutto.
Andrea Cortellessa è nato a Roma nel 1968. Insegna Letteratura italiana contemporanea all’Università di Roma Tre. Nel 2018 ha tenuto la «cattedra De Sanctis» al Politecnico di Zurigo. Ha pubblicato saggi e antologie, curato testi di autori italiani del Novecento e contemporanei (fra i quali Giorgio de Chirico, Giulio Paolini e Claudio Parmiggiani), realizzato trasmissioni radiofoniche e televisive, spettacoli teatrali e musicali. I suoi ultimi libri sono Monsieur Zero. 26 lettere su Manzoni, quello vero (Italo Svevo, 2018), la nuova edizione ampliata di Le notti chiare erano tutte un’alba. Antologia di poeti italiani nella Prima guerra mondiale (Bompiani, 2018), Volevamo la Luna (Mattioli 1885, 2019), Il libro è altrove. 26 piccole monografie su Giorgio Manganelli (Luca Sossella, 2020), con Silvia De Laude Vedere, Pasolini («La Rivista di Engramma» 181, 2021) e Andrea Zanzotto. Il canto nella terra (Laterza, 2021). Di Zanzotto ha curato Premesse all’abitazione e altre prospezioni («Pietre d’angolo» Aragno, 2021); insieme a Chiara Bertola ha curato la mostra Un’evidenza fantascientifica. Luigi Ghirri, Andrea Zanzotto, Giuseppe Caccavale (Fondazione Querini Stampalia, Venezia, maggio-ottobre 2021). È nella redazione del «verri» e tra i fondatori di «Antinomie. Scritture e immagini»; collabora ad «Alias» del «manifesto», alla «Domenica» del «Sole 24 ore», «Tuttolibri» della «Stampa» e altre testate. Ph. Dino Ignani