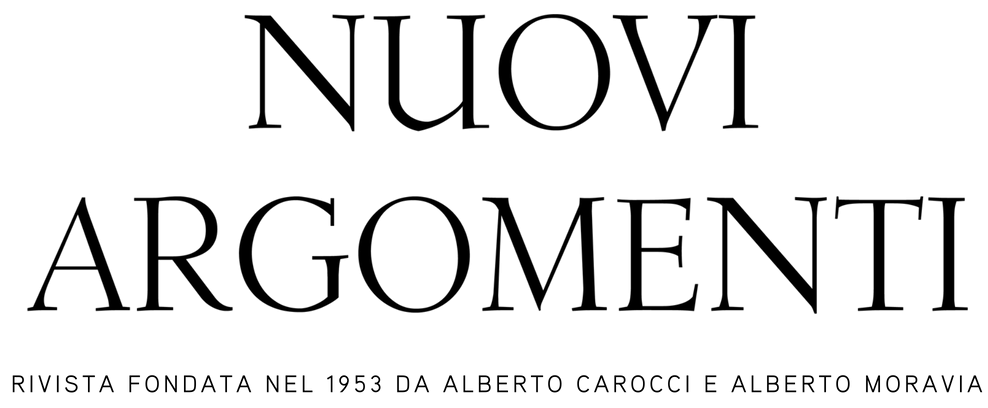Benché la vita di queste persone che escono dalle auto parcheggiate fra le strisce degli spazi condominiali gli sembri incomprensibile ora che sta uscendo dall’infanzia, sa bene che il luogo e il tempo in cui è nato lo destinano a diventare come loro, una versione migliorata di loro. Per non posteggiare la propria auto davanti a un palazzo come questo, per non perseguire avanzamenti di carriera fra i quadri intermedi di una gerarchia aziendale, dovrà attraversare dei conflitti invisibili e feroci con gli esseri che oggi formano il suo mondo, con le persone che ama. Appoggiando la fronte al legno degli infissi, studiando la cura insensata con cui i vicini incerano le macchine prima di coprirle con i teli, crede di sentire il peso di quello che sta per accadere. Ha tredici anni; sa che la vita è solo sua; vede solo se stesso.
Non vede invece che è stato il lavoro di queste persone, la fatica che hanno fatto per uscire dai poderi mezzadrili e raggiungere una periferia residenziale, a consegnargli il potere di essere diverso, di coltivare altre mete e altre paure. Nella crudeltà della prima adolescenza può capire solo poche cose degli individui dispersi lungo il piazzale. Vivono per sé; accettano la sfera di relativa sicurezza che questa periferia sembra custodire; non credono in nulla che oltrepassi i destini familiari. Fra pochi mesi forze ignobili gli faranno desiderare di trascendere ciò che vede, di vivere vite più prestigiose o più morali. Cercherà di procurarsi un’altra biografia, proverà passioni per conflitti lontani, soffrirà per ingiustizie che non gli appartengono, finché un giorno, con vergogna e ostinazione, darà a questo desiderio la forma più banale, mettendo su carta il proprio io ingigantito per sperare di sopravvivere più a lungo.
Vent’anni dopo, mentre le stesse strisce ridisegnate brillano sotto gli alberi di Natale e i suoi coetanei ritornano nelle case dove sono cresciuti portando passeggini, crede di capire meglio. Oggi pensa che nulla possa trascendere la nostra sorte singolare, la vita infissa nei lineamenti che la luce bianca sembra cancellare quando tocchiamo i pupazzi appesi sopra i cruscotti o attraversiamo l’aria fra le macchine vuote, seguendo la traiettoria che forze invisibili hanno preparato per noi, l’ellittica di una deriva personale. Oggi crede che non esistano valori ma solo vite, modi di interpretare un destino che rimane solo privato, per tutti. Loro lo sanno da tempo: tutta la loro identità è modellata su questa certezza. Sanno che quanto accade in questo recinto è tutto quello che realisticamente esiste qui e ora, ai margini di una città europea di medie dimensioni; e dentro questo spazio ricavano le loro minime sacche di valore, rimuovendo ciò che li trascende e che un giorno si mostrerà all’improvviso in un prepensionamento, in un divorzio, in un’analisi medica, in un incidente stradale.
Miliardi di uomini che hanno vissuto o vivono in altri tempi o in altri luoghi hanno desiderato e desiderano la vita che la classe media occidentale ha conosciuto nella seconda metà del ventesimo secolo, dopo millenni di violenza e povertà. E se è vero che la sicurezza di queste case nasce sul risvolto di rapporti di forza che infliggono violenza e povertà a miliardi di esseri lontani per i quali sarebbe difficile, sarebbe irrealistico provare qualcosa, è altrettanto vero che pochissimi degli individui che occupano questo luogo e questa epoca ne sono consapevoli o hanno colpe. Oggi capisce la dignità, la complessità delle persone che esistono per sé, senza bisogno di trascendenze, risarcimenti, giustificazioni. Il parcheggio si è coperto di automobili; nelle borse giacciono i regali di Natale. E’ come loro, e non ha nulla da opporre se non il proprio sguardo, la rabbia senza oggetto con cui osserva i volti dei nuovi individui, le sagome delle nuove costruzioni sotto il solito cielo.
***
1. Il file dice che Parcheggio è stato scritto fra il novembre del 2004 e il settembre del 2005. A un certo punto si intitolava I destini privati, come anche il libro di cui il testo fa parte; poi il testo è tornato a chiamarsi Parcheggio e il libro si è chiamato I mondi, saggiamente. Nel 2011 ho scritto una poesia in prosa intitolata I destini generali (è una citazione da Fortini); nel 2015 ho pubblicato un libro che non ha alcun rapporto con la poesia in prosa ma che porta lo stesso titolo. Le ossessioni durano a lungo.
2. Nella prima parte qualcuno parla di sé in terza persona e racconta un frammento della propria adolescenza. Non si tratta di un episodio in senso stretto perché non c’è azione o aneddoto; è piuttosto un processo di pensiero che la scrittura rende manifesto. Non lo si dice esplicitamente ma siamo nel 1980, cioè nell’ultimo anno di una guerra civile (largamente simbolica) che ha attraversato l’Italia dal novembre del 1967, quando le prime occupazioni universitarie inaugurano il Sessantotto, all’autunno del 1980, quando la Marcia dei Quarantamila e la nascita di Canale 5 inaugurano l’epoca nella quale, sotto certi aspetti, continuiamo a vivere. Benché inespresso, questo sfondo storico è il presupposto di Parcheggio. Il tredicenne (che ha l’età delle prime occupazioni, essendo nato nel novembre del 1967) cresce in una periferia residenziale piccoloborghese ai margini di una media città europea. Nel suo quartiere la storia non esiste; esistono solo destini privati, persone che vivono per sé e per la propria famiglia, senza trascendenze, sensi di colpa, giustificazioni. In un certo senso, il vero vincitore della guerra civile (largamente simbolica) che precede l’attimo fissato dal testo è la classe media che sta oltre la finestra. Il ragazzo non sa nulla di tutto questo. Sa però una cosa importante: che non vuole essere così.
Vent’anni dopo, nel 2000, la stessa persona rivede lo stesso paesaggio e crede di capire alcune cose che nel 1980 erano presentite e implicite: che è stato anche il lavoro e la fatica di individui simili a portare questa periferia residenziale, questa città e l’Europa occidentale intera fuori dall’Ancien Régime contadino, creando il benessere che serve per diventare qualcosa di diverso, per contestare; che questo benessere presuppone rapporti di forza ingiusti e orribili, ma che i singoli individui, pur beneficiando dell’ingiustizia, non hanno colpe soggettive; che qualunque cosa il tredicenne faccia per non essere così, alla fine anche lui diventerà una persona privata dedita a scopi puramente privati, come tutti. La realtà è fatta di vite singolari circondate da potenze incontrollabili: l’unica forza che si è illusa di modificare questo stato di cose, la politica intesa come costruzione di una forma di vita utopica, nel 2000 non esiste più e forse non è mai esistita veramente. Ciò che resta è la rabbia senza oggetto con cui il tredicenne diventato trentatreenne osserva le case e le persone della sua media periferia occidentale. E’ come loro, ma non vuole essere così. Alcuni anni dopo, il saggio intitolato I destini generali si chiude con un sentimento simile.
3. I mondi è un libro di poesie liriche sovraesposte. Discende da una tradizione di lirica tragica tipicamente italiana, ma la voce e il personaggio-che-dice-io finiscono spesso per dire più di quello che di solito dicono i soggetti poetici convenzionali. Condivido il fastidio che una parte degli autori miei coetanei prova per i limiti della lirica moderna, ma reagisco facendo un’altra cosa. Se la poesia che negli ultimi anni si è autoproclamata ‘di ricerca’ rifiuta l’assertività, i testi che ho cercato di scrivere sono iperassertivi; o, per dirlo con un’altra metafora, se quel tipo di poesia è sottoesposto, la mia scrittura è sovraesposta: nasce dalla stessa impazienza ma prende una via di fuga diversa; non va verso il cut-up, la virgolettatura e l’ironia, ma verso la riflessione, la saggistica e la filosofia. Ho provato a dilatare i limiti che la lirica moderna impone all’intelligenza dell’io per rendere conto del carattere letteralmente superficiale della nostra vita. Le forze che ci muovono sfuggono all’esperienza vissuta che, tranne in alcuni rari momenti epifanici, è ripetizione, aneddotica o sogno-a-occhi-aperti; l’essenziale avviene fuori scena e si lascia cogliere solo col pensiero. Mi interessa scrivere l’equivalente in poesia di un romanzo-saggio. Era questo lo scopo inconsapevole dei Mondi; lo è anche del libro che dovrebbe uscire fra qualche mese. Si intitola La pura superficie.
Immagine: Foto di Guido Mazzoni.
La rubrica “I poeti leggono se stessi” ha già ospitato:
Mario Benedetti, Milo De Angelis, Franco Buffoni, Umberto Fiori, Patrizia Valduga, Valerio Magrelli, Fabio Pusterla, Gian Mario Villalta, Andrea Inglese, Maria Grazia Calandrone, Gabriele Frasca, Stefano Dal Bianco, Carlo Bordini, Italo Testa.
Maria Borio è nata nel 1985 a Perugia. È dottore di ricerca in letteratura italiana contemporanea. Ha pubblicato le raccolte Vite unite ("XII Quaderno italiano di poesia contemporanea", Marcos y Marcos, 2015), L’altro limite (Pordenonelegge-Lietocolle, Pordenone-Faloppio, 2017) e Trasparenza (Interlinea, 2019). Ha scritto le monografie Satura. Da Montale alla lirica contemporanea (Serra, 2013) e Poetiche e individui. La poesia italiana dal 1970 al 2000 (Marsilio, 2018).