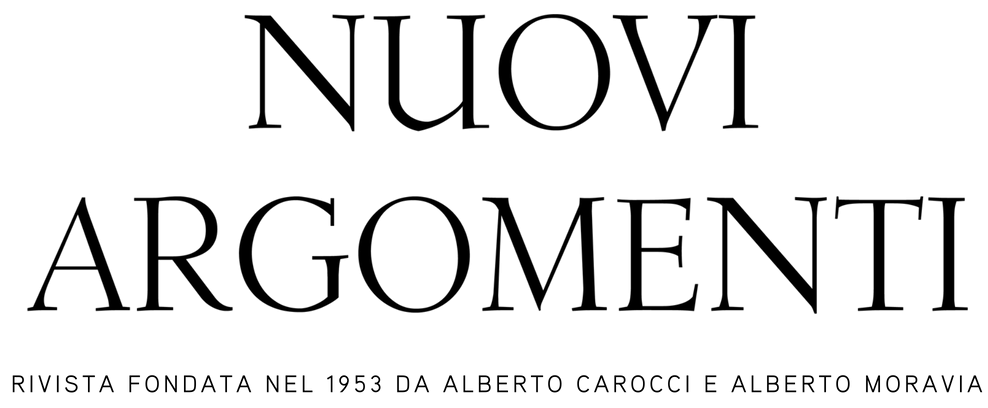Amelia Rosselli, poeta tra i più importanti del secondo ‘900 italiano, è celebrata con l’uscita di un Meridiano che raccoglie tutta la sua opera poetica, a cura di Stefano Giovannuzzi e Emmanuela Tandello. Per ricordare Amelia proponiamo un testo di Biancamaria Frabotta, che racconta la poesia e la persona di Amelia in un ritratto delicato e vivo (da Biancamaria Frabotta, Quartetto per masse e voce sola, Roma, Donzelli, 2009).
Davanti alla bara di Amelia Rosselli
Roma, Casa della cultura, 16 febbraio 1996
Il fuoco riscalda.
A leggere la poesia di Amelia, la temperatura del nostro corpo si altera un po’. Talvolta si abbassa, più spesso si innalza. E non diversi effetti scaturivano dall’ascolto, dalla sua viva voce di straordinaria lettrice. Lei ardeva per suo conto. Era con te, qualche volta contro di te, ma mai lontano da te. Ti metteva a parte dei suoi segreti, ma non della sua intimità. Amelia era furiosamente, strenuamente pudica.
Il fuoco disinfetta.
E cauterizza le piaghe. Lei ci comunicava i suoi incubi, i mali che la torturavano e insieme i suoi paradisi, la gioia del tempo, la passione politica che sempre l’ha agitata, e tutto, il male come il bene supremo, acquistava un solo tono, il suo. La sua voce era un basso profondo, una musica che faceva lievitare la fondamentale tra le parole rese singole e compenetrate l’una nelle altre. Un campo di spighe uniformemente mosse dal vento e pure così variate, inafferrabili a un solo colpo d’occhio. Mai un grido nella sua recitazione, eppure quanti soprassalti nelle sue poesie! Per lei hanno nominato Campana, Rimbaud. Ma nulle le era più estraneo dello sregolamento dei sensi, dello sfrenato abbandonarsi all’altra voce che urge quando la ragione tace. In lei parlano entrambe, la ragione della mente e quella che piove dall’Altrove, in una educata, civilissima convivenza che non dimenticheremo mai.
Il fuoco illumina.
La poesia di Amelia Rosselli è oscura eppure chiarissima. Certo, bisogna abituarvisi, come quando si entra da fuori in una stanza buia. All’inizio avanziamo cautamente, abbiamo paura di farci male, urtiamo negli spigoli, imprechiamo. Ma poi diventiamo come i gatti che vedono anche nelle tenebre. Come loro impariamo a sviluppare sensi normalmente inerti, latenti. La sua forma di conoscenza è la Pietà, un grande canzoniere d’amore, senza tracce di narcisismo.
Il fuoco non è mai fermo.
Non può appagarsi dell’immobilità. Tende a salire, guizza, si libera dalle sue stesse forme. In tanti avremmo voluto imitarla, la sua poesia, anche solo per un omaggio, un affannoso tributo d’amore. Ma era come voler ricalcare il percorso nell’aria delle lingue di fuoco. Chi può arrestarle, catturarle? Si può solo contemplarle, lasciarsene ipnotizzare in silenzio.
Il fuoco scotta.
Con la Storia che le ha marchiato i suoi segni sul corpo, prima ancora che nella mente. Dietro la sua poesia-amore avanzano la persecuzione politica, l’assassinio, la tragedia del conflitto più violento di un secolo ormai alla fine. La sua lingua, dissennatamente poliglotta, ne è stata disarticolata, ma quanto dilatata! Con Amelia se ne va l’ultima vittima di un secolo divoratore dei suoi poeti. Un’epoca che ostenta indifferenza verso la poesia e che continua a nutrirsene avidamente, cannibalisticamente. Marina Cvetaeva diceva che con la poesia bisogna comportarsi come con le creature amate. Si sta con loro finché non sono loro a lasciarci. E chi resta solo con il dolore e il lutto non dimenticherà la gioia della dedizione fino al sacrificio finale.
Immagine: Dino Ignani, Ritratto fotografico di Amelia Rosselli.
Maria Borio è nata nel 1985 a Perugia. È dottore di ricerca in letteratura italiana contemporanea. Ha pubblicato le raccolte Vite unite ("XII Quaderno italiano di poesia contemporanea", Marcos y Marcos, 2015), L’altro limite (Pordenonelegge-Lietocolle, Pordenone-Faloppio, 2017) e Trasparenza (Interlinea, 2019). Ha scritto le monografie Satura. Da Montale alla lirica contemporanea (Serra, 2013) e Poetiche e individui. La poesia italiana dal 1970 al 2000 (Marsilio, 2018).