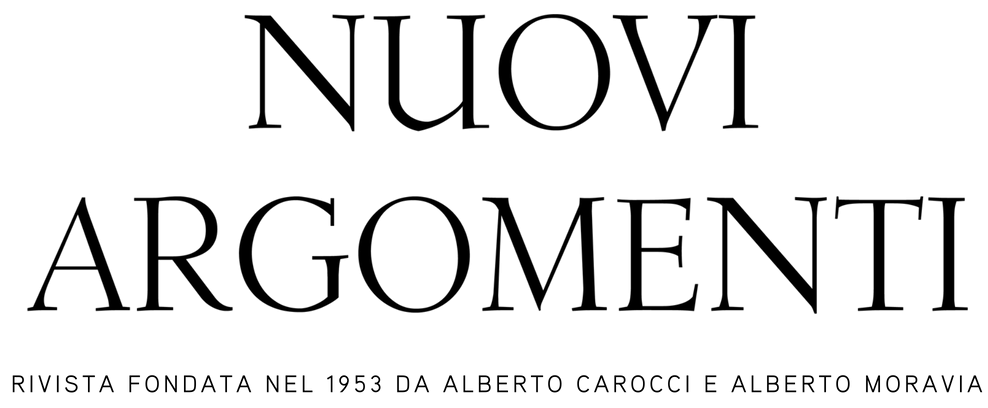In anteprima da “Ceneri germogli ceneri”, che raccoglie poesie di Eugenio De Signoribus dal 1976 al 2024, appena uscito per Lo Specchio Mondadori, pubblichiamo alcuni testi e due estratti dell’introduzione di Stefano Verdino.
(racconto)
l’uomo era l’albero del suo battello
venuto incontro alla secca e arenato
chiuso se ne stava nel suo mantello
senza gesti e alti richiami– vorrei farmi amare da voi
dichiarò appena udibile rivolto verso terra
per mezzo cerchio girai lo sguardo
da lui a quella parte:
lì non c’era nessuno
né dune e rocce che potessero
nascondere qualcuno
– è una svista… o forse una visione…
gli annunciai fuori della pagina
il battello era intanto finito di fianco
così ch’egli ora mi stava di fronte
ma mi era oscura la sua immaginazione
perché potessi sapere se solo mi vedeva…
ancora parlò – la tua voce è plurale
ti anima un piccolo popolo di turbati e innocenti
che da soli arrivano alla tua casa
o da te cercati con te la convivono…
perciò io, errante ormai alla fine
e che oltre più non posso andare,
vorrei almeno farmi amare da voi… –
questa è la fedele pagina
della sua inaspettata presentazione
*
PRIMA DELL’ALFABETO
prima dell’alfabeto
scoprii l’intera lettera,
la segreta, il mistero
del messaggio amoroso,
l’incompiuto corpo
della scritta parola
per il tempo d’attesa
assediai la fortezza
della pagina, il là,
il telaio sospeso…
prima della verità
riconobbi la lettera
poi diventò alfabeto
e l’alfabeto tempo
*
(alienazione)
si può morire ridendo della filatura
di bolla di un’idea che non s’alza
eppure un punto d’aria s’è incarnito
il pensiero imbastito trattenendo…
in questa strozzatura si viaggia
su binari uguali all’apparenza
in carrozze deserte ci sediamo
scudo facendo alla nostra evidenza
noi stessi che non siamo lì ma altrove
e con altri sguardi ci leghiamo
*
(esplosione)
si stacca prima la stanza tra le grida
e quindi il tetto come in propulsione
e quindi le persone, folgorazioni mie,
la strage non si svaga per mie figurazioni…
pianti, carni, vanno dove… sangue
nel crepaccio ribolle, lordo spaccio…
larghe penne corvine non misericordiose
come pale stizzose i ventri fendono
le viscere svelano i loro funghi panciuti
e gli occhi mai pensavano di vedersi così
tra animali che piangono i loro figli
gli uni agli altri invisibili, perduti…
*
(altre voci)
si può ignorare il coro temporaneo
e ascoltare l’inverno sotterraneo
non c’è sonno nei morti continuamente
essi parlano, prendono la nostra voce
l’eco gira sulle vene acquose, fuma,
e la lingua è visitata dalla neve…
*
ma chi più li guarda i trascurati quando
è diverso il peso dei vivi e dei morti?
Quando la lingua s’infalsa
fino a truccare i tabulati?…
Nell’odierno imperio è stabilito che, alla violazione
di un corpo di serie A, subito si risponda
con una vendetta moltiplicata… cioè che sia scorporata,
sotto un corto mantello, un’intera genìa
di serie minore…
La spina su di essa inflitta percorra tutto il corpo
e trasveni il sangue per l’arido campo…
che almeno la morte non sia sola
e si tema la colpa più del lutto
*
eppure è un batticuore continuare nel 2,
un blocco del respiro, uno sbocco di pianto…
A riavvolgersi nel nastro per cercare un’identità
si rischia di non fermarsi più…
Esita pure il fotogramma vitale.
Tutto è alla luce del dopo.
Dunque non ho risposto alla tua chiamata,
non ho bussato alla tua porta?…
Ma tu, mi hai chiamato davvero?…
davvero m’avresti aperto?…
Chiunque può dire: non avevo altra strada
e in quella ho incontrato chi ho potuto!
Ma quanta fraternità dispersa per un passo o un nulla,
quanto nulla ci ha invaso lasciandoci sugli alberi,
spogli e lontani!…
*
DOMANI
domani chissà chi saremo
quale nome in noi consisterà
quando qualcuno a sé ci chiamerà
o da distante ci additerà
come disdetti o estranei
in quelle acque che superano in febbre
i loro letti ed esulando s’incrociano
e si assumono, prima in cromi incandescenti
poi in macchie spondali e via via
in vite correnti a vista e sui fondali,
in quelle acque dei popoli
io, estraneo a te, ti parlerò
(così spero di te)
*
L’AMORE PER LA LINGUA
L’amore per la lingua è il più fedele.
Ha in sé la potenza unica della scoperta della parola.
Il poter dire ciò che si è e ciò che si diventa.
Il confronto, il mondo. L’affronto e il conflitto.
La possibilità di rispondere alle ferite e di curarle.
Il suo nascere antico e sempre nuovo, il suo andare
nel tempo, malgrado esso, fuori di esso.
L’amore per la lingua contiene gli altri amori,
dal loro annuncio alla loro consumazione.
Va oltre. Salva. (Forse salva).
*
(lo sparolaio, invece)
lo sparolaio, l’onnisciente
di ogni tema-parola, sa
da nascita a morte
da dio diavolo a sorte
il sapiente, il verbaiolo
mette sempre il suo tappo
ingurgita spazio e aria
il mai sazio ingorgaiolo
e striglia e scriviglia
senza scampo e nesso
né capisce l’inciampo
il buttafuori di se stesso
*
FORSE NON TI RICONOSCO
forse non ti riconosco, voce,
perché in te non rinasco
ma mi dibatto e commuovo
per il balbettìo dei tuoi occhi
per l’intermittente lumìo
d’un disperato segnale
come da un corpo separato
ma vivo ancora…
e ti ascolto e ti accolgo
e verso te m’attiro
come una vocale
dentro la parola
***
Dall’INTRODUZIONE di Stefano Verdino
Magari ci sarà qualche lettore che come l’amico del Tristano leopardiano, a lettura conclusa, in un ipotetico colloquio con l’autore esordirà “Malinconico al vostro solito”; e si potrebbe replicare con un passaggio di una recente prosa di De Signoribus che avvisa: «ho scelto di non chiudere mai gli occhi», parlando di quella nozione oggi spesso inattuale dell’«impegno» e della necessità che l’osservazione dei «mali umani» sia rielaborata in una lingua «non consumabile immediatamente ma resistente come un ramo più che una foglia». Da oltre mezzo secolo, con artigiana calibratura, questo è stato il lavoro poetico di uno dei maggiori e più appartati poeti italiani a cavallo del millennio, che non ha chiuso gli occhi, né ha avuto timore o esitazione a scrivere quella parola «male» che, al di là di Leopardi e Montale, non è poi molto amata dai poeti, specie se desolatamente pronunciata e non dalla distanza di un pulpito o di un podio. Qui è detta nella inespungibile consapevolezza del proprio coinvolgimento, di un sentimento di inermità e di colpa, che per reazione genera il bisogno di distillare quanto visto ed emotivamente sentito in una lingua atta a rappresentare e trasmutata in nuove parole, le quali abbiano «peso» per non fluire rapidamente nella cloaca della glossolalia in cui si è immersi. E per rispondere ancora all’amico leopardiano con altre parole del nostro poeta, mi pare precisa nella sintesi la risposta a un questionario francese del 2004:
Credo che la poesia non sia solo memoria e malinconia, ma anche sentimento presente…, un mare vasto, emotivo e percettivo, davanti al quale chi nasce testimone si ritrova nudo… il linguaggio poetico è il tessuto che forma e cresce tutt’intorno; è la sua veste.
[…]
Non siamo davanti a una antologia tradizionale, ma a un ripensamento radicale teso a configurare un nuovo percorso di testimonianza e poesia: testi derivati dai volumi sopra citati, e sottoposti a una vasta revisione, spesso una vera riscrittura, sono messi in connessione a testi del tutto inediti, in modo da creare nuove sequenze all’interno di una architettura, sempre mutuata, come già in precedenza da una numerologia, che vede serie di 7 poesie (simbolo di completezza, come la costruzione del mondo) in 14 stazioni, ancora una volta nella figuralità della via crucis. Alla rigida struttura però segue come sintesi, fuori numero, “Summa minima”, che in ogni caso si snoda in 14 testi; portali di apertura, la dedica, e di chiusura, il congedo e la voce fuori campo, completano l’insieme.
Il dato architettonico del testo, già da tempo operante, come sopra detto, qui conosce una particolare funzionalità, perché risemantizza i testi in un nuovo itinerario che vuole metterci sotto gli occhi il «sugo» di una vicenda di poesia. La reiterata figura numerica della via crucis da un lato mi pare avviso di una condizione umana che non fa che ritrovarsi periodicamente nella stessa posizione, ma è pure segno di una vocazione per certi versi metanarrativa, anche se i materiali del suo consistere sono testi lirici. In ogni caso è altresì elemento portante alla configurazione del poema, di cui sono altri segni i citati porta li di apertura e chiusura.
Qualcuno si chiederà della piena necessità di tanta numero logia e macchina; è mia opinione che questa modulare architettura sia come una desiderata maglia di ferro, per incanalare ordinatamente un incandescente materiale linguistico ed espressivo, mercuriale e guizzante con i suoi ben noti caratteri di fotogramma al dettaglio, impastato di realismo, allegoria, sogno, visione e sofferenza. Questa architettura è un altro da sé, una convenzione di antico richiamo, che altri, il lettore, può facilmente intendere, come spesso capitava con i poeti antichi dai numeri bene o male obbligati sia per il totale dei canti del poema epico, sia per l’ideale diario giornaliero dell’anno del “Canzoniere”, sia ovviamente per il «poema sacro», annodato dalla figura del 3 (terzina, canti, cantiche) e dalla perfezione complessiva dei 100 canti.
E a convincere il lettore che questa numerologia non è deliberata stranezza o eccentricità di poeta, ma necessità testuale non resta che andare a illustrare il percorso di queste stazioni. Il portale del racconto (dal fondamentale Istmi e chiuse) ci pone davanti, in un quadro allegorico, un’«inaspettata presentazione» di un quasi naufrago che dice all’alter-ego: «La tua voce è plurale / ti anima un piccolo popolo di turbati e innocenti / che da soli arrivano alla tua casa / o da te cercati con tela convivono…». Sono versi tra i più noti ed emblematici, che illustrano le ragioni di fondo di questa esperienza di poesia, tenacemente offerta come forma di voce verso un sentire che possa essere comune.
[…]