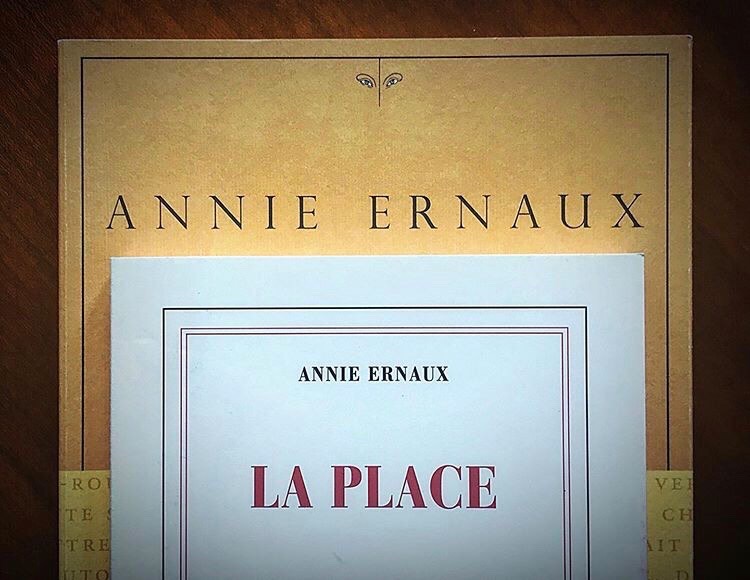Tutto sta, quando (ci) raccontiamo, nelle parole che scegliamo per descrivere altre parole: quelle che sono diventate – per noi che scriviamo – o che devono diventare – per quelli che leggono – cose e fatti concreti, realistici quando non reali, quelle parole che ci hanno definito e che hanno delimitato il mondo in cui abbiamo vissuto. Se c’è dunque una ragione definitiva che rende la letteratura necessaria alla vita quella ragione risiede nella loro comune sostanza, che è fatta di parole. Per anni – molti – mi è capitato di leggere libro dopo libro senza questa acuta consapevolezza e quasi cercando nei romanzi un mondo altro e separato, capace certo di illuminare quello in cui vivevo io ma fondamentalmente avulso da quello, come relegato in una sfera di rarefatta superiorità. Erano due mondi le cui parole parallele non si toccavano mai (o quasi).
Poi un giorno mi è capitato tra le mani – sapete quella sensazione che spinge magneticamente le vostre mani verso un particolare volume? – Il posto di Annie Ernaux, un libro che si apre in esergo con questa citazione di Jean Genet: «Azzardo una spiegazione: scrivere è l’ultima risorsa quando abbiamo tradito»; portarlo a casa e tuffarmici dentro è stato un attimo, quasi un tutt’uno.
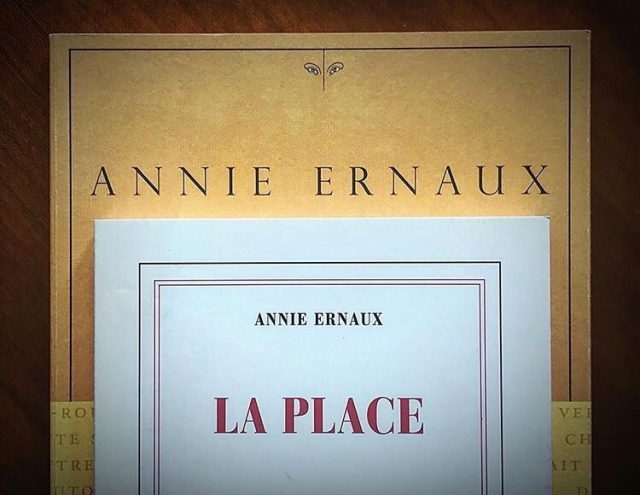
Leggendolo la domanda che mi tormentava era “quale tradimento?”. Sapevo che quell’epigrafe iniziale non era casuale (non lo sono mai) e mi chiedevo quando sarebbe arrivata la risposta da cui in un certo senso sentivo che dipendesse l’intero libro. «Forse scrivo perché [io e mio padre, ndr] non avevamo più niente da dirci», dice Ernaux poco dopo metà libro; eccola la risposta che cercavo! Tutto quel libro, lo capii in quelle due righe, si reggeva sul racconto di un tradimento, e quel tradimento era fatto del silenzio tra un padre e una figlia nato dall’abbandono delle parole comuni (di più: condivise) e dall’uscita da un mondo che non poteva rimanere il proprio per sempre: «È il periodo in cui tutto ciò che mi tocca da vicino mi è estraneo. Sto emigrando lentamente verso un mondo piccoloborghese […]». Insomma, quel libro mi parlava di un distacco, di un allontanamento delle parole e dalle parole che definivano un mondo verso cui si era consumato un tradimento involontario ma necessario. Ma, ecco la sorpresa, il mondo che era stato oggetto di quel tradimento – il mondo del padre – non rimaneva inerte sullo sfondo della narrazione bensì emergeva in superficie attraverso le parole scelte da Ernaux per raccontarlo. Tutto sta, quando raccontiamo, nelle parole che scegliamo per descrivere altre parole; e così per descrivere le parole del padre e del suo mondo Ernaux aveva scelto con cura estrema, maniacale, le proprie, e io mi accorgevo che quell’esattezza colma d’amore era offerta come riscatto del tradimento operato.
«Per riferire di una vita sottomessa alla necessità non ho il diritto di prendere il partito dell’arte, […]. Nessuna poesia del ricordo, nessuna gongolante derisione. La scrittura piatta mi viene naturale, la stessa che utilizzavo un tempo scrivendo ai miei per dare le notizie essenziali». Il romanzo è impossibile, la poesia è impossibile, l’arte è impossibile, è impossibile tutto ciò che somministri al lettore parole alterate e artificiali, nel tentativo di appassionare o commuovere. Solo una scrittura piatta è possibile. Inizialmente a una prima lettura non mi ero fermato a riflettere sulla quantità di significati che questo unico aggettivo conteneva: piatta perché priva di volute stilistiche, certo, ed era la cosa che più saltava all’occhio tra le righe asciutte del testo; ma nella sua piattezza c’era anche la dote essenziale di sapersi adagiare sulle cose raccontate, conformandosi in modo duttile alla loro superficie e ai loro confini rivestendole con esattezza; piatta come lo è l’acqua in stato di quiete, che solo quando è piatta mostra il fondo; piatta ma tagliente come la lama di un coltello, di un bisturi con il quale Eranux – e lo fa in ogni suo libro – incide la pagina per scoprirvi al di sotto la propria carne viva. Non ho mai davvero capito se per lei le parole siano strumenti di ricerca (tagli e fessure, appunto, da cui intravedere la carne della vita) o siano invece esse stesse il risultato di quella ricerca operata dal taglio della lama della memoria, ciò che rimane dopo una sfrondatura impietosa. Ma qualsiasi cosa siano, e forse proprio per questa loro natura bifronte, esse stanno sempre al centro insieme ai fatti che si trascinano dietro.
Attraverso le parole riesumate da una memoria spietata e capace di tornare a distanza di anni con precisione anche al punto più nascosto e più lontano, Il posto si costruisce dunque come il tributo a una vita conclusa, pegno offerto in sacrificio postumo a quell’uomo e a quel mondo (il suo) verso cui si è colpevoli – senza colpa alcuna – di tradimento. In questo senso si tratta di un libro che colma una distanza, che tenta di essere il trait d’union assente per una vita intera, l’ultimo ponte rimasto tra la sponda della propria infanzia e del mondo dei padri e quella della propria vita adulta e del mondo in cui, nonostante tutto, non si smette di essere figli. Ernaux scrive da figlia, consapevole che chi è stato figlio una volta lo sarà per sempre, e scrive del padre dunque; ma scrive anche dell’uomo, nel tentativo di rimetterlo al mondo (così dirà della madre in un altro libro). Questo libro, come ogni suo libro, è un personale tentativo di instaurare un dialogo con una figura rimasta indietro nel tempo e nella vita, il tentativo di dare finalmente voce al silenzio che si è depositato col tempo: «Forse scrivo perché non avevamo più nulla da dirci», come a dire che se si fossero parlati per tutta la vita le parole si sarebbero consumate fino a non poter essere più scritte. O forse no, forse si scrive perché scrivere è l’unico modo di credere che quel tradimento non ci sia stato davvero… Ma una cosa è certa: se quel tradimento si è consumato Ernaux non ce lo nasconde, perché la salvezza, l’unica possibile, non è nell’oblio ma nella memoria e nella memoria c’è anche l’espiazione della comprensione. Al termine del libro Ernaux scrive: «Ho finito di riportare alla luce l’eredità che, quando sono entrata nel mondo borghese e colto, avevo dovuto posare sulla soglia». «Ho finito» (intravedete qui la precisione estrema, apparentemente semplice, che caratterizza la sua scrittura), come si finisce un lavoro. Ereditare è un lavoro, è (in francese) un travail. Ereditare è un travaglio, una fatica. Ed è un nodo ogni suo libro, lungo le cui pagine costantemente si percepisce il movimento che tira i fili e li intreccia finalmente saldandoli col sollievo di chi sa che quei due mondi e quelle due sponde hanno convissuto lì, su quelle pagine che sono il diario di «una memoria umiliata», che è la sola capace di santificare i ricordi (questo il suo comandamento).
Tutto sta, quando (ci) raccontiamo, nelle parole che scegliamo per descrivere altre parole; ma l’ho capito solo leggendo per la prima volta Annie Ernaux. Il posto è stato per me l’incontro con una concezione della letteratura (e della lettura) che non credevo possibile, la rivelazione di cosa significhi davvero raccontarsi spogliandosi di fronte al lettore sconosciuto senza alcun pudore. Non c’è parola nei libri di Ernaux che non significhi esattamente ciò che è; non c’è parola che non si appiattisca sulla superficie (della pagina, della pelle, delle labbra) per farsi tangibile e rivelare sotto di sé la vita che palpita confusa con le sue colpe e le sue vergogne, le sue gioie timide e le sue vertigini emotive. Tutto si deposita sul bianco con ordine e compostezza, senza che la pagina diventi peraltro inerte: per ogni parola tradita c’è in questo libro una parola riscattata.
Non ho trovato nessun urlo e nessun virtuosismo stilistico nelle sue pagine, perché non è da lì che passa la verità; tutto è sussurrato con fermezza perché possa ascoltare solo chi lo vuole. Ho trovato però l’esperienza unica di un incontro con una voce che ha parlato per me inchiodandomi al ricordo del montaliano «Non recidere, forbice, quel volto, / solo nella memoria che si sfolla». Ernaux mi ha insegnato che per non recidere i volti – quello sì che sarebbe il tradimento definitivo – la forbice deve recidere tutte le parole inutili, conservando solo quelle che si credevano perse.
Finisce così, con la consapevolezza che si può ritrovare solo ciò che si è perso tra le sponde di due mondi, e che solo ciò che si è tradito può essere davvero tramandato: a sé stessi e a chiunque legga.
Luca Granato è un bookstagrammer. Su Instagram lo trovate come libriamoci_tralepagine.