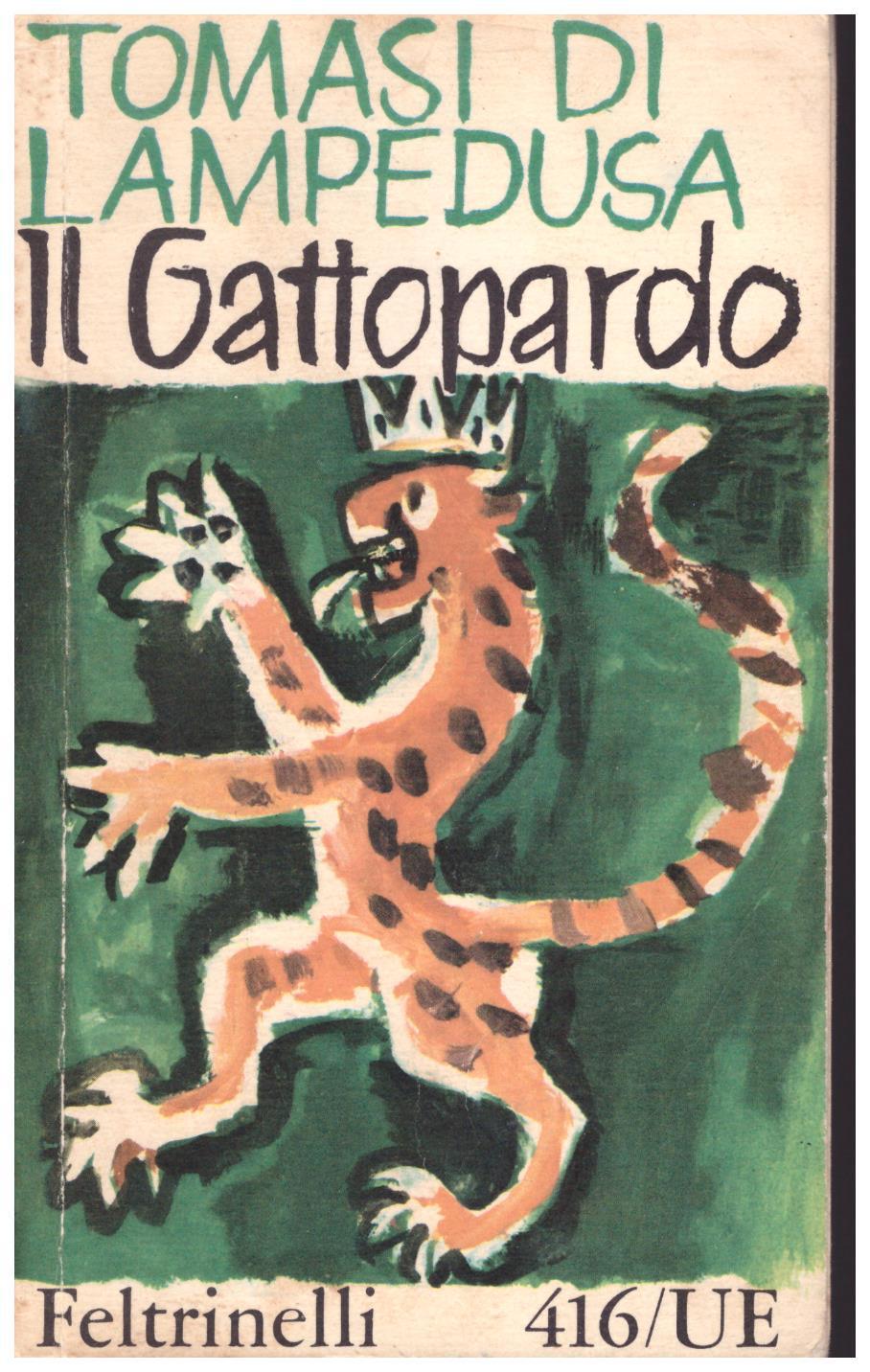Il Gattopardo inizia in un tardo pomeriggio, con la famiglia Salina riunita per la recita quotidiana del rosario. I Salina sono un casato aristocratico, e – come per tutti i nobili – il loro tempo è scandito da rituali, da pratiche dettate dall’etichetta e dal cerimoniale. Tra questi rituali, il rosario è quello che più di tutti è legato al tempo, alla sua scansione cadenzata dalla successione dei misteri e dai grani che scorrono rapidi sulla corona degli oranti. Il rosario è una preghiera lunga, impegnativa, insensata, bellissima, che segna il tempo che fluisce e lo consegna alla Vergine come un dono di umiltà: Maria, ti offro il mio tempo, che non è un tempo statico, immobile, ma un tempo che scorre, un tempo prezioso, che mi lascia diverso da com’ero prima.
Ecco, Il Gattopardo è un romanzo sullo scorrere del tempo, sulla storia che lascia una scia materiale sulle cose e le trasforma in maniera quasi impercettibile. La vicenda del libro inizia nel maggio del 1860, alla vigilia della spedizione dei Mille, in un’epoca di grandi cambiamenti, quando la Sicilia stava per passare dall’egemonia borbonica a quella dei Savoia. Don Fabrizio, patriarca nobile e fiero della famiglia Salina, vede con preoccupazione la trasformazione imminente, ma Tancredi, il suo amatissimo nipote, lo illumina molto presto sul significato degli eventi storici che si stanno per compiere: «Se vogliamo che tutto rimanga come è, bisogna che tutto cambi».
Come a dire che la trasformazione, il mutamento, è un fenomeno ambivalente: da un lato sembra cambiare tutto, dall’altro ristabilisce un ordine simile al precedente. La trasformazione è qualcosa di momentaneo, che occorre accettare perché fa parte della storia. L’ordine invece è duraturo, e se si vuole che torni simile al precedente, occorre agevolare la trasformazione in modo che si concluda il prima possibile.
Il Gattopardo narra la trasformazione che prende corpo nell’Italia della seconda metà dell’Ottocento, ma anche nella famiglia Salina e nella società siciliana. Il trascorrere del tempo è normalmente un fenomeno lento, qualcosa di talmente impalpabile che sembra difficile credere che possa portare un cambiamento nelle cose. È un mutamento costante, ma così indolente che sembra lasciare l’universo come lo ha trovato, senza portare nessuna novità. Eppure, osservando le cose dopo un certo intervallo temporale, notiamo che – anche se non si sono verificati eventi significativi – il tempo una traccia l’ha lasciata: leggerissima ma concreta. E la troviamo proprio nella consistenza materiale delle cose: una polvere sottilissima che ricopre gli oggetti e i pavimenti, i fili di una ragnatela sul soffitto, il muschio nelle zone più ombreggiate delle fontane, il marmo leggermente sbrecciato dei gradini di marmo. Una patina che custodisce e trasforma, protegge e attesta il cambiamento, preserva e rimette in discussione. Come la recita del rosario, che apparentemente ci lascia identici a come ci ha trovato, ma che in realtà ci trasforma in qualcosa di nuovo, in individui più solidi, in persone migliori.
Angelica e Tancredi, subito dopo il fidanzamento, girano per le innumerevoli stanze del palazzo di Donnafugata per cercare ambientazioni sempre nuove per i loro amori. In una di queste stanze ritrovano, tutti impolverati, dei carillon che risalivano al secolo precedente, e provano a farli suonare:
Un pomeriggio rinvennero dentro un cassettone con tre gambe quattro carillons, di quelle scatole per musica delle quali si dilettava l’artificiosa ingenuità del Settecento. Tre di esse, sommerse nella polvere e nelle ragnatele, rimasero mute; ma la quarta, più recente, meglio chiusa nello scrignetto di legno scuro, mise in moto il proprio cilindro di rame irto di punte e le linguette di acciaio sollevate fecero a un tratto udire una musichetta gracile, tutta in acuti argentini.
Il carillon, per sua natura, sembra destinato a sottolineare – con il proprio meccanismo musicale – esattamente lo scorrere del tempo. Il congegno, che dopo vari decenni ancora sembra funzionare, attesta che il tempo è ancora in movimento. Le singole note, rallentate dall’inattività durata molto a lungo, sottolineano l’ineluttabilità di questo tempo che trascorre, che talora sembra diminuire la propria velocità, in altri momenti sembra accelerare in un vortice di eventi sfrenati, ma sempre mantiene il timone dritto verso il futuro. I carillon ci parlano – ancora una volta – del tempo che passa, e – mentre ce lo rivelano – incantano questo tempo in una musichetta ripetibile, addomesticata, in cui è chiaro cosa venga prima e cosa dopo.
Il principe Salina sta per andare a Palermo a trovare una prostituta, e mentre accarezza languidamente il senso di colpa che sta per invaderlo, d’improvviso si ritrova a compiacersi in pensieri di autoassoluzione:
«Sono un peccatore, lo so, doppiamente peccatore, dinanzi alla legge divina e dinanzi all’affetto umano di Stella. Non vi è dubbio e domani mi confesserò a padre Pirrone.» Sorrise dentro di sé pensando che forse sarebbe stato superfluo, tanto sicuro doveva essere il Gesuita dei suoi trascorsi di oggi; poi lo spirito di arzigogolio riprese il sopravvento: «Pecco, è vero, ma pecco per non peccare più, per strapparmi questa spina carnale, per non esser trascinato in guai maggiori. Questo il Signore lo sa».
«Pecco, per non peccare più», afferma Don Fabrizio. Ovvero mi abbandono al trascorrere del tempo con la pretesa di invertirne la direzione. Affronto le conseguenze del peccato per impedire alla storia di imbattersi in conseguenze peggiori. Ancora una volta, il tempo sembra un concetto reversibile, navigabile in entrambe le direzioni. Ma sia che si scelga di percorrerlo in avanti, sia che si preferisca navigarlo al contrario, lascia una conseguenza materiale nell’esistenza.
A livello più ampio, ciò è vero anche per le classi sociali, che con il tempo perdono la loro peculiarità più puntuale, la quale, da natura profonda, si trasforma in esteriorità, in facciata:
La ricchezza, nei molti secoli di esistenza si era mutata in ornamento, in lusso, in piaceri; soltanto in questo; l’abolizione dei diritti feudali aveva decapitato gli obblighi insieme ai privilegi, la ricchezza come un vino vecchio aveva lasciato cadere in fondo alla botte le fecce della cupidigia, delle cure, anche quelle della prudenza, per conservare soltanto l’ardore e il colore. Ed a questo modo finiva con l’annullare sé stessa: questa ricchezza che aveva realizzato il proprio fine era composta solo di oli essenziali e come gli oli essenziali evaporava in fretta.
La ricchezza che si trasforma in ornamento, in decoro, deprivata della sostanza che ne è parte costitutiva: i beni, i privilegi, i feudi, il patrimonio, ma anche gli oneri, gli obblighi, le responsabilità. La nobiltà rimane pura facciata con niente dietro, un olio essenziale che libera la propria fragranza ed evapora velocemente. Il tempo ha eroso la sua natura aristocratica e l’ha resa pura parvenza.
Dall’altra parte, abbiamo la borghesia che compie il percorso inverso: si arricchisce, conquista cariche pubbliche, assume ruoli di potere, ma non riesce ad acquisire quell’eleganza, quella sprezzatura, quell’eminenza che affascina e seduce. Come don Calogero Sedara, il sindaco di Donnafugata, che nonostante le enormi ricchezze accumulate, il successo nella politica locale, la bellezza straordinaria della figlia Angelica, non riesce a perdere quella goffezza, quella sciatteria, quell’approssimazione che don Fabrizio non può fare a meno di notare:
come riuscita sartoriale, il frack di don Calogero era una catastrofe. Il panno era finissimo, il modello recente, ma il taglio era semplicemente mostruoso. Il Verbo londinese si era assai malamente incarnato in un artigiano girgentano cui la tenace avarizia di don Calogero si era rivolta. Le punte delle due falde si ergevano verso il cielo in muta supplica, il vasto colletto era informe e, per quanto doloroso è necessario dirlo, i piedi del sindaco erano calzati da stivaletti abbottonati.
Il frack di don Calogero è il correlativo oggettivo dell’incapacità della borghesia di assumere un ruolo che non le è mai appartenuto. Dopo la spedizione dei Mille, dopo che la Sicilia è stata sottomessa ai Savoia, dopo che l’aristocrazia locale ha dilapidato immense ricchezze e la borghesia ne ha accumulate altre in maniera significativa, sono ancora i leoni, i gattopardi a detenere nella società una supremazia in termini di consenso e di credibilità. Del resto, proprio lo spreco di immensi patrimoni da parte dei suoi avi conferisce a Tancredi il fascino che lo rende irresistibile.
Lo rivela proprio don Fabrizio parlando con don Calogero del suo amatissimo nipote: «Ma, don Calogero, il risultato di tutti questi guai, di tutti questi crepacuori, è stato Tancredi; noialtri queste cose le sappiamo: è forse impossibile ottenere la distinzione, la delicatezza, il fascino di un ragazzo come lui senza che i suoi maggiori abbiano dilapidato una mezza dozzina di grossi patrimoni». Come a dire che non è la ricchezza a determinare il carisma di un individuo, ma il disprezzo di essa stratificato nel tempo. La noncuranza con cui gli antenati dei Salina hanno sperperato enormi capitali per varie generazioni, mantenendo tuttavia uno status di rispettabilità e decoro, ha determinato nei discendenti l’indifferenza nei confronti del lavoro, del sacrificio, della fatica, e la consapevolezza di essere predestinati a una condizione di inalienabile egemonia, che non dipende più dai soldi o da una condizione sociale, ma da una speciale qualità dell’anima che il trascorrere del tempo non riesce a erodere.
È ancora il tempo, dunque – il grande protagonista del romanzo –, a determinare le sorti dei personaggi. Un tempo che sembra stravolgere ogni cosa lasciandone tuttavia l’apparenza immutata. Un tempo che cambia la sostanza ma non la forma. Un tempo che scorre molto lentamente ma che tuttavia esiste, si muove in maniera impercettibile come la sabbia tra le ampolle di una clessidra, portando con sé le epoche, i regimi politici, le tradizioni, gli oggetti, le abitudini, la vita stessa delle persone. Scorre in modo silenzioso, ma qualche volta, quando il mondo sembra tacere per alcuni istanti e l’esistenza entra in un periodo di quiete temporanea, è possibile ascoltare il suono dei granelli di sabbia che ne attestano il movimento, l’irreversibilità.
Ce lo rivela il narratore al principio del capitolo memorabile in cui viene narrata la morte di don Fabrizio:
Don Fabrizio quella sensazione la conosceva da sempre. Erano decenni che sentiva come il fluido vitale, la facoltà di esistere, la vita insomma, e forse anche la volontà di continuare andassero uscendo da lui lentamente ma continuamente come i granellini che si affollano e sfilano ad uno ad uno, senza fretta e senza soste, dinanzi allo stretto orifizio di un orologio a sabbia. In alcuni momenti d’intensa attività, di grande attenzione questo sentimento di continuo abbandono scompariva per ripresentarsi impassibile alla più breve occasione di silenzio o d’introspezione, come un ronzio continuo all’orecchio, come il battito di una pendola s’impongono quando tutto il resto tace; e ci rendono sicuri, allora, che essi sono sempre stati lì vigili anche quando non li udivamo.
Il tempo, a volte, sembra non esistere. Distratti dalla frenesia dell’esistenza, non lo percepiamo più; ma poi, osservando i segni della storia intorno a noi, ci accorgiamo che esso è trascorso, e che ha lasciato i suoi segni sulle cose che ci circondano: appunto, gli strati di polvere sugli oggetti, il muschio nelle fontane, le ragnatele sui soffitti, i gradini sbrecciati, i meccanismi inceppati dei carillon, la vita che, a poco a poco, ci abbandona.
«Se vogliamo che tutto rimanga come è, bisogna che tutto cambi». Ma perché ciò sia vero, bisogna districarsi tra le varie direzioni in cui cambiano le cose, e intraprendere quella che riporta al punto di partenza. Come fa Tancredi, quando, al momento della spedizione dei Mille, si schiera senza esitazione con l’esercito piemontese; o quando tra la nobile cugina Concetta – rampolla della dinastia dei Salina, elegante e raffinata – e la bellissima Angelica – figlia del borghese don Calogero, la cui esagerata bellezza non riusciva a occultare completamente la grossolanità delle sue origini – sceglie di sposare quest’ultima, avendo così la possibilità di accedere alle stanze della ricchezza e del potere.
Il tempo, dunque, è reversibile, circolare. Trascorre, lascia la sua traccia – una patina ben visibile sulle cose – ma poi ritorna al punto di partenza, portando con sé chiunque sia stato in grado di carpirne il segreto e di cavalcare i suoi percorsi misteriosi. È un tempo che sembra fondamentalmente statico, ma che cambia la sostanza delle cose, ne rinnova il cuore più profondo.
Come nella corona del rosario, che, al termine della recita, alla fine della quinta decina, si ricongiunge al principio della prima, in una perfetta e mistica circolarità. Sembra che non sia cambiato niente, ma forse, se recitato con fede, potrebbe essere cambiato il cuore.
Luca Alvino è nato a Roma nel 1970. Ha pubblicato Il dettaglio e l’infinito. Roth, Yehoshua e Salter (Castelvecchi, 2018) e Il poema della leggerezza. Gnoseologia della metamorfosi nell’Alcyone di Gabriele d'Annunzio (Bulzoni, 1998). Si interessa di letteratura contemporanea e di poesia. Collabora con il blog minima&moralia.