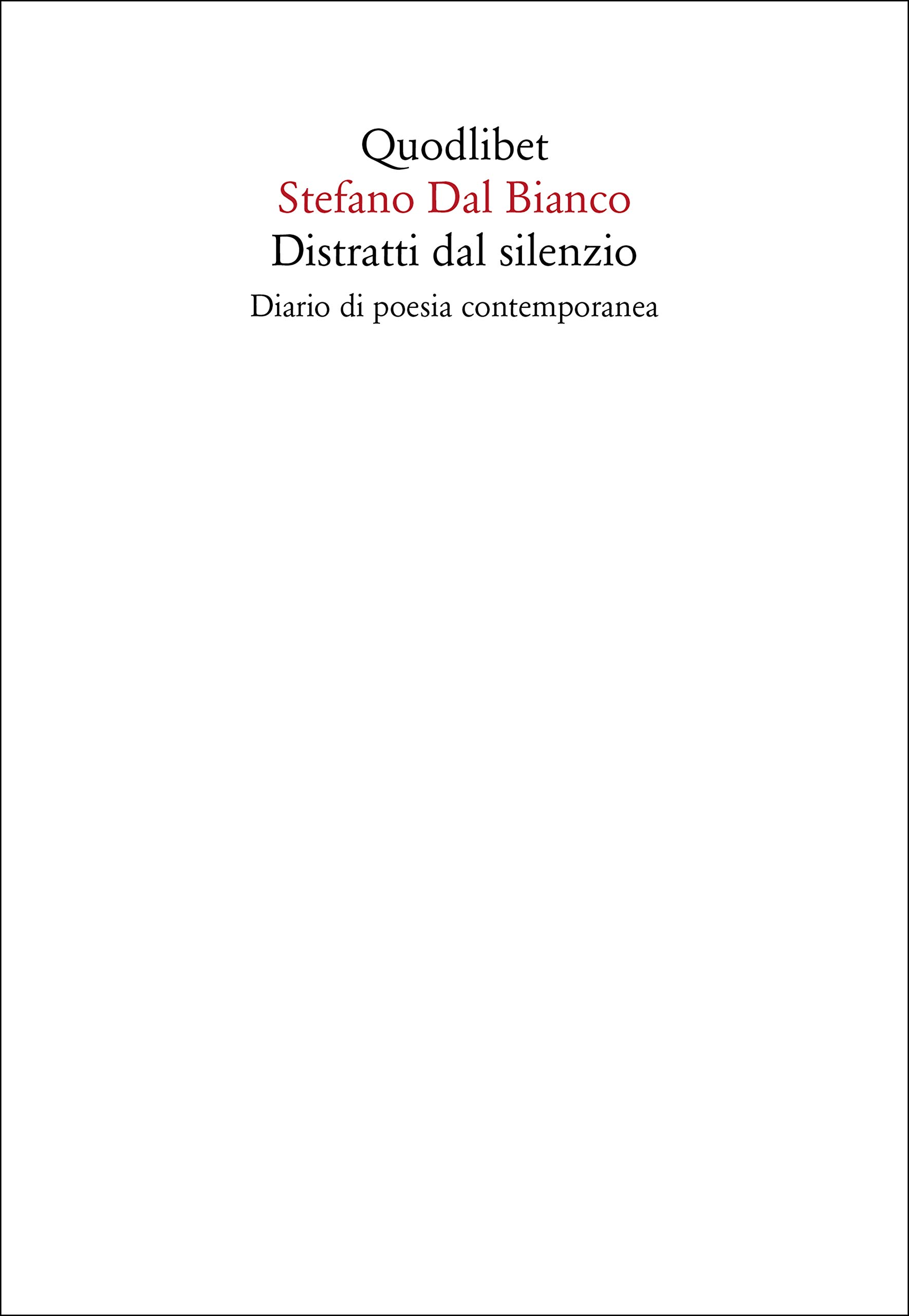di Stefano Dal Bianco
L’opera esprime senso attraverso l’ascesi nei confronti del senso. [T.W. Adorno]
Ciò che è divino è senza sforzo. [Eschilo]
«Distratti dal silenzio sono forse i poeti. Non tutti: ce n’è qualcuno, e non per forza dei peggiori, che se ne infischia del silenzio, ma questi a noi interessano poco. Quello che vogliamo è un indugio nella morte, per attraversarla con amore e arrivare di là, dall’altra parte, dove la nostra esistenza avrà un significato meno provvisorio di quello che siamo abituati a conferirle. Per farlo bisogna essere bravi, bravi nella vita e bravi nell’ascolto della lingua. È così che amare e respirare saranno per noi la stessa cosa. Una cosa per cui vale la pena di lavorare, di impegnarsi».
Così scrivevo, agli esordi di tutto, tra gli anni Ottanta e Novanta, usando parole e toni che oggi mi impressionano per la retorica e l’improntitudine, e soprattutto senza dare ragione di quel noi: a nome di chi parlavo? Sicuramente a nome degli amici che in quegli anni iniziavano con me la loro ricerca poetica, presi come eravamo dalla vertigine che ci imponeva di trovare una lingua per raccontare ciò che tra noi si pensava, si diceva e si scriveva. Nacque così «Scarto minimo – Rivista di poesia contemporanea» che nel 1986 fondammo a Padova con Mario Benedetti e Fernando Marchiori. La rivista non accoglieva saggi critici e recensioni, ma soltanto poesie e “interventi di poetica”.
Non tutti hanno avuto la fortuna – e certo la sfrontatezza – di poter dire noi all’inizio della propria storia. E raramente i poeti parlano davvero di poesia tra loro. La maggior parte riflette sul senso di ciò che fa, ma parlarne è un’altra cosa. C’è un pudore esagerato, e in molti una disabitudine a condividere le esperienze e le idee. L’egotismo, in effetti, non riguarda chi parla di sé, ma chi non riesce a esporsi in una relazione. E una poetica di gruppo non è l’adeguarsi a un dover-essere della poesia, e nemmeno una razionalizzazione a posteriori. È tutte e due le cose: è qualcosa che si fa insieme, vivendo e scrivendo; non viene prima o dopo la poesia, ma nel mentre. Ognuno è se stesso e contemporaneamente assorbe, interiorizza, ciò che avviene negli altri e offre ciò che ha di proprio. Quanto maggiori sono la stima e la fiducia reciproche, tanto più il pensiero comune affiora e si lascia intendere, accrescendo la comprensione del proprio fare. Non si tratta di uno scambio, perché lo scambio, comunemente, presuppone individualità definite che hanno ben chiaro ciò che possono proporre. La poetica, ogni poetica di gruppo, si forgia nella relazione stessa, un processo nel quale a prevalere sono l’incoscienza e l’osmosi.
La citazione all’inizio riflette bene lo stile romantico e garibaldino della seconda metà degli anni Ottanta. Ma non è lì soltanto per un rigurgito nostalgico. L’ho riportata per rivendicare un atteggiamento che, pur evolvendosi nei decenni, ha conservato il suo spirito fondante, che era ed è di difendere il sapere della poesia in quanto tale. Uno dei punti di forza di «Scarto minimo» era proprio di sdoganare la teoresi dei poeti, infischiandosene di ciò che poteva essere politicamente corretto per un teorico della letteratura o per un filosofo estetico. Le ragioni della poesia non avevano bisogno delle stampelle di qualche illustre pensatore del passato o del presente, ma dovevano sbocciare direttamente dall’esercizio della scrittura e, nel caso, si doveva avere il coraggio di essere ingenui e di mostrarsi ignoranti. A monte c’era evidentemente la consapevolezza di essere eredi diretti, e perciò detentori, di un sapere che non era appannaggio né dei letterati di professione, né dei filosofi. Di qui l’insistenza sulle forme e sullo stile. Lo sforzo, in realtà, era di mettere in relazione il sapere linguistico formale con il culturale e l’esistenziale – forma, cultura, esistenza – per tratteggiare una sorta di etica della poesia.
Anche adesso, dopo qualche decennio, quando ormai ciascuno di noi ha raggiunto la propria chiarezza, come è destino che sia, il lascito di quell’esperienza è prezioso, e si comprende meglio come quel noi fosse la fattispecie del “noi” più vasto che si annida nella voce di ogni singolo poeta.
*
Ho raccolto qui, secondo il filo del tempo, le riflessioni che nell’arco di trent’anni, e nelle forme più diverse, mi è capitato di scrivere o esporre pubblicamente intorno alla poesia, alla poesia in generale e alla mia in particolare. E ho spiegato come mai molte di esse si presentino in una prospettiva “generazionale”.
Il titolo di questo libro accosta in modo paradossale due fuochi ricorrenti negli scritti che lo compongono: distrazione e silenzio. Non c’è poesia senza dedizione al silenzio. Chi scrive deve trovare e salvaguardare una certa dose di silenzio interiore. Fino a qualche decennio fa si poteva pensare che fosse il rumore del mondo a distrarre i poeti dal loro luogo proprio. Mi sono accorto che alla base di molte delle mie considerazioni c’è l’esperienza diretta di un rovesciamento dei termini. La quantità e la qualità del rumore della vita contemporanea hanno mutato la condizione esistenziale di chi scrive, dei poeti, come quella di tutti. Viviamo sotto bombardamenti di comunicazione inessenziale. Di pari passo si è ridotto lo spazio che, nel marasma delle nostre vite, siamo disposti a riservare al silenzio. Al giorno d’oggi – e non era mai accaduto in modo così netto – solitudine, silenzio, vuoto, fanno paura anche ai poeti. Il frastuono è in noi, ed è sempre più difficile escluderlo. Ciò significa che si va radicalizzando anche il conflitto tra il momento della scrittura e quello della vita.
Come far fronte a tutto questo? Forse domandandosi se distrazione e silenzio sono davvero due poli incompatibili. È immaginabile una condizione nella quale una certa dimensione silenziosa possa conservarsi in forma, per così dire, surrettizia, e essere vissuta negli interstizi della distrazione? È possibile che l’accettazione della dimensione distratta la renda almeno in parte generativa di un silenzio differente? È pensabile, insomma, una dimensione silenziosa che nasca dalla distrazione stessa?
Non so se la scommessa sia davvero questa, e non so se la sto formulando nel modo corretto. Mi si impongono qui alcune considerazioni sulla parabola della mia esperienza di scrittura, così come questa si è delineata e in qualche modo specchiata negli interventi qui raccolti.
La poetica di «Scarto minimo» puntava alla riduzione del divario tra lingua della poesia e lingua naturale, che è come dire tra poesia e vita, senza per questo rinunciare alle istanze di un “grande stile” di matrice novecentesca. Era dunque l’attenzione alla forma stessa – in una prospettiva opposta a ogni espressionismo e perciò sostanzialmente “classica” – a farsi garante di una aderenza alla verità dell’esistere.
Ma l’assunzione di responsabilità stilistica sul proprio fare implica una disciplina interiore che, di fatto, pertiene alla sfera dell’etica, dal momento che viene esercitata prima di tutto contro se stessi e la propria scrittura. È così che, a un certo punto, l’etica della forma ha potuto dichiarare guerra ai contenuti, a ciò che comunemente viene definito “il messaggio” di una poesia, mentre il piano formale veniva eletto a unico strumento di conoscenza e di crescita umana. È evidente che un intento del genere poteva reggere solo come provocazione, se si considera che dopotutto i testi un messaggio lo comunicavano, sia pure di sottobanco e quasi fuori controllo.
Su un altro fronte, andare contro se stessi voleva dire perseguire utopicamente quell’assenza di stile individuale che è il miraggio di ogni classicismo. Che al fondo di questi tentativi di dismissione dello stile si trovi pur sempre una voce, uno stile, è l’esperienza di tanti poeti nella loro maturità. Ma alla radice di quell’atteggiamento classico che persegue la rinuncia allo stile è probabilmente la grande tradizione filosofico sapienziale del “conosci te stesso”, del lavoro su di sé che ogni essere umano è tenuto a intraprendere proprio nell’ottica di un annullamento dell’ego. La parabola perveniva così, non senza traballamenti e contraddizioni, a un discorso che coinvolge non solo quei “significati” e quel “messaggio” che all’inizio si davano per inessenziali, ma nientemeno che il senso della vita in quanto tale.
Nello stesso tempo, l’assolutizzazione del momento formale diveniva una sorta di iniziazione tecnico stilistica, la quale, portata all’incandescenza, poteva davvero farsi strumento di conoscenza trascendentale. Ascoltare la lingua silenziosamente, distrattamente, senza sforzo, è entrare in contatto con il divino che è in noi, perché la lingua è il divino. «In principio era il Verbo, e il Verbo era presso Dio, e il Verbo era Dio»: una poesia che non si misuri con questo, che non cerchi di sondare il mistero del Logos, di entrare profondamente nel suo significato, ha già abdicato al suo destino.
Siena, febbraio 2019
Questa è l’introduzione a Distratti dal silenzio. Diario di poesia contemporanea di Stefano Dal Bianco. Appena uscito per Quodlibet, il libro raccoglie scritti di poetica e sulla poesia contemporanea, che attraversano gli ultimi due decenni del Novecento e i primi due degli anni Duemila. Riportiamo di seguito Manifesto di un classicismo, pubblicato sulla rivista «Scarto minimo», 1, marzo 1987.
Manifesto di un classicismo (1987)
Chi scrive è affetto da patologica indecisione. È così che forse, cavillando cavillando, non sarà difficile reperire nel breve scritto che segue degli scarti interpretabili come contraddizioni, anche se non esplicite. A mia parziale discolpa devo dire.
Non tutto è rappresentabile. Spesso chi si affanna a trovare contraddizioni è schiavo delle rappresentazioni e manca di intelligenza sensibile. Le contraddizioni non esistono. Bisogna sempre sforzarsi di annullarle senza doversi aggrappare a una rappresentazione. C’è sempre un indicibile che rende conto della qualità apparente dell’antitesi. Ciò che unisce in un punto i due estremi di una contraddizione è spesso una motivazione profonda che non tollera di passare attraverso una rappresentazione.
Il corpo è importante perché io sono io. Il lessico, dal momento che si presenta prevalentemente come un fatto di scelta, si rivela separato dal corpo. Non hanno niente a che fare con una scelta i procedimenti ritmico sintattici, che sono più facilmente emanazione del corpo, che sfuggono all’appiattimento della langue con molta più disinvoltura dei significati lessicali. È per questo che si è contro la volgarità di ogni espressionismo. Non per motivi puristici, ma per il fatto che ogni termine marcato si allontana dal cuore in misura direttamente proporzionale allo straniamento messo in atto. L’espressionismo punta sul lessico. Qui si è per lo straniamento controllato, che è un fatto di respiro, di sintassi e di ritmo, non di scelta lessicale. In nome di una presa di coscienza della misura del nostro respiro, guardiamo con sospetto ai linguaggi speciali e anche al “cozzo dell’aulico col prosastico” o a qualsiasi altro modo in cui il grado zero sia raggiunto macroscopicamente per somma algebrica degli elementi. Lo zero va perseguito a livello microtestuale. È la non rilevanza dei punti del tracciato, la medietas petrarchesca.
Ed è anche da ritenersi auspicabile una scorrevolezza della lettura. È normale che la poesia richieda più di una lettura, ma una poesia non deve chiedere che ci si fermi a ogni parola. La petulanza lessicale è specchio di falsità. La verità sta più in alto, o più in basso della lingua, comunque in un piano inconoscibile. Non è più accettabile una fiducia nella lingua, perché le parole non sono affatto più vere delle cose. Ciò di cui si può essere sicuri è forse solo della necessità di sperimentare una ricerca dei limiti, a partire dal corpo e dal suo respiro. Puntare su una fruizione che non si curi dei particolari lessicali e che non indugi sulle specificazioni. È una poesia che alla lettura non ci dice quasi niente perché in realtà vuole dirci altro. E ci dirà più tardi, quando parole in cui ci imbatteremo casualmente richiameranno altre parole dimenticate, e con esse tutto il respiro che le trasportava. Così si esplica la nostra infondatezza in un mondo che non ci ama e non ci odia.
Alla base della divaricazione tra classico ed espressivo può esserci una diversa idea di forza. L’esigenza espressionistica è quella di una parola esibita, a sé stante, eventualmente ricca di implicazioni ma al tempo stesso eclatante e immediata, una parola in cui l’intenzione faccia tutt’uno con l’attualizzazione, che sia evidente.
La parola classica è velata, grigia, povera, svalutata in funzione del verso e quindi attenta alle sfumature, riflessiva, psichica e leggera. L’intenzione è costitutivamente mascherata. È il desiderio di entrare nelle cose (nella morte), il che implica sofferenza, da cui un atteggiamento di ipersensibilità verso l’esterno, di estrema riflessività, di paura, che si traduce in forza interiore e che viene interpretato aberrantemente come debolezza. Si usa chiamare forza invece la rimozione espressionista dell’interno.
Il classico coincide oggi con l’amore, cioè con il rifiuto della moralità nella forma. L’espressionista è sempre morale o antimorale, mai amorale. Il già visto, ritmico e formale, va nel senso di una comunicazione ritrovata fra corpi. Lo straniamento massimo e la novità a tutti costi vanno nel senso di una spettacolarizzazione del sentimento.
Ma classico non significa ossessione del senso. Come non è incasellabile in un sentimento reazionario della forma, così non si lascia prendere dal gioco accademico dell’equivalenza forma chiusa-recupero del senso, per cui tutto ciò che non è pura letteratura viene tacciato di surrealismo e tutto ciò che non si capisce è vizio formale.
La necessità della forma chiusa[1] esprime la nausea della trascorsa «mimesi della schizofrenia universale» (anni Sessanta) e della disgregazione apocalittica dell’Io (anni Settanta) e il loro superamento, ma non certo nel senso di un ancor minore impegno (esistenziale più che politico) dovuto alla fiducia in un corpo sano e al trinceramento dietro i confini di esso. Qui si tratta di un tentativo di superamento e accettazione del male proiettandolo all’interno di una coscienza agguerritissima, così forte da non aver bisogno di tecniche eclatanti ed estrinseche per affrontarlo. Il tutto si risolve (ma è parola che impoverisce la tragicità dell’esperienza) nell’immagine di un corpo che, per una sorta di orgoglio del decadimento, riesce a contenere al proprio interno le metàstasi con il semplice aiuto della coscienza.
La coscienza di una ormai sopravvenuta condizione metastorica per la decadenza occidentale è mille volte più interessante di qualsiasi rigurgito di primitivismo dorato.
Il classico ha a che fare con l’ironia. Leggiamo Cioran: «Chi vuole insediarsi in una realtà o scegliersi un credo, e tuttavia non ci riesce, si dedica per vendetta a ridicolizzare quelli che vi accedono spontaneamente. L’ironia deriva da un desiderio di ingenuità deluso, insaziato, che, a furia di fallimenti, s’inasprisce e s’invelenisce».[2] Questo genere di ironia potrebbe essere preso come il motore di tanta letteratura contemporanea.
Se il presupposto e il nostro fine ultimo è una consapevolezza dell’arbitrarietà dell’esistere che escluda ogni rancore, l’ironia non dovrebbe entrare in poesia. Ma l’antico tragico è per noi escluso, relegato in un passato che a tratti sprizza fin qui, si fa cogliere, ma noi non ne conosciamo la forza. Ecco perché la maggior parte dei discorsi in cui manca l’ironia è soggetta, oggi, a un inevitabile effetto kitsch che ne depaupera l’originaria, intenzionale, tragicità. Ne deriva che l’ironia deve essere costitutiva anche del classico. Si tratta però di un’ironia che rifiuta il sarcasmo come troppo attaccato alle cose e alle persone. È un’ironia paradossalmente priva di referente concreto, che è specchio di un distacco, di un anonimato del soggetto, di una sospensione. Essa si rivolge solo contro la sintassi corrente, finemente ridicolizzando la sua mancanza di consapevolezza, la sua fiducia nella vita, e al tempo stesso la sua inevitabile falsità di langue.
La nostra tragedia è dunque pervasa di leggerezza. La poesia è una commistione tragico ironica che rifiuta il masochismo idiota del sarcasmo ed è sorda a ogni pesantezza. Non si può accettare e vivere il vuoto continuando a strapparsi i capelli. E tutto questo è classico.
Note:
[1] La dizione forma chiusa, qui e qualche riga sopra, può dare adito a fraintendimenti. L’eventualità di comporre terzine o sonetti, per noi in quegli anni, era molto lontana. Per forma chiusa in questo contesto si intendeva qualche cosa come “un componimento in metrica libera che tuttavia conservasse l’aura di ciò che erano state le forme chiuse della tradizione” (sdb 2019).
[2] E.M. Cioran, Squartamento, Milano, Adelphi 1981, p. 49.
Maria Borio è nata nel 1985 a Perugia. È dottore di ricerca in letteratura italiana contemporanea. Ha pubblicato le raccolte Vite unite ("XII Quaderno italiano di poesia contemporanea", Marcos y Marcos, 2015), L’altro limite (Pordenonelegge-Lietocolle, Pordenone-Faloppio, 2017) e Trasparenza (Interlinea, 2019). Ha scritto le monografie Satura. Da Montale alla lirica contemporanea (Serra, 2013) e Poetiche e individui. La poesia italiana dal 1970 al 2000 (Marsilio, 2018).