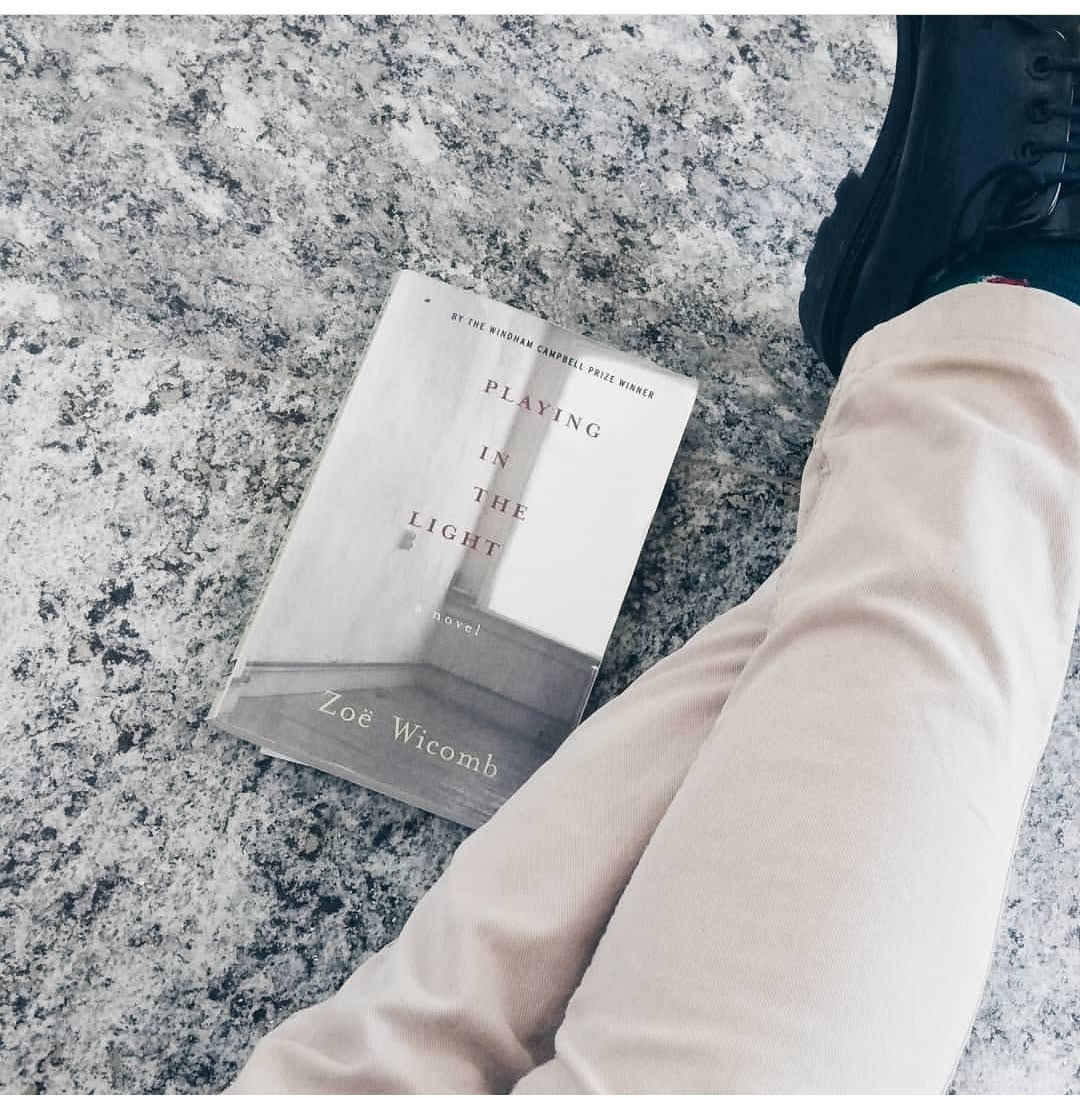Città del Capo, immediato post-apartheid. Marion Campbell, giovane sudafricana bianca (no, questa volta non si può evitare di porre enfasi sul colore della pelle, poi capirete perché), gestisce un’agenzia di viaggi e sembra incarnare il prototipo della donna emancipata. Vive sola in un condominio lussuoso vista mare, passa le sue serate nel letto a baldacchino che ha sempre sognato e guida una Mercedes. È single e sembra non sentire l’esigenza di aver un uomo con cui spartire il materasso né di amicizie cui poter telefonare la sera. Una vita agiata, insomma, e solida come un monolite, almeno in apparenza.

È questo lo scheletro portante del romanzo In Piena Luce di Zoë Wicomb (Playing in the Light, 2006), pubblicato in Italia nel 2009 da La Tartaruga nella traduzione di Francesca Romana Paci e Angela Tiziana Tarantini. Uno dei romanzi che al momento sento abbiano maggiormente plasmato il mio personale modo di vedere, gettando luce su aspetti del reale che mai avrei considerato altrimenti. Talmente fondamentale che mi stupisco al pensiero che l’autrice sia quasi totalmente sconosciuta, almeno al grande pubblico.
Nata nel 1948 a Beeswater, nell’arida regione sudafricana del Namaqualand, Zoë Wicomb si è poi trasferita a Glasgow nel 1994, dove attualmente insegna alla Strathclyde University. Al momento, mentre un nuovo romanzo è in lavorazione, Wicomb ha all’attivo innumerevoli contributi saggistici e quattro opere di fiction (due raccolte di racconti e due romanzi), l’ultima delle quali è proprio In Piena Luce.
Decidere di parlare di questo libro è un po’ come tirarsi una zappa sui piedi, perché è talmente stratificato da rendere difficile qualsiasi tipo di analisi. Nonostante questo, considerato il valore del romanzo, mi sforzerò qui di snocciolare i punti più salienti. Torniamo a dove siamo rimasti qualche riga fa: Marion sembra condurre una vita perfetta, niente sembra poterla scalfire, eppure qualcosa cambia nel momento in cui assume come impiegata dell’agenzia Brenda, una ragazza nera dallo spirito politico particolarmente affilato. Si crepa una parete, improvvisamente. Una nuova luce spinge per entrare. L’indole infuocata della ragazza spingerà tutti, ma in particolare Marion, a spostare lo sguardo un po’ più in là e a interrogarsi sul proprio peso e il proprio ruolo nella scacchiera insanguinata della storia sudafricana. È chiaro sin da subito, infatti, che il romanzo è ambientato dopo il 1994, anno in cui finalmente si mette fine all’apartheid, una delle stagioni più buie che l’intero continente africano abbia mai vissuto.
La segregazione razziale sembra essere ormai solo un ricordo nella mente dei personaggi: il Sudafrica è diventato un paese democratico e il partito di Nelson Mandela è al governo, ma il sentimento popolare è tenacemente ancorato al passato. La maggior parte dei protagonisti – il padre di Marion, John, in prima linea – ha un atteggiamento nostalgico nei confronti di quello che è stato. La democrazia, secondo loro, ha portato soltanto corruzione e ha permesso ai kaffirs – termine denigratorio in lingua afrikaans per indicare la popolazione nera – di commettere crimini alla luce del sole. L’apartheid è giunto al termine, dunque, ma la situazione nazionale non si è ancora risanata, i conflitti razziali e di classe sono talmente ingombranti da impedire che il tessuto del paese venga rattoppato, che il passato passi davvero. Considerata questa cornice ideologica entro la quale si muovono i personaggi, immaginiamo cosa possa scaturire dall’incontro tra una ragazza nera, Brenda, e un gruppo di colleghi bianchi nostalgici o indifferenti, come Marion, nei confronti delle ferite della segregazione razziale. Nonostante Marion abbia espresso più volte il desiderio di lavorare in un ufficio che sia svuotato da ogni ideologia politica, la fame di giustizia e di rivalsa di Brenda accende una miccia che farà crollare l’integrità della nostra protagonista.
È proprio durante una mattina di lavoro come tante che Brenda litiga con il collega Boetie, accusandolo di non dare il giusto peso alla responsabilità dei singoli individui nel percorso che ha portato all’istaurazione della segregazione razziale e alle terribili conseguenze che essa ha avuto. Marion interviene: «Fuori la politica dall’ufficio». Ma intanto i primi interrogativi iniziano a farsi strada nella sua testa. Com’è andata davvero? Che ruolo ha avuto la sua famiglia? Chi è lei? C’è qualcosa che Marion deve sapere e a ripeterglielo è un’immagine sulla copertina del quotidiano nazionale posato sulla scrivania dell’ufficio. La fotografia di una donna, il fantasma del passato, che con enfasi shakesperiana sembra dirle: «Ricorda, ricorda, ricorda». Cosa c’è da ricordare? Chi è quella donna?
La donna è Patricia Williams, superstite delle più violente atrocità dell’apartheid. Non solo un fantasma del passato, ma dal punto di vista metaforico un vero testimone del tempo, un corpo su cui ancora sono evidenti gli squarci dei traumi nazionali. La sua immagine comincerà a perseguitare la protagonista, non la lascerà in pace, assumerà sembianze sempre diverse fino a quando Marion non deciderà di intraprendere letteralmente un viaggio alla ricerca del tassello mancante, dell’anello della catena che qualcuno ha rubato e tenuto nascosto per sempre.
È evidente sin dal principio, agli occhi di Marion e a quelli dei lettori più attenti, che questo mistero del passato ha a che fare con l’identità della protagonista. Cresciuta da genitori bianchi e da una bambinaia nera, in una casa bianca e asettica, circondata (quasi) unicamente da persone bianche. Una vita color latte, dove l’unica presenza nera – la più cara, la più amata – è sparita senza nemmeno l’ultimo saluto, il più importante. Che ruolo aveva quella persona? Chi era davvero? E chi è davvero Marion Campbell? Altre domande, sempre le stesse e poi altre, nuove.
Grazie a questo viaggio iniziatico, Marion arriva nelle zone “nere” del territorio sudafricano, in quei quartieri che, nonostante la fine dell’apartheid, segnano ancora una divisione etnica netta. Marion entrerà dunque in contatto con persone che si riveleranno esserle più vicine di quanto pensasse. La verità a un certo punto diventa chiara, esposta in piena luce. Ma il viaggio non è finito, non può terminare. Marion, per scendere a patti con la verità rivelata, deve allontanarsi dal paese che le ha dato i natali e solo così, solo scappando per un attimo dalla storia ingombrante di un paese diviso, riesce a ricominciare, a provare ad autodeterminarsi ancora partendo dalle sue nuove consapevolezze.
Quella della ricerca della propria identità è soltanto una delle tante tematiche sollevate da Wicomb nel romanzo, ma è sicuramente una delle più evidenti. Se ci soffermassimo ad analizzare il titolo originale del libro, infatti, noteremmo quasi immediatamente un riferimento (e omaggio) al saggio Playing in the Dark di Toni Morrison (1992), dove l’autrice afroamericana riflette proprio sulla questione dell’identità razziale. Nel romanzo, inoltre, Wicomb mette alla prova il lettore e, ancora prima di renderlo partecipe dell’epifania della protagonista, lo stimola con delle immagini anticipatorie di quello che verrà. Il tropo dell’identità entra nel corpo del romanzo già dalle primissime pagine e non vi uscirà mai. Marion riflette, ad esempio, sulla condizione identitaria delle sirene costrette a vivere nel compromesso di una vita che le obbliga a essere metà donne e metà pesci, cittadine di due mondi contemporaneamente. O ancora il tema dell’identità è evocato dall’immagine di Michael Jackson che, all’apice della sua carriera da popstar, decide di sottoporsi a operazioni chirurgiche che gli permettono di cambiare il colore della sua pelle. Da nero a bianco.
A posteriori, invece, dopo che il romanzo è stato bene interiorizzato dal lettore, ciò che colpisce maggiormente è come Wicomb utilizzi una prosa caotica e tesa al preziosismo linguistico per costruire un intreccio pluristratificato e poco lineare. La sua scrittura fonde con grande maestria la lingua inglese al vocabolario afrikaans con lo scopo ultimo di creare caos sulla pagina perché, come affermato dall’autrice stessa in diverse occasioni, l’unico modo per rendere la confusione e la complessità della situazione politica sudafricana è quello di concretizzarla attraverso una lingua speculare. È solo gettando il lettore su una pagina labirintica, dove ogni parola sembra condurre contemporaneamente in direzioni diametralmente opposte, che la storia sudafricana può essere osservata.
Sicuramente degno di nota è anche il modo in cui, forse addirittura inconsapevolmente, la scrittrice sudafricana gioca con i generi letterari. In questo senso In Piena Luce può essere facilmente letto sia come Bildungsroman, se consideriamo l’evoluzione della protagonista, sia come romanzo famigliare, se invece poniamo la nostra enfasi sulle case e le dinamiche di una famiglia indubbiamente disfunzionale. Il tutto impreziosito da elementi facilmente riconducibili ad atmosfere noir e gotiche e alla letteratura di viaggio.
È proprio l’evidente molteplicità postmoderna di punti di vista e prospettive che, insieme a una prosa complessa e provocatoria e a una struttura basata su diversi livelli narrativi, riesce a convincere a fondo il lettore. In Piena Luce mostra sin da subito la sua indole complessa e spinge chi legge a collaborare attivamente; Wicomb sembra non tollerare i lettori pigri e per questo motivo ci stimola costantemente, affidandoci a una polifonia di voci narranti e giocando coi piani temporali, e ci costringe a strizzare gli occhi davanti a pagine tortuose. Non esagero affatto quando ribadisco che un romanzo come questo può davvero temprare la nostra personalità da lettori, e insegnarci che ognuno di noi, come essere umano, deve imparare a fare i conti con la complessità infinita del mondo che ci circonda.
Federico Colombo è un bookblogger e bookstagrammer. Gestisce il blog microcosmodiparole. Su Instagram la trovate come microcosmodiparole.