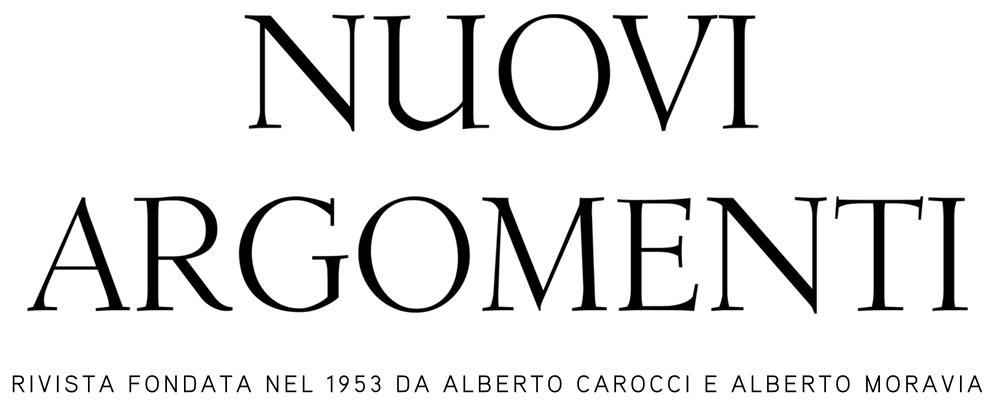Poesia intesa come “arte generale del segno”. Così Emilio Isgrò definisce la poesia nella sua Dichiarazione 1. Era il 1966. Intanto c’è una carriera artistica a trecentosessanta gradi, che lo vede impegnato a esplorare altri linguaggi quali il teatro e il cinema, prima di approdare nel 2003 alla raccolta Brindisi all’amico infame.
La copertina reca la Cancellazione per Brindisi all’amico infame che si rivela immediatamente come portatrice di senso. L’autore si presenta con delle cancellature già in copertina, cancellature in grado di suscitare una sensazione di distanza. Questo tipo di operazione fa già parte della nostra memoria televisiva; una delle sue cancellature fa da sfondo al programma Passepartout curato dallo storico dell’arte Philippe Daverio.
Per Isgrò la cancellatura si configura come un ostacolo tra noi e l’immagine mediatica, è una presenza che negando una parola “esclusa” dal discorso riesce a sottrarre lo scritto al canale della percezione passiva. E’ inoltre un segno che si propone l’obiettivo di eliminare il superfluo, di scegliere e di selezionare le parole, parole che, tra tante esclusioni, spiccano monumentali come piramidi nel deserto del discorso.
Le immagini del libro sono notevoli e direi che sono espressione di una mente decisamente libera, un gusto che si sviluppa attraverso il superamento delle associazioni di consuetudine, per raggiungere una comunicatività più efficace e fantasiosa, un occhio visionario che ha tutto il sapore del secolo Novecento.
In questa raccolta poetica Isgrò rievoca l’infanzia trascorsa nella sua amata terra, la Sicilia. Una Sicilia “troppo addolorata per essere sincera” e dove “anche la briscola degenera in tragedia”.
L’infanzia è dunque un’educazione al crimine e al lutto, un apprendistato mediterraneo bieco che fa sì che spesso si sia spettatori di silenziose tragedie quotidiane. Emilio Isgrò gioca a trasformare il requiem in un brindisi e vice versa, l’ironia è strumento ora di superamento, ora di attacco. L’autore sembra fare sciacallaggio di memorie collettive, rubando brandelli di storie per creare un quadro più ampio, un quadro regionale. La Sicilia emerge con molta prepotenza da queste pagine, con un carattere estremamente autentico e mai tipizzato.
Da napoletana, direi che spesso territori come Napoli, o come la stessa Sicilia in questo caso, sono strumentalizzati per ottenere fama letteraria con un argomento tutto sommato condiviso. Si espongono a questo rischio quei luoghi che, per dirla con Georg Simmel, hanno il “ritratto” più forte del “volto”. L’idea prodotta dall’immaginario collettivo è più forte della realtà stessa.
“La Sicilia è finita ed io la penso ancora \ come fosse ancora lì e la geografia \ fosse la storia stessa che si umilia. \ Quante poesie ho evitato di scrivere \ pur di non apparire fragile e sanguisuga”.
Nell’intervista ad Isgrò curata da Vincenzo Guarracino, posta a chiusura del libro, l’autore si esprime in maniera piuttosto esplicita su questo punto. L’attenzione alla terra d’origine era pregnante già nella prima raccolta dal titolo Fiere del Sud. A questo libro, era seguita una fase di rigetto, di allontanamento totale dall’argomento. A chiusura di questo c’è Brindisi all’amico infame, che esprime l’amore per la terra di origine in maniera assolutamente non localistica e non stereotipata, un amore per la terra reso più maturo dalle diverse esperienze e dalla riconquista dopo il distacco.
Brindisi all’amico infame scaturisce dall’esigenza di recuperare il proprio ‘posto’. Si legga questo frammento: “Nel momento in cui siamo qui e altrove per via della società mediatica, che ci costringe a stare a cena con tragedie di tutti i tipi, a convivere con l’orrore e con la demenzialità, ho sentito il bisogno di riposizionarmi nella mia storia, con tutto ciò che essa ha, di positivo come di oscuro. In una storia, che ha ben poco da spartire con la geografia, con l’immagine convenzionale che di essa hanno costruito i media e che anche certi scrittori hanno contribuito a divulgare”.
C’è una sete di verità che inequivocabilmente si sazia con il passato. Un ritorno ad una sensibilità quasi “arcaicizzante”, una delicatezza che è una dissonanza con il tono continuo che fischia nelle nostre orecchie moderne. C’è in questi versi la melodia della campagna e l’ascolto pulito delle generazioni contadine, il tutto reso più ruvido dalla senso critico espresso con una forte vis polemica nei confronti della contemporaneità. Sembra che nel testo, a tratti, si insinui la voce di Pasolini.
“Mirabile la terra quando ancora
contiene insetti, api, formiche, lepidotteri
lanciati contro i tori e i carri armati.
Mirabile la vita quando non c’è più niente
che possa separarla dal maschio e dal suo seme.
E anche le mutande di una femmina
non sono più deserte né più calde
di un piatto di carne
………….che si trasforma in rondine”.
Immagine: Emilio Isgrò, Dichiaro di non essere Emilio Isgrò (poi ritrattata in Diacharo di essere Emilio Isgrò), 1971
Maria Borio è nata nel 1985 a Perugia. È dottore di ricerca in letteratura italiana contemporanea. Ha pubblicato le raccolte Vite unite ("XII Quaderno italiano di poesia contemporanea", Marcos y Marcos, 2015), L’altro limite (Pordenonelegge-Lietocolle, Pordenone-Faloppio, 2017) e Trasparenza (Interlinea, 2019). Ha scritto le monografie Satura. Da Montale alla lirica contemporanea (Serra, 2013) e Poetiche e individui. La poesia italiana dal 1970 al 2000 (Marsilio, 2018).