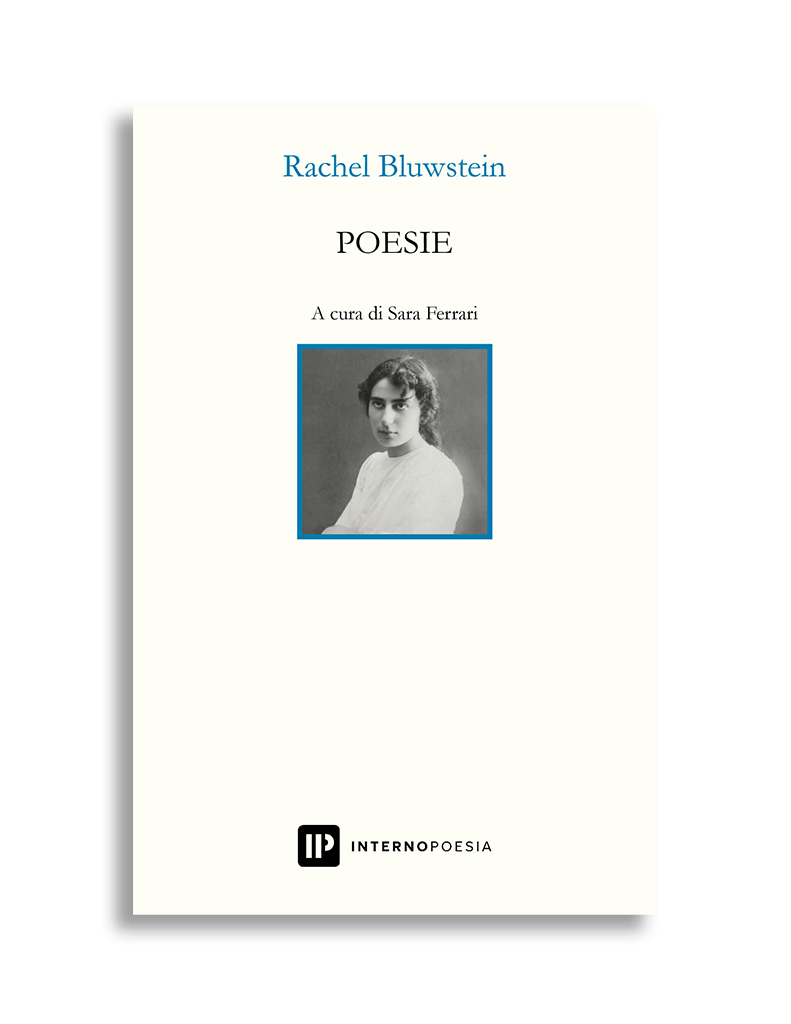Generalmente in Italia non arriva molta poesia straniera, soprattutto se di provenienza non
occidentale (ovvero non europea e non americana). A mio avviso, si tratta di una cosa normale,
perché non è facile trovare un pubblico per questo di tipo di poesia, e alle case editrici non conviene investire in questa direzione. C’è un problema linguistico, certo, legato alla traduzione. Non abbiamo numerosi traduttori per le lingue extraeuropee, e molti di loro, anche se sanno tradurre egregiamente un testo narrativo o di carattere generale, non sono in grado di affrontare la traduzione di un testo poetico, che richiede delle competenze specifiche aggiuntive, oltre che, oserei dire, una speciale e rara sensibilità.
Ma è anche un problema culturale. La poesia spesso fa riferimento a un patrimonio antropologico, artistico, linguistico, religioso, politico che occorre conoscere – almeno in parte – per avvicinarsi a una comprensione piena del testo poetico. Conoscenze che di solito sono prerogativa degli studiosi o, al massimo, degli immigrati provenienti dai luoghi in questione.
Per questo motivo mi sembra un’operazione coraggiosa la recente pubblicazione del libro della
poetessa ebraica Rachel Bluwstein compiuta da parte dell’editore Interno Poesia. In quanti, tra i
pochi lettori di poesia che ci sono in Italia, saranno in grado di apprezzare – per di più in traduzione – la forza poetica di questa autrice, notissima in Israele, quanto quasi del tutto sconosciuta nel nostro Paese? O forse nei suoi testi è possibile ritrovare delle immagini e delle suggestioni di valore universale, che ha senso proporre oggi in Italia, a quasi un secolo dalla loro scrittura e diffusione?
L’attenta e accurata prefazione di Sara Ferrari, curatrice della raccolta, ci aiuta un po’ a inquadrare l’autrice soprattutto da un punto di vista storico e culturale, oltre che poetico, e ci consente di non arrivare impreparati alla lettura del libro.
Rachel Bluwstein nasce nel 1890 a Saratov, nella Russia europea, e visita per la prima volta la
Palestina nel 1909, mentre era diretta verso Roma. Rimasta incantata dalla bellezza di quei luoghi, decise insieme alla sorella di trasferirvisi. Rachel abbracciò dunque la causa sionista non per fuggire dall’antisemitismo, ma per una libera elezione. Innamoratasi follemente della Palestina, volle contribuire al progetto sionista tramite una delle modalità che stavano maggiormente a cuore ai primissimi pionieri ebraici, ovvero il lavoro dei campi. Si trasferì in una scuola agricola nei pressi del lago di Tiberiade, la cosiddetta Kinneret, luogo che l’autrice celebrò largamente in molte delle sue liriche, connotandola di un significato quasi mistico, legato alla propria esperienza biografica e culturale.
La poesia di Rachel Bluwstein è fortemente legata alla terra. Lavorare e far portare frutto a una terra difficile, non particolarmente fertile (che in passato era stata per lo più destinata a un’agricoltura di mera sussistenza) è segno di un impegno profondo, esprime il desiderio e la determinazione ad affrontare coraggiosamente le avversità, e a mettere a disposizione ogni proprio sforzo e tutte le proprie energie per il bene comune.
Rachel condivide pienamente lo spirito del kibbutz, ovvero il senso di responsabilità nei confronti della collettività espresso tramite il lavoro della terra. Ma riconosce anche di avere la possibilità di dare alla patria un contributo molto più importante tramite la poesia: «Non ti ho cantata, terra mia, / né ho fregiato il tuo nome / con gesta d’eroe / o con spoglie di guerra; / solo un albero le mie mani hanno piantato / sulle placide rive del Giordano, / solo un sentiero hanno tracciato i miei piedi / nella distesa dei campi».
Ovviamente, nel sentire comune, il lavoro della terra è un impegno prioritario rispetto a una
celebrazione poetica. Il lavoro porta il sostentamento, ha natura egualitaria, è un’attività semplice, alla portata di tutti, che non crea disuguaglianze. È dunque giusto che Rachel si dedichi al lavoro, e lei ne è consapevole. Ma sa anche le proprie capacità poetiche le richiedono una profonda responsabilità. Se lei possiede il dono della poesia, può compiere per la propria patria acquisita qualcosa di molto più importante del lavoro agricolo: ha il dovere morale di celebrarla nei propri versi. Ovviamente lo sta già facendo, e già nella seconda strofa di questa poesia si abbandona a immagini particolarmente liriche, che mettono in evidenza la vigorosa forza morale di questa poetessa, spesso celata dietro una apparente patina di soggezione e insicurezza: «È molto misera davvero, / lo so, madre, / è molto misera davvero / l’offerta della tua figlia. / Solo il suono di un trillo di gioia / nei giorni in cui splende la luce / solo un pianto in lontani recessi / sulla tua povertà».
Rachel descrive il proprio canto come una misera offerta, ma lo fa con immagini nitidissime e
suggestive, che negano ciò che sta affermando nel momento stesso in cui lo afferma.
Rachel è in realtà perfettamente consapevole del valore della sua opera, ed è tramite la propria arte che contribuisce nel modo più determinante alla causa sionista. Purtroppo, sebbene fosse molto apprezzata dai lettori (e lo sia ancora oggi in Israele), la critica la relegò sempre a un ruolo marginale rispetto a quello dei poeti maschi votati anch’essi alla causa sionista (in primis Haim Nachman Bialik, considerato il poeta nazionale di Israele, e poi Saul Cernichovskij, un poeta ucraino che si espresse in ebraico ma con una impostazione legata a modelli del romanticismo europeo). Come suggerisce Sara Ferrari nell’introduzione al volume, la sua attitudine mesta e riservata – in gran parte dovuta a un’esistenza che non le risparmiò prove anche molto dure, fino alla morte prematura all’età di quarant’anni a causa della tubercolosi – non consentì inizialmente di riconoscere la sua forza poetica e la sua ragguardevole levatura morale.
Sarebbe sbagliato vedere in Rachel Bluwstein semplicemente una voce del movimento sionista che si andava sviluppando nei primi decenni del ventesimo secolo. Rachel possiede un’individualità che la rende un’artista a tutto tondo, che rivela la propria energia esattamente mentre sembra negare le proprie potenzialità espressive: «Io conosco detti eleganti in abbondanza, / frasi fiorite a non finire / che camminano leziose, / lo sguardo arrogante. // Ma amo l’espressione pura come un neonato / e modesta come la polvere. / Conosco innumerevoli parole, / per questo io taccio. // Saprà il tuo orecchio cogliere, anche dal silenzio, / il mio umile parlare? / Saprai proteggerlo come un amico, un fratello, / come una madre in seno?».
Quello di Rachel è un parlare che nasce dal silenzio, un parlare umile. Ma non perché la poetessa ignori l’arte della parola, il fiorire rigoglioso del linguaggio poetico. Rachel sceglie l’espressione pura e modesta, perché è quella che meglio le consente di esprimere la levità del suo sentire. Non le interessa la voce epica e roboante dei suoi colleghi uomini. È un’intonazione che non le appartiene, che non le consentirebbe di portare verso l’esterno la propria intimità più profonda e sofferta, soffermandosi su immagini inusuali, costantemente in equilibrio sul filo del dolore.
Come quando descrive la moglie del suo amante, mettendo a confronto il proprio ruolo con quello di lei con apparente distacco e impressionante lucidità: «Si volta, chiamandolo per nome. / Nella sua voce il suono della consuetudine. / Ma io nella mia non posso confidare: / chissà cosa si lascerebbe sfuggire. // La via attraversa al suo fianco, / accolta da tutti, alla luce del sole: / io, invece, nell’oscurità delle sere, / nel più fitto mistero».
Il dettato poetico è essenziale, minimalista. Ma è proprio il suo basso profilo a far emergere il
sentimento di mestizia della sua riflessione. Una mestizia che non perde mai la propria dignità. Il
dolore – che pur si percepisce in ogni singola sillaba – non viene nemmeno nominato. Eppure è lì, nascosto nel tono neutro delle parole, eclissato nell’equilibrio delle strofe, in cui viene assegnato con equanimità un distico alla moglie e uno all’amante.
L’immagine più amata e ricorrente della poetessa è quella della Kinneret, il lago di Tiberiade, presso il quale Rachel Bluwstein si trasferì all’età di ventuno anni per andare a lavorare nella cosiddetta «Fattoria delle ragazze». La Kinneret rappresenta dunque per lei la giovinezza, la scoperta dell’amore, il correlativo oggettivo di una pace edenica, iniziale, che si identifica con la parte più profonda della sua anima: «Io sono così: quieta / come le acque del lago, / amo la calma dei giorni ordinari, gli occhi dei neonati / e le poesie di Francis Jammes».
Francis Jammes è un poeta francese nato pochi anni prima di lei, che viene ricordato per la
semplicità dell’universo poetico da lui cantato, per la sua vena fortemente contemplativa, lontana dalla retorica dannunziana che in quegli anni andava per la maggiore.
Rachel affianca la sua poesia alla quiete del lago, all’ordinarietà dei giorni comuni, alla purezza degli occhi dei neonati. Ma non ci si lasci ingannare. Le sue immagini umili, il suo linguaggio essenziale, il suo sentire apparentemente timido, nascondono una personalità gigantesca, capace di trasformare ogni rinuncia in una conquista, di inglobare ogni cosa perduta e consegnarla all’eternità. Il non detto è sempre lì, evidente, riconoscibile, e costituisce la sua eredità per i posteri, l’invisibile patrimonio di bellezza che, come la parte sommersa dell’iceberg, rappresenta la sua potenza e la sua forza dirompente.
Ed è un retaggio profondamente lirico e puro, ma di una purezza che non è una diminutio, bensì una immersione di natura quasi battesimale; una purificazione che assume su di sé lo splendore del creato, e lo fa crescere per far risplendere la propria innocenza.
Come in questa ennesima poesia dedicata alla Kinneret: «Laggiù, in riva al lago, c’è una palma dalla cima modesta, / è tutta scarmigliata, come un bimbetto monello / che è scivolato fino a terra e nelle acque di Kinneret / sciacquetta i piedi. // Quanti fiori sono spuntati d’inverno a Kerak, / il sangue degli anemoni e l’oro del croco, / ci sono giorni che è verde l’erba sette volte tanto, / settanta volte azzurra l’azzurrità del cielo».
Nella simbologia ebraica, il numero sette indica l’infinito, la perfezione. Il numero settanta è una
perfezione moltiplicata. Ecco, la Kinneret è questa perfezione, questa pienezza che Rachel ha
sempre custodito dentro di sé. Anche nei momenti più bui, negli addii struggenti, nell’amara
solitudine. Sempre il ricordo della felicità e della giovinezza ha tenuto accesa nel suo cuore la
speranza e donato dignità alla sua scrittura.
Quando, nell’aprile del 1931, morì sola in ospedale, abbandonata da tutti, sul suo tavolino fu
rinvenuta un’ultima poesia, il cui ultimo verso ci fornisce forse la chiave di interpretazione di tutta la sua opera: «solo ciò che ho perduto sarà mio in eterno».
Quella di Rachel Bluwstein è una poesia in levare, in cui l’artista rinuncia a tutto ciò che sembra
turbarla, per aspirare a una quiete assoluta, immobile e trasparente come le acque del lago di
Tiberiade. Eppure, tutto quello a cui rinuncia – nella propria vita, a livello esperienziale, o nei propri versi, a livello poetico-stilistico –, tutto ciò che lascia volontariamente fuori da ciò che scrive, confluisce silenziosamente nella sua opera, e va ad abitarla per l’eternità.
Luca Alvino è nato a Roma nel 1970. Ha pubblicato Il dettaglio e l’infinito. Roth, Yehoshua e Salter (Castelvecchi, 2018) e Il poema della leggerezza. Gnoseologia della metamorfosi nell’Alcyone di Gabriele d'Annunzio (Bulzoni, 1998). Si interessa di letteratura contemporanea e di poesia. Collabora con il blog minima&moralia.