Il punto fondamentale, dunque, è il concetto di verità in rapporto alla letteratura. Non solo: in rapporto alla persona che scrive letteratura nel momento stesso in cui la sta scrivendo. Io avevo cercato di scrivere qualcosa il più possibile verosimile, vicino al vero; per farlo, avevo però dovuto truccare – passatemi il termine – la storia con elementi di fantasia, avevo dovuto reinterpretarla e gonfiarla con particolari letterari (valga per tutti la testa di forca). Avevo, insomma, dovuto renderla mia vedendomela, come ho scritto poco sopra, da un’altra parte. Ora la telefonata di uno strano tizio venuto dal nulla mi metteva davanti a uno specchio: era, in qualche modo, la personificazione del mio arco narrativo e mi aveva contattato dicendo «Non hai detto la verità».
 Qualche mio illustre collega del passato avrebbe risposto a Simone: «Per forza, la letteratura è una menzogna» e avrebbe riattaccato il telefono. Sono andato a riprendermi proprio il saggio di Manganelli, La letteratura come menzogna. Non ricordavo che comincia così: «Qualche tempo fa, durante una discussione, qualcuno citò: “Finché c’è al mondo un bimbo che muore di fame, fare letteratura è immorale”». Questa cosa mi ha turbato, perché io avevo lavorato proprio su una strage di bambini e non consideravo il mio gesto né immorale né una menzogna. L’attacco di Manganelli mi ha fatto venire in mente quello che scrisse Adorno a proposito della poesia dopo Auschwitz e mi ha fatto venire in mente, anche, che Primo Levi, la poesia, cominciò a farla proprio dopo e forse anche grazie – o nonostante – Auschwitz). Ancora Manganelli: «Forse è vero: la letteratura è immorale, è immorale attendervi. (…) Una piaga purulenta si gonfia in metafora, una strage non è che un’iperbole, la follia un’arguzia per deformare irreparabilmente il linguaggio, scoprirgli moti, gesti, esiti imprevedibili. Ogni sofferenza non è che un modo di disporsi del linguaggio, un suo modo di agire».
Qualche mio illustre collega del passato avrebbe risposto a Simone: «Per forza, la letteratura è una menzogna» e avrebbe riattaccato il telefono. Sono andato a riprendermi proprio il saggio di Manganelli, La letteratura come menzogna. Non ricordavo che comincia così: «Qualche tempo fa, durante una discussione, qualcuno citò: “Finché c’è al mondo un bimbo che muore di fame, fare letteratura è immorale”». Questa cosa mi ha turbato, perché io avevo lavorato proprio su una strage di bambini e non consideravo il mio gesto né immorale né una menzogna. L’attacco di Manganelli mi ha fatto venire in mente quello che scrisse Adorno a proposito della poesia dopo Auschwitz e mi ha fatto venire in mente, anche, che Primo Levi, la poesia, cominciò a farla proprio dopo e forse anche grazie – o nonostante – Auschwitz). Ancora Manganelli: «Forse è vero: la letteratura è immorale, è immorale attendervi. (…) Una piaga purulenta si gonfia in metafora, una strage non è che un’iperbole, la follia un’arguzia per deformare irreparabilmente il linguaggio, scoprirgli moti, gesti, esiti imprevedibili. Ogni sofferenza non è che un modo di disporsi del linguaggio, un suo modo di agire».
Avevo fatto questo, io, con il Demone? Faccio questo, generalmente, quando scrivo? Scrivo per un’insopprimibile impulso alla disobbedienza, al furore, al cinismo, all’indifferenza, a quello che Manganelli chiama «rifiuto dell’anima»? È questo ciò che ha spinto Melville, Dostoevskij, Canetti, a scrivere? I miei inarrivabili maestri sono dei buffoni stronzi e cinici e io non me ne sono mai accorto?
 L’impulso a riprendere queste note e a ragionare nuovamente sul tema della letteratura e del suo rapporto con la realtà e la verità mi è venuto, al di là della voglia di raccontare l’episodio di Simone – che riprenderò e concluderò tra un po’ – dalla lettura (per me sostanzialmente deludente, e spero di riuscire a spiegare il perché) di un piccolo saggio: si chiama Il realismo e l’impossibile e l’ha scritto uno dei migliori scrittori italiani viventi, Walter Siti. Non ho letto tutto ciò che Siti ha scritto, anzi: probabilmente lo conosco molto meno di quanto dovrei e di quanto meriterebbe. La mia delusione è dunque, per così dire, una delusione episodica e legata a un pamphlet che dice e non dice. Siti comincia raccontando un episodio della vita di Dickens tratto dalla biografia dello scrittore inglese scritta da un altro scrittore inglese, Chesterton: c’è Dickens all’interno di un bar londinese che guarda la scritta sul vetro esterno del locale. La scritta dice «coffee room» ma, essendo pensata per chi sta sulla strada, quelli che si trovano all’interno del locale leggono «moor eeffoc». La cosa ha due conseguenze: la prima è che ogni volta che, nella vita, a Dickens capitò di trovarsi all’interno di un locale dove c’era scritto «moor eeffoc», lo scrittore non poteva evitare di rievocare in un colpo, come davanti a una madeleine, la propria giovinezza; la seconda, più importante, è che, per Chesterton e in seguito anche per Siti, quel particolare rovesciato, «contrario» alla realtà immediata della scritta, è una metafora dell’essenza del realismo: «Il realismo» dice Siti «è l’antiabitudine, è uno strappo, un particolare inaspettato che apre uno squarcio nella nostra stereotipia mentale. Realismo è quella postura verbale o iconica che coglie impreparata la realtà». Invito a leggere un articolo di Giorgio Fontana (a cui il Siti è piaciuto) per farsi un’idea di quello che c’è scritto in Il realismo è l’impossibile. Sorvolando sul fatto che Siti cita a più riprese quell’insopportabile trombone di Nabokov, riporto quelli che mi sembrano i passi e i concetti che più concorrono a formare il saggio, in un elenco di estrapolazioni che naturalmente non rende giustizia a Siti e al suo libro: «La verità del mondo vien fuori controvoglia, affermando diritti e desideri che le convenzioni conculcavano», «Parlare del realismo come trasgressione e rottura di codici può apparire contraddittorio rispetto alla cantilena che nei secoli si è ripetuta, del realismo come copia del reale e dell’artista mimetico come scimmia della natura» (qui viene in mente la celebre immagine con cui Cèline spiegava la sua lingua: il bastone immerso nell’acqua), «Nel vero realismo la realtà non è mai qualcosa di ovvio: è sempre in statu nascendi», «la rappresentazione della realtà è efficace se sembra nascondere sempre un altro strato della realtà (…) Se finalmente raggiunta, la realtà-realtà risulta poco credibile dal punto di vista dell’arte», «Il verosimile nasce da questa necessità di selezione: è il repertorio di tutte quelle parti di realtà a cui il lettore può credere senza inciampo perché assomigliano a cose che ha già sperimentato. Il verosimile è il regno del generale e del comune». «le cose che raccontiamo sono vere proprio perché non appaiono verosimili. Realismo e verosimiglianza, in ultima analisi, si scoprono rivali», «In letteratura, molti dettagli sono esplicitamente funzionali al procedere della trama o all’illustrazione di un carattere; ma i particolari realistici in senso pieno, quelli che si moltiplicano da Flaubert in poi, i più vittoriosi e debordanti ma anche i più problematici, sono quelli non funzionali, quelli che non significano niente» (e messi lì dall’autore, sembra dire Siti, per creare un “effetto di realtà”: il barometro di Un coeur simple non serve a nulla, non spiega gli ambienti e non dà dettagli sui personaggi: è lì, semplicemente, perché c’era, perché è vero), «La precisione gergale dei termini marinari non fa di Moby Dick una storia di pesca. Il romanzo realista [Moby Dick romanzo realista?!?] secolarizza il mondo non solo per re-incantarlo; è un progetto scientifico sperimentale ma insieme una reazione infantile, selvaggia, di illusionismo ipnotico. (…) Il realismo oppone la realtà alla Realtà» (vi insinua insomma una semiosi limitata, controllata, trova il simbolico nel quotidiano e lo eleva e lo esplode, lo rende, per come ho capito ciò che Siti ha scritto, un paradigma di qualcos’altro). Insomma, Siti risolve il problema realtà/finzione all’interno dell’opera d’arte con questa intuizione: è solo grazie a una non-verità, a un surplus di fittizio che la finzione riesce a restituire la realtà. La realtà in sé è troppo illimitata, troppo ricca per essere controllata e dunque compresa; la realtà non è funzionale, è semplicemente tutto e il tutto non si può controllare. Quella fetta di vero che la finzione ritaglia e descrive, riempiendola di elementi funzionali e di immaginario e risignificandola e dotandola di valenze simboliche che in sé e per sé non avrebbe, è il modo migliore affinché il mondo risulti descrivibile e comprensibile. Attenzione però: il lato simbolico contenuto negli elementi del reale, una volta riportato sulla pagina sfugge a qualsiasi possibilità di controllo, innesca una semiosi continua, un continuo rimando di senso a dispetto della volontà e della consapevolezza dell’autore, e arricchisce di un ulteriore livello il significato (inteso in senso lato) dell’opera. Fino a quello che, per me, è il passo cruciale di tutto il libro e la frase attorno a cui ruota il mio modo di vedere la letteratura:
L’impulso a riprendere queste note e a ragionare nuovamente sul tema della letteratura e del suo rapporto con la realtà e la verità mi è venuto, al di là della voglia di raccontare l’episodio di Simone – che riprenderò e concluderò tra un po’ – dalla lettura (per me sostanzialmente deludente, e spero di riuscire a spiegare il perché) di un piccolo saggio: si chiama Il realismo e l’impossibile e l’ha scritto uno dei migliori scrittori italiani viventi, Walter Siti. Non ho letto tutto ciò che Siti ha scritto, anzi: probabilmente lo conosco molto meno di quanto dovrei e di quanto meriterebbe. La mia delusione è dunque, per così dire, una delusione episodica e legata a un pamphlet che dice e non dice. Siti comincia raccontando un episodio della vita di Dickens tratto dalla biografia dello scrittore inglese scritta da un altro scrittore inglese, Chesterton: c’è Dickens all’interno di un bar londinese che guarda la scritta sul vetro esterno del locale. La scritta dice «coffee room» ma, essendo pensata per chi sta sulla strada, quelli che si trovano all’interno del locale leggono «moor eeffoc». La cosa ha due conseguenze: la prima è che ogni volta che, nella vita, a Dickens capitò di trovarsi all’interno di un locale dove c’era scritto «moor eeffoc», lo scrittore non poteva evitare di rievocare in un colpo, come davanti a una madeleine, la propria giovinezza; la seconda, più importante, è che, per Chesterton e in seguito anche per Siti, quel particolare rovesciato, «contrario» alla realtà immediata della scritta, è una metafora dell’essenza del realismo: «Il realismo» dice Siti «è l’antiabitudine, è uno strappo, un particolare inaspettato che apre uno squarcio nella nostra stereotipia mentale. Realismo è quella postura verbale o iconica che coglie impreparata la realtà». Invito a leggere un articolo di Giorgio Fontana (a cui il Siti è piaciuto) per farsi un’idea di quello che c’è scritto in Il realismo è l’impossibile. Sorvolando sul fatto che Siti cita a più riprese quell’insopportabile trombone di Nabokov, riporto quelli che mi sembrano i passi e i concetti che più concorrono a formare il saggio, in un elenco di estrapolazioni che naturalmente non rende giustizia a Siti e al suo libro: «La verità del mondo vien fuori controvoglia, affermando diritti e desideri che le convenzioni conculcavano», «Parlare del realismo come trasgressione e rottura di codici può apparire contraddittorio rispetto alla cantilena che nei secoli si è ripetuta, del realismo come copia del reale e dell’artista mimetico come scimmia della natura» (qui viene in mente la celebre immagine con cui Cèline spiegava la sua lingua: il bastone immerso nell’acqua), «Nel vero realismo la realtà non è mai qualcosa di ovvio: è sempre in statu nascendi», «la rappresentazione della realtà è efficace se sembra nascondere sempre un altro strato della realtà (…) Se finalmente raggiunta, la realtà-realtà risulta poco credibile dal punto di vista dell’arte», «Il verosimile nasce da questa necessità di selezione: è il repertorio di tutte quelle parti di realtà a cui il lettore può credere senza inciampo perché assomigliano a cose che ha già sperimentato. Il verosimile è il regno del generale e del comune». «le cose che raccontiamo sono vere proprio perché non appaiono verosimili. Realismo e verosimiglianza, in ultima analisi, si scoprono rivali», «In letteratura, molti dettagli sono esplicitamente funzionali al procedere della trama o all’illustrazione di un carattere; ma i particolari realistici in senso pieno, quelli che si moltiplicano da Flaubert in poi, i più vittoriosi e debordanti ma anche i più problematici, sono quelli non funzionali, quelli che non significano niente» (e messi lì dall’autore, sembra dire Siti, per creare un “effetto di realtà”: il barometro di Un coeur simple non serve a nulla, non spiega gli ambienti e non dà dettagli sui personaggi: è lì, semplicemente, perché c’era, perché è vero), «La precisione gergale dei termini marinari non fa di Moby Dick una storia di pesca. Il romanzo realista [Moby Dick romanzo realista?!?] secolarizza il mondo non solo per re-incantarlo; è un progetto scientifico sperimentale ma insieme una reazione infantile, selvaggia, di illusionismo ipnotico. (…) Il realismo oppone la realtà alla Realtà» (vi insinua insomma una semiosi limitata, controllata, trova il simbolico nel quotidiano e lo eleva e lo esplode, lo rende, per come ho capito ciò che Siti ha scritto, un paradigma di qualcos’altro). Insomma, Siti risolve il problema realtà/finzione all’interno dell’opera d’arte con questa intuizione: è solo grazie a una non-verità, a un surplus di fittizio che la finzione riesce a restituire la realtà. La realtà in sé è troppo illimitata, troppo ricca per essere controllata e dunque compresa; la realtà non è funzionale, è semplicemente tutto e il tutto non si può controllare. Quella fetta di vero che la finzione ritaglia e descrive, riempiendola di elementi funzionali e di immaginario e risignificandola e dotandola di valenze simboliche che in sé e per sé non avrebbe, è il modo migliore affinché il mondo risulti descrivibile e comprensibile. Attenzione però: il lato simbolico contenuto negli elementi del reale, una volta riportato sulla pagina sfugge a qualsiasi possibilità di controllo, innesca una semiosi continua, un continuo rimando di senso a dispetto della volontà e della consapevolezza dell’autore, e arricchisce di un ulteriore livello il significato (inteso in senso lato) dell’opera. Fino a quello che, per me, è il passo cruciale di tutto il libro e la frase attorno a cui ruota il mio modo di vedere la letteratura:
«Perché, avendo a disposizione millenni di storia e decenni di cronaca, un narratore sente il bisogno di inventarsi una storia in più, una storia che non è mai accaduta ma sarebbe potuta accadere? Perché questa storia fittizia, per qualche causa oscura, è più esemplare delle storie vere, contiene più significati in un rapporto più coerente e armonioso; perché può ammaestrare e far capire cose giacciono nell’inconscio personale e collettivo; perché la realtà così alterata e messa in forma è più buffa, o più tragica, o più commuovente di quanto la realtà nuda e cruda non sia stata mai. La narrazione fittizia ci offre un cosmo e non un caos, una realtà controllabile e finita, un facsimile di realtà commisurato a quegli dèi minori che crediamo di essere nei nostri deliri di onnipotenza. L’universo alternativo della narrazione è composto da molti meno elementi dell’universo reale; il mondo rappresentato in un racconto fittizio è sempre frutto di una selezione».
 Nel Passeggiatore solitario, saggio sui generis che ha dedicato alla figura di Robert Walser, W.G. Sebald osserva una sequenza di fotografie dello scrittore svizzero e, improvvisamente, scopre che «il modo in cui lo scrittore se ne sta lì sullo sfondo del paesaggio suscita immancabilmente e spontaneamente il ricordo di mio nonno». L’effigie di Robert Walser è uguale a quella del nonno di Sebald. Poco più avanti, Sebald racconta dello stupore che ha provato leggendo dei passi di un libro di Walser: c’è una scena esattamente uguale a una che lo stesso Sebald aveva scritto poco tempo prima – naturalmente senza aver ancora letto quel libro di Walser; ancora, in quello stesso racconto dove Sebald ha “copiato” senza saperlo Robert Walser è contenuta un’espressione («curriculum di dolori») che Sebald immaginava di aver inventato: la ritrova invece in Walser, due pagine più avanti la scena “copiata”.
Nel Passeggiatore solitario, saggio sui generis che ha dedicato alla figura di Robert Walser, W.G. Sebald osserva una sequenza di fotografie dello scrittore svizzero e, improvvisamente, scopre che «il modo in cui lo scrittore se ne sta lì sullo sfondo del paesaggio suscita immancabilmente e spontaneamente il ricordo di mio nonno». L’effigie di Robert Walser è uguale a quella del nonno di Sebald. Poco più avanti, Sebald racconta dello stupore che ha provato leggendo dei passi di un libro di Walser: c’è una scena esattamente uguale a una che lo stesso Sebald aveva scritto poco tempo prima – naturalmente senza aver ancora letto quel libro di Walser; ancora, in quello stesso racconto dove Sebald ha “copiato” senza saperlo Robert Walser è contenuta un’espressione («curriculum di dolori») che Sebald immaginava di aver inventato: la ritrova invece in Walser, due pagine più avanti la scena “copiata”.
Io sto per cominciare un libro il cui spunto di partenza fondamentale è proprio l’imprevista somiglianza tra due persone: mio nonno materno e colui che sarà al centro della narrazione. L’idea della Calligrafia, che è un libro di fantasia e di personaggi inventati, traeva origine da una foto trovata su un quotidiano:
Posso dire che tutto quello che ho scritto finora – se si eccettua il romanzo breve Marialuce, che è e rimane un unicum nella mia produzione anche per le condizioni in cui è nato, e che comunque ha avuto bisogno delle biografie di Beethoven e di Glenn Gould per essere scritto – tutto ciò che ho prodotto fin qui (e, per quanto ne so, tutto ciò che sto per produrre da qui in avanti) è figlio di un lampo, di un’immagine, di uno spunto inatteso proveniente dalla realtà e in qualche modo trasfigurato, reso mio. Alcune delle scene che più mi fanno soffrire del Demone (la donna che allatta, le bottiglie di plastica vuote nella palestra) sono vere. O meglio, sono una mia riscrittura di qualcosa che è successo davvero. Esiste nel mondo (o è esistita) una donna che per non prendersi la mastite ha dovuto dare il suo latte ai bambini prigionieri, esistono tuttora delle persone (sopravvissuti, parenti di vittime) che portano bottiglie vuote nella palestra sventrata di Beslan perché per tre giorni i terroristi non hanno dato da bere ai bambini. Tutto è vero, non ho inventato nulla: ciò che c’è di mio in passi come quelli è la lingua, ovviamente, la voce, il modo in cui sono raccontati, la scelta di inserirli in un punto piuttosto che un altro dell’intreccio e di farli raccontare da questo o da quel personaggio. Ma la realtà è lì, c’è, e se l’ho trasfigurata è stato solo per poterla raccontare. La realtà infatti, a volte, è talmente carica di simboli e di semiosi che non ha bisogno di essere inventata: basta sceglierla e avvicinarla. È ovvio, come scrive anche Siti, che per scriverla bisogna passare per un processo di selezione (questo lo racconto/questo no, questo lo metto in evidenza/questo lo lascio nell’ombra per farlo magari riemergere all’improvviso, questo lo faccio raccontare dal personaggio x, che ha una voce particolare e così via), ma vista la mia esperienza diretta io non sarei in grado di dire che i mondi fittizi siamo migliori, dal punto di vista narrativo e di significato, di quello reale. Credo cioè di fare il percorso esattamente inverso a quello reclamato da Siti nel suo saggio e nei suoi libri: mi si perdoni la banalizzazione, ma a me pare che quello che si dice in Il realismo è l’impossibile è che il lavoro di uno scrittore realista consiste nell’inventare un mondo fittizio, chiuso e ricco di senso e di “effetto di reale” con il quale raccontare un pezzo di quella semiosi illimitata che è il mondo; per me, scrivere è in qualche modo l’esatto contrario: trovo nella realtà un paradigma già fatto e lo scrivo, aggiungendovi il fittizio per poterlo raccontare. (Posso assicurare che sono anni che tento di scrivere questa frase tanto banale e sciocca, e solo adesso ci sono riuscito). In una biblioteca di Verona, a metà degli anni Ottanta, W.G. Sebald si trova seduto e sfoglia i quotidiani dei mesi di luglio e agosto 1913: in quell’estate, infatti, pare che sulle rive del Garda si sia preso una breve vacanza, a scopi anche curativi, nientemeno che Kafka. L’episodio di Sebald in biblioteca è contenuto nel secondo dei quattro racconti che compongono Vertigini; il titolo del terzo racconto, ça va sans dire, è Il dottor K. in viaggio alle terme di Riva. All’interno di un libro, uno scrittore racconta di se stesso mentre fa delle ricerche per un episodio storico che lo incuriosisce e su cui, forse (Sebald non lo specifica mai chiaramente), ha intenzione di scrivere. Mentre studia, tra l’altro, riporta intuizioni come questa: «Continuando a leggere e a sfogliare i giornali fino al tardo pomeriggio, scoprii alcuni episodi che, all’occasione, meriterebbero un racconto; fra gli altri l’articolo dal titolo “Ucciso sul banco anatomico”, che iniziava con queste parole degne di una novella: Ieri sera nella cella mortuaria del cimitero di Nogara, e nel quale si parlava dell’omicidio di un carabiniere di nome Muzio». Nello stesso libro, poi, compare il racconto di cui il lettore, a questo punto, conosce almeno in parte il lavoro preparatorio. Ecco, in un certo senso, scrivere è questo.
Una frase che mi stordisce e mi commuove: «Il tempo si trascina come un elefante e i cani mi strappano il cuore». È di Werner Herzog, che non è uno scrittore ma ha scritto libri bellissimi.
 Gli snodi attorno cui si muove il mio lavoro sono, come credo di aver già accennato, punto di vista e voce. Ce n’è un altro, che è per così dire meno “tecnico”, ma che ha a che fare in modo diretto con la presa di voce: si tratta del diritto di prendere parola. Uno scrittore davanti alla pagina bianca, con il suo racconto da cominciare, non è semplicemente qualcuno che deve riempire dei fogli con una storia e delle immagini: è qualcuno che, implicitamente, sta chiedendo il permesso di parlare, che deve giustificare il fatto che vuole dire qualcosa e vuole farsi leggere. È qualcuno che, in sostanza, avanza una richiesta di attenzione e che, per farlo, deve averne il diritto. Nelle Voci di Marrakech, Canetti racconta a un certo punto di una sera in cui, mentre attraversa a piedi da solo la Djema-al-Fna, la sua attenzione viene catturata da un nugolo di persone raccolte in un punto della piazza. Si avvicina e, benché sia l’unico occidentale, all’inizio non viene notato da nessuno: le persone sono disposte in cerchio e al centro del cerchio c’è un vecchio, un cantastorie che sta raccontando qualcosa. Benché Canetti non capisca nulla del racconto, viene rapito dalla cantilena berbera del vecchio e per alcuni minuti perde coscienza di dove si trova, del perché e persino del fatto che non capisca una parola. Improvvisamente, il racconto si interrompe in modo brusco. Come azionati da un meccanismo, gli spettatori cominciano immediatamente a frugarsi nelle tasche alla ricerca di qualche dirham, che rovesciano in un cappello che un ragazzino, l’aiutante del cantastorie, fa girare tra la piccola folla. Una volta che il cappello è pieno di monete, il vecchio ricomincia il suo racconto – presumibilmente dal punto in cui l’aveva interrotto. Questa scena, che è vera, perché non è capitato di vederla solo a Canetti ma anche a me, quando sono andato a Marrakech, dice, mi pare, pressoché tutto quel che c’è da dire sul rapporto tra scrittore e lettore e sulla questione del diritto alla presa di voce: l’autore davanti alla pagina bianca (e, tempo dopo, sul banco di una libreria) chiede al lettore di riempirgli il cappello affinché la narrazione possa cominciare o andare avanti; il lettore, gettando la sua moneta nel cappello, accorda questo diritto e, allo stesso tempo, chiede di essere reso partecipe della storia. E tuttavia, se la storia in questione non merita di essere raccontata o, peggio, è una storia che non deve essere raccontata in quel modo da quella persona, il cappello deve rimanere vuoto.
Gli snodi attorno cui si muove il mio lavoro sono, come credo di aver già accennato, punto di vista e voce. Ce n’è un altro, che è per così dire meno “tecnico”, ma che ha a che fare in modo diretto con la presa di voce: si tratta del diritto di prendere parola. Uno scrittore davanti alla pagina bianca, con il suo racconto da cominciare, non è semplicemente qualcuno che deve riempire dei fogli con una storia e delle immagini: è qualcuno che, implicitamente, sta chiedendo il permesso di parlare, che deve giustificare il fatto che vuole dire qualcosa e vuole farsi leggere. È qualcuno che, in sostanza, avanza una richiesta di attenzione e che, per farlo, deve averne il diritto. Nelle Voci di Marrakech, Canetti racconta a un certo punto di una sera in cui, mentre attraversa a piedi da solo la Djema-al-Fna, la sua attenzione viene catturata da un nugolo di persone raccolte in un punto della piazza. Si avvicina e, benché sia l’unico occidentale, all’inizio non viene notato da nessuno: le persone sono disposte in cerchio e al centro del cerchio c’è un vecchio, un cantastorie che sta raccontando qualcosa. Benché Canetti non capisca nulla del racconto, viene rapito dalla cantilena berbera del vecchio e per alcuni minuti perde coscienza di dove si trova, del perché e persino del fatto che non capisca una parola. Improvvisamente, il racconto si interrompe in modo brusco. Come azionati da un meccanismo, gli spettatori cominciano immediatamente a frugarsi nelle tasche alla ricerca di qualche dirham, che rovesciano in un cappello che un ragazzino, l’aiutante del cantastorie, fa girare tra la piccola folla. Una volta che il cappello è pieno di monete, il vecchio ricomincia il suo racconto – presumibilmente dal punto in cui l’aveva interrotto. Questa scena, che è vera, perché non è capitato di vederla solo a Canetti ma anche a me, quando sono andato a Marrakech, dice, mi pare, pressoché tutto quel che c’è da dire sul rapporto tra scrittore e lettore e sulla questione del diritto alla presa di voce: l’autore davanti alla pagina bianca (e, tempo dopo, sul banco di una libreria) chiede al lettore di riempirgli il cappello affinché la narrazione possa cominciare o andare avanti; il lettore, gettando la sua moneta nel cappello, accorda questo diritto e, allo stesso tempo, chiede di essere reso partecipe della storia. E tuttavia, se la storia in questione non merita di essere raccontata o, peggio, è una storia che non deve essere raccontata in quel modo da quella persona, il cappello deve rimanere vuoto.
Io impiego mesi, a volte anni, per capire come riempire quel cappello, e a volte devo confessare che non lo capisco fino in fondo. Dunque scrivere è, a volte, un azzardo. La voce, il diritto alla voce è pressoché tutto in letteratura: viene prima della storia, della trama, dei personaggi, dei significati, del lavoro di selezione della (dalla) realtà. Perché scrivo? Perché voglio dare voce proprio a questa vicenda? Che diritto ho, io, di parlarne? Cosa mi spinge e mi consente di stare fermo per anni su una vicenda che, almeno in senso stretto, non mi appartiene? Per quanto riguarda il Demone, ho accennato a questo tipo di dubbi poco sopra: ero perfettamente consapevole che, scrivendolo, avrei messo il dito in una piaga ancora aperta della storia recente – una piaga che, al di là dell’aspetto emotivo e intellettuale, non mi aveva coinvolto o toccato da vicino. Continuamente pensavo a come avrei potuto giustificare questa mia invasione al cospetto di una madre di Beslan. La madre di Beslan – una madre che è tutte le madri – mi ha ossessionato a lungo: io, dal mio punto di vista, scrivendo facevo un torto a lei e a suo figlio morto. A questo dovevo aggiungere il fatto che una verità univoca e inconfutabile sui tre giorni nella palestra non esiste: sbagliando la versione della verità su cui basarmi, avrei fatto un torto doppio a quelle madri. Dunque, per molto tempo, non ho scritto.
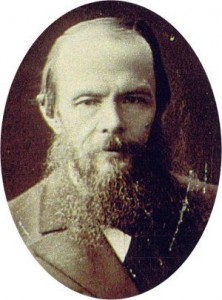 Poi, un giorno, in un momento del tutto inaspettato, mi è arrivata una voce: in modo sottile, quasi sussurrato, questa voce diceva «Sei tu? Sei stato tu?»; era, entro un certo margine, l’equivalente di una delle frasi guida del libro, che è tratta dal finale dei Demoni di Dostoevskij e che io metto in bocca al mio narratore a pagina uno: «Non si incolpi nessuno, sono io». Pochi giorni dopo ne è arrivata un’altra, ma questa era quasi incomprensibile: era la voce di un vecchio che, chino su se stesso, sfregandosi indice e pollice cercava un gatto e chiamava «Miciomiciomiciomicio». Non so spiegare come (grazie a dio non tutto è spiegabile) ma immediatamente ho capito che queste due voci altre dovevano in qualche modo entrare nel libro e che, anzi, ne sarebbero state l’ossatura in termini di struttura e di etica. Il file della prima versione del romanzo, per essere chiari fino in fondo, si intitola Tre voci. Insomma, come giustificavo, io, il racconto in prima persona di uno degli eventi più terribili di tutti i tempi sul quale, lo ripeto, non esiste per di più un’unica e inconfutabile versione? Restituendo una realtà il più possibile spaccata, tridimensionale, dove tre (e più) voci si rincorrono, si contestano, ritornano l’una sui passi dell’altra e riraccontano la vicenda, i singoli episodi da un’altra prospettiva. Il punto di vista, la pluralità delle voci mi davano il diritto di prendere voce. Per permettermi tutto questo, ho avuto bisogno di un’ulteriore livello di approfondimento: ho cambiato i nomi. Non esiste e non è mai esistito (che io sappia) un Marat Bazarev. Non esiste e non è mai esistita gran parte dei nomi con cui ho chiamato gli altri membri della cellula cui Marat appartiene: da degli evidenti assurdi come Afelio e Perielio a nomi e cognomi mutuati dai libri e dagli autori che amo, i trentadue terroristi portano con sé, nel nome, un bagaglio di significati che nella mia testa li estrae (e li astrae) dal semplice livello della cronaca per inserirli nel complicato vortice della letteratura degli ultimi due secoli. In questo modo, i miei personaggi – avessero una connessione stretta con persone realmente esistite o fossero, come il vecchio Ivan che cerca il suo gatto, personaggi inventati tout court – entravano nella vicenda carichi di simboli («di tritolo e di segni», come faccio dire a Marat mentre con il suo gruppo si avvicina alla palestra). È anche grazie a loro, dunque, che ho operato quella selezione di simboli a cui fa riferimento Siti quando parla del realismo. La differenza tra me e lui consiste nel diverso punto di partenza da cui operiamo una selezione della realtà: in lui, per così dire, si tratta di una selezione completa: trova una storia totalmente fittizia che sia uno specchio (deformato e deformante) della realtà e vi si muove come all’interno di un ordo. Io – lo sto facendo anche nel libro nuovo – prendo il caos della realtà e lo piego in maniera simbolica alle esigenze di quello che è, in ultima analisi, comunque un racconto fictional. Si tratta di percorsi totalmente speculari, anche se fatico a dire quale dei due sia «coffee room» e quale «moor eeffoc».
Poi, un giorno, in un momento del tutto inaspettato, mi è arrivata una voce: in modo sottile, quasi sussurrato, questa voce diceva «Sei tu? Sei stato tu?»; era, entro un certo margine, l’equivalente di una delle frasi guida del libro, che è tratta dal finale dei Demoni di Dostoevskij e che io metto in bocca al mio narratore a pagina uno: «Non si incolpi nessuno, sono io». Pochi giorni dopo ne è arrivata un’altra, ma questa era quasi incomprensibile: era la voce di un vecchio che, chino su se stesso, sfregandosi indice e pollice cercava un gatto e chiamava «Miciomiciomiciomicio». Non so spiegare come (grazie a dio non tutto è spiegabile) ma immediatamente ho capito che queste due voci altre dovevano in qualche modo entrare nel libro e che, anzi, ne sarebbero state l’ossatura in termini di struttura e di etica. Il file della prima versione del romanzo, per essere chiari fino in fondo, si intitola Tre voci. Insomma, come giustificavo, io, il racconto in prima persona di uno degli eventi più terribili di tutti i tempi sul quale, lo ripeto, non esiste per di più un’unica e inconfutabile versione? Restituendo una realtà il più possibile spaccata, tridimensionale, dove tre (e più) voci si rincorrono, si contestano, ritornano l’una sui passi dell’altra e riraccontano la vicenda, i singoli episodi da un’altra prospettiva. Il punto di vista, la pluralità delle voci mi davano il diritto di prendere voce. Per permettermi tutto questo, ho avuto bisogno di un’ulteriore livello di approfondimento: ho cambiato i nomi. Non esiste e non è mai esistito (che io sappia) un Marat Bazarev. Non esiste e non è mai esistita gran parte dei nomi con cui ho chiamato gli altri membri della cellula cui Marat appartiene: da degli evidenti assurdi come Afelio e Perielio a nomi e cognomi mutuati dai libri e dagli autori che amo, i trentadue terroristi portano con sé, nel nome, un bagaglio di significati che nella mia testa li estrae (e li astrae) dal semplice livello della cronaca per inserirli nel complicato vortice della letteratura degli ultimi due secoli. In questo modo, i miei personaggi – avessero una connessione stretta con persone realmente esistite o fossero, come il vecchio Ivan che cerca il suo gatto, personaggi inventati tout court – entravano nella vicenda carichi di simboli («di tritolo e di segni», come faccio dire a Marat mentre con il suo gruppo si avvicina alla palestra). È anche grazie a loro, dunque, che ho operato quella selezione di simboli a cui fa riferimento Siti quando parla del realismo. La differenza tra me e lui consiste nel diverso punto di partenza da cui operiamo una selezione della realtà: in lui, per così dire, si tratta di una selezione completa: trova una storia totalmente fittizia che sia uno specchio (deformato e deformante) della realtà e vi si muove come all’interno di un ordo. Io – lo sto facendo anche nel libro nuovo – prendo il caos della realtà e lo piego in maniera simbolica alle esigenze di quello che è, in ultima analisi, comunque un racconto fictional. Si tratta di percorsi totalmente speculari, anche se fatico a dire quale dei due sia «coffee room» e quale «moor eeffoc».
In ogni caso, su questa complicata serie di simboli e rimandi tra il mondo vero e il mondo della finzione, un giorno si è innestato Simone con la sua storia. Io ero partito da un fatto reale, che avevo piegato al romanzo mantenendomi però fedele ad alcune dinamiche: la scansione temporale, per esempio, o le scene madri, non sono inventate. Di inventato, nel libro, al di là delle voci e della biografia personale di Marat, ci sono alcuni episodi (la mamma con i due bambini a cui Marat dà il coltello, le storie delle vedove – che sono però tutte più o meno paradigmatiche di una condizione e che per questo sono scritte tutte con tecniche diverse – e così via). Tutto il resto, più che inventato, è trasfigurato. Su questo impianto, che, dicevo, parte dal reale e prova a restituirlo in forma romanzata, la strana telefonata di Simone rischiava di agire come un terremoto: qualcuno era venuto a dirmi che non avevo scritto la verità. La realtà, insomma, veniva a impattare violentemente contro una finzione che l’aveva sì trasfigurata, ma che ad essa si pensava ancorata da più di un motivo.
La prima parte è qui.
Mario de Laurentiis (Napoli 1969 – Segrate 2666).

