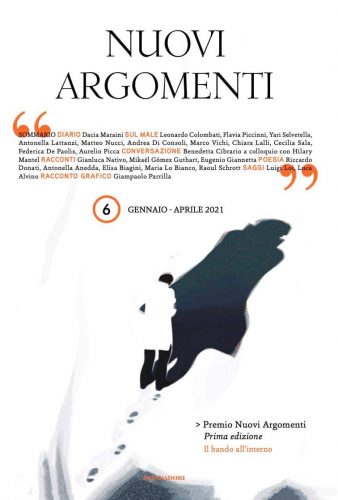Quella che segue è la nota introduttiva di Riccardo Donati ad una mini-antologia di poesie di Antonella Anedda, curata da Donati ma sulla base di un’ampia auto-antologia precedente composta dall’autrice, che apre la sezione ‘Poesia’ del numero di “Nuovi Argomenti” (gennaio-aprile 2021), da oggi in libreria. La pubblichiamo di seguito.
«Io credo che il nostro compito… forse addirittura il nostro dovere… sia di… – la sua voce si fece calma, matura, – sopportare il peso del mistero con tutta la grazia possibile». Questa, nella traduzione di Susanna Basso, la conclusione cui giunge l’avvocato Suzanne, un personaggio del romanzo Olive, ancora lei di Elizabeth Strout (Einaudi, 2020). Un compito/dovere non dissimile da quello che l’opera di Antonella Anedda – un classico contemporaneo, come è stata giustamente definita – si pone sin dall’esordio di Residenze invernali (1989). In trent’anni di lavoro la poetessa romana, ma di origini sarde, non ha mai tradito il mandato che si è data: cercare un luogo per la parola, uno spazio da sterrare diverso da quello occupato dalla letteratura piattamente mimetica, schiacciata sulla cronaca, e insieme alternativo a ogni idea astratta e impalpabile – per eccesso di sublimazione, teoresi o formalismo – di prassi creativa. Ad Anedda non interessa, ben lo chiarisce il verso incipitario di Pelle, polvere, essere riconosciuta come «autrice», preferisce definirsi «scriba», ossia qualcuno incaricato di annotare la realtà, di prendersi cura del mondo per verba, mosso insieme da un’esigenza intima e da un dovere testimoniale. La scrittura, dunque, come gesto etico, incompatibile con ogni forma di declamazione estatica o benintenzionata, inconciliabile con il ghigno compiaciuto dei postmoderni: un impegno arduo, che impone di tenersi vicini alla datità dell’esistenza, studiando e studiandosi, creando nessi fra le cose, mantenendo viva una ragione a cui non si può rinunciare ma che neppure dev’essere deificata. È questo, oggi, uno dei pochi modi di fare della “poesia onesta”, per riprendere un celebre sintagma di Umberto Saba: tentare di sottrarsi quanto più possibile al cerchio asfittico dei narcisismi celebrativi dell’io, smorzare le spinte egolatriche a vantaggio di una percezione quanto più possibile collettiva e complessiva dell’esistenza. La scrittura, dunque, come atto di sottrazione e in certa misura di abnegazione – sempre a Leopardi torna, fatalmente, la migliore poesia italiana – attraverso un disciplinamento della voce che comporta una verifica permanente delle proprie responsabilità autoriali e un costante affinamento degli strumenti retorico-stilistici maneggiati.
L’aspirazione alla precisione, all’essenzialità, al rigore formale, attenuando ogni impeto effusivo e pienezza del canto a vantaggio di una pertinace onestà intellettuale e di una pudica reticenza, sono costanti dell’opera di Anedda. Ben lo dimostrano i fatti linguistici: un italiano volutamente anonimo, atonale, il suo, che accantona quanto del lessico patrio la Storia ha reso impronunciabile e si apre invece volentieri all’apporto di altri idiomi, chiamati ad asciugare (lessicalmente e sintatticamente) la lingua madre e insieme a nutrirla, ad arricchirla, quando non ad affiancarla, come nel caso della Limba. Sorta di koiné delle molte parlate sarde, la “limba” cui la poetessa ricorre in alcuni dei suoi testi più suggestivi è una postura, ancor prima che un vocabolario, in parte ereditata – l’intenso legame col paesaggio aspro ed essenziale di una delle più remote e belle isole italiane, La Maddalena, ha profondi riflessi emotivi nella sua scrittura e sostanzia molte delle sue ragioni anche militanti – in parte inventata, rielaborata sotto forma di originale idioletto creativo.
Sul piano dei temi, come si evince anche da questa antologia minima, Anedda lavora su un’originale declinazione quotidiana del lirico, dove schegge di esperienza privata e tracce dell’esistenza più ordinaria (i piccoli oggetti, i gesti d’ogni giorno, il mondo alla tv o fuori dal balcone) sollecitano interrogativi esistenziali e producono un severo confronto con la violenza della storia, con i fenomeni epocali e le trasformazioni in atto nella società. La sua poesia è infatti da sempre in ascolto dei dimenticati, dei vinti, di quanti non hanno «raggiunto il [loro] destino», di quello che con Walter Benjamin possiamo chiamare “il passato oppresso”. Lo spazio della pagina diventa per lei una radura di luce nella notte del mondo in cui preservare gli scarti e le rovine, restituire la parola a tutto ciò che inesorabilmente frana, per calcolo o noncuranza, verso l’oblio. Un atteggiamento, questo, che esclude a priori ogni esaltata celebrazione della Eternità dell’Arte, così come la pretesa romantico-idealistica che basti una poesia per restituire unità all’ordine spezzato delle cose: e ben lo vediamo in testi come A mia figlia o Pelle, polvere, dove l’ombra di distruzione che il tempo proietta su ogni vita e ogni cosa è sempre più spesso pensata, contemplata e in qualche misura accolta come dato non solo ineluttabile ma addirittura confortante. La danza degli atomi e delle cellule che continuamente si aggregano e disaggregano in un infinito gioco di dispersione e ricombinazione può essere affascinante e finanche accettabile nel momento in cui dimostra in modo palmare l’assurdità di ogni pretesa antropocentrica, finalistica, trionfalistica, come Lucrezio e Leopardi non smettono di insegnare.
L’umana partecipazione dei suoi versi alle vicende e al destino comuni muovono semmai dalla convinzione che quello espressivo non sia e non possa in alcun modo essere un gesto solipsistico, autosufficiente, ma imponga la fuoriuscita dal limitato perimetro dell’io per abbracciare la dimensione collettiva, anzi corale, dell’esistenza. L’aspirazione a «perdersi in altri corpi» è non solo e non tanto un tentativo di resistere alla morte, fantasticando su un’impossibile reversibilità del tempo, quanto il bisogno di liquidare ogni sciocca presunzione di immortalità e onnipotenza, foriera di quella pretesa di dominio che è il motore di tanta parte della violenza della storia. «L’intelligenza di cui facciamo vanto / risputa il passato nel presente», scrive Anedda in un testo di Historiae: eccolo il benjaminiano “passato oppresso”, quel rimosso-non-removibile che stupidamente ci ostiniamo a perpetuare nel nostro presente aureolato di magnifiche sorti e progressive. È questa la laica “grazia” di una scrittura che si predispone ad accogliere la realtà nella sua intrinseca incertezza, fragilità, povertà; è questo il compito/dovere della “poesia onesta” praticata da una “scriba” che non scrive di qualcuno o qualcosa ma scrive per, scrive a causa di, scrive in onore di un’umanità offesa e privata della parola, di una natura mai idolatrata ma lucidamente considerata, e amata, come l’orizzonte ineludibile in cui si consuma ogni destino biologico e, in definitiva, il destino stesso della specie. Una poesia che, nel suo farsi, già lascia traccia del proprio avvenire, del suo essere destinata a restare: ecco cos’è un “classico contemporaneo”.