Padreterno, uscito nel 2015 per Einaudi, è un romanzo che parla di violenza con la voce di un uomo che la agisce. Raccontandosi giorno dopo giorno al padre morente, il protagonista Aristeo fa i conti con sé stesso e con i modelli che ha ereditato, confrontandosi con le parole, scritte su degli scontrini, che gli ha consegnato nel tempo Nina, la donna che dice di amare e che ora non c’è più.
Caterina Serra (già autrice di Tilt, Einaudi, 2008, oltreché sceneggiatrice di documentari e film di finzione) mette in campo uno sguardo spiazzante e disturbante, che riproduce e critica allo stesso tempo l’immaginario patriarcale. Padreterno è un viaggio dentro la coscienza intermittente di un uomo che affronta per la prima volta le dinamiche di potere nel rapporto amoroso, nel tentativo – inaugurale, imperfetto – di trovare gli strumenti per non essere più quello che è stato.
Ho incontrato Caterina Serra a Venezia, sua città d’adozione dopo molti anni passati in Inghilterra. Qui porta avanti progetti di scrittura, sceneggiatura e fotografia, ed è attiva nella rete locale del movimento femminista Non una di meno. Ci siamo sedute a un bar al riparo dai turisti, dove conosce tutti e dove tutti la salutano, per parlare di Padreterno, di violenza, di potere, di femminismo e di scrittura.
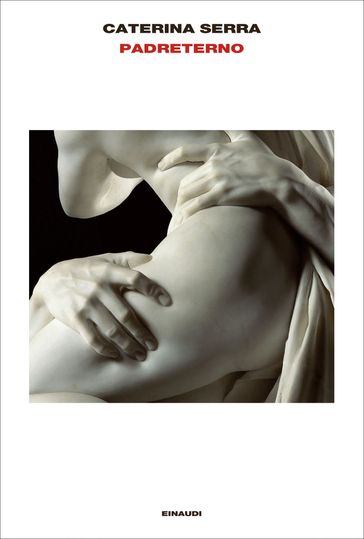
Che tipo di percorso hai fatto per immedesimarti nella voce di un uomo violento?
Ho fatto molte interviste. Partivo da un documentario del 2010, Parla con lui, in cui come sceneggiatrice davo spazio per la prima volta alla voce degli uomini per parlare della violenza contro le donne. Gli uomini intervistati continuavano a dirmi: “Non ho le parole per dirlo, lei mi accusa di questo, ma io non riconosco che è violenza”. Non riconoscevano che i loro atti, il loro modo di stare al mondo, erano violenti rispetto alle donne. In realtà questi uomini non si raccontavano mai, non sapevano come farlo. Allora mi è venuta voglia di provare a farlo io, questo racconto. E così mi sono messa in ascolto degli uomini della mia vita, di quelli che incontravo, al bar, all’università; tutti i luoghi avevano a che fare con la narrazione maschile rispetto alla relazione amorosa. Naturalmente la questione non era solo le parole per dirlo, era anche il corpo, era il desiderio, la narrazione sessuale, culturale, storica, educativa, cioè da dove viene un uomo quando parla e agisce in un certo modo. E a quel punto mi sono detta che forse con quest’attenzione profonda, verticale, potevo cominciare a ragionare, a guardare, come un uomo. Non ho detto, so cos’è, ho detto, comincio a farlo e vediamo dove va.
Aristeo è un uomo molto intelligente. Lui ha le parole?
Aristeo è un filosofo come suo padre, che è un modello di uomo patriarcale e violento. Ho voluto che avessero a che fare con le parole. Un filosofo cerca di vedere le cose e ne ricerca i nomi. Mi incuriosiva molto l’idea che ci fosse un uomo che possiede le parole, ma non le ha per sé, per definire sé e il suo rapporto con l’amore, e con il potere. Non le ha perché la società non le ha, il sistema che ha ereditato non ha mai raccontato così la violenza, non l’ha nominata. L’ha chiamata raptus, follia, rabbia, malattia, natura. Sì, violenza perfino come fatto naturale, connaturato.
Anche Nina è rappresentata come una donna molto intelligente, che contesta Aristeo e rivendica libertà. Però rimane per un lungo periodo in una relazione violenta. Perché? Che donna è Nina?
Nina sfida Aristeo tutto il tempo. Lo ama, non si accontenta come le madri e le nonne che non mettevano energie nella relazione d’amore perché tanto non sarebbero arrivate da nessuna parte. Nina, nella relazione d’amore, vuole il meglio di lui. E questa è la sfida di una donna che, rispetto alle donne del passato, stima un uomo, pensa che possa avere uno scatto, uno sguardo diverso rispetto a lei e al mondo. Lui però non accetta questa spinta, perché lo mette in una posizione scomoda, perché per lui comporta il rischio di perdersi e non essere all’altezza, lo fa sentire insicuro. Gli toglie quello che per secoli è stato il suo privilegio di maschio: il dominio, il controllo, il potere prevaricante.
Aristeo non è solo un uomo intelligente e insicuro, è anche un uomo violento, e il libro si apre proprio su una scena di violenza sessuale di una brutalità estrema.
Ma qual è la vera violenza? Il libro inizia con quello che più chiaramente riconosciamo come violenza. È evidente che la violenza sessuale, ma diciamo meglio, lo stupro, è la cosa che ci colpisce di più perché la relazione di dominio e potere sull’altro che parte dai corpi è palese. Lo stupro fa parte della storia, non della natura, dell’uomo da sempre, in ogni narrazione. Però la prima violenza la vedo in Aristeo che tutti i giorni legge a suo padre uno scontrino scritto da Nina, e dice sempre: “Io so cosa voleva dire”. E traduce – quindi tradisce – tutto il tempo la prospettiva di lei. Non dice mai: “Non ho capito, devo chiederle cosa vuol dire, mi piacerebbe sapere perché dice così”. La prima violenza è questa presunzione di sapere l’altro chi è e cosa desidera.
Perché Nina scrive sugli scontrini? I testi di lei sono bellissimi, poetici, però sono complessi da interpretare. Potrebbe sembrare una reiterazione del cliché secondo cui “le donne sono difficili da capire”.
Nina scrive sul retro degli scontrini, sì. In questa forma chiusa, sintetica e appunto poetica c’è tutta la possibilità dell’ambiguità, dell’equivocità. Però, il fatto di essere più narrativi o espliciti non ci rende più facili da capire – tutto il contrario, e con gli scontrini era più chiaro rappresentare questo limite. Aristeo non capisce il linguaggio di lei. Per mettersi nel linguaggio e nel mondo dell’altro ci vuole uno sforzo, uno spostamento da sé, invece lui continua a dire di aver capito, e non ha capito niente. Non si sposta. È una forma di violenza, ripeto, di umiliazione.
Ho scoperto dopo che Emily Dickinson, che amo e leggo continuamente, usava le buste delle lettere per scrivere i suoi versi, e seguiva la forma della busta che si chiude a triangolo. Diceva, genialmente, che non è la parola che struttura la forma, bensì la forma che struttura la parola.
La tua scrittura è molto leggibile, non ci sono preziosismi o intellettualismi, e allo stesso tempo densissima di riferimenti e di livelli di interpretazione. Come lavori sulla tua scrittura?
Faccio un lavoro enorme sulla leggibilità e la semplicità del linguaggio. Sulla chiarezza. Ma cerco di mantenere il mistero, l’oscurità. È un doppio sforzo. Da qui, quelli che tu chiami i livelli, gli strati. La mia formazione è pesante, intellettualissima – lo studio del sanscrito, delle lingue classiche. Lavorando a Padreterno ho imparato a usare questa formazione, a servirmene. Per esempio, ho utilizzato il mito, perché il racconto mitologico è quello che ha creato, alimentato, la narrazione sessista occidentale. Poi, cerco sempre di evitare il compiacimento, magari non sempre ci riesco.
Poi c’è il ruolo del parlato, c’è un io parlante che sta cercando di capirsi mentre si racconta. Amo molto i personaggi che lavorano sulla propria storia raccontandosi, e nel momento in cui do voce a una narrazione parlata non posso usare un linguaggio scritto, troppo intellettuale, retorico. Con Aristeo ho cercato di riprodurre una voce che possa essere ascoltata come se parlasse per la prima volta, si cercasse, e allo stesso tempo una voce consapevole, animata da uno sforzo di comprensione.
Aristeo usa il linguaggio per cercare di capire. Si può dire che questo desiderio di comprensione della violenza, questo interrogarsi sulle proprie origini e sul perché delle proprie azioni, che anima tutto il libro, sia già un traguardo?
Aristeo è sincero nel suo sforzo di comprensione. Ho cercato di proporgli una possibilità, che però non ho trovato e non trovo facilmente nella realtà, un uomo che decide di mettersi così tanto in gioco da smontarsi e rimontarsi, esiste?
Padreterno è un’utopia?
È un invito. Questo testo è uscito nel 2015, ma ci ho lavorato per sette anni. Avevo deciso che volevo lavorare non su quello che avevo ascoltato, ma su quello che avrei potuto ascoltare, quindi su un condizionale utopico. Quello che vorrei che la mia scrittura facesse è che desse una visione, che producesse uno sguardo deviato, lontano, che non sta qua, perché se sta qua fa giornalismo. Io parto dal giornalismo, da storie vere, e potrei fare una fotografia della realtà. Ma mi interessa guardare attraverso quell’immagine, mi interessa immaginare cosa proietta altrove o nel futuro. Questo è quello che mi piace come sfida e che mi emoziona, è il mio pezzo politico, perché penso che la scrittura sia azione e agisca politicamente.
Con Padreterno pensavo di aver adottato uno sguardo ravvicinato, poco visionario, e invece mi sono accorta che il lavoro è esattamente quello che non pensavo di avere fatto: quest’uomo non esiste, non esiste ancora. Questo mondo che finalmente interroga gli uomini non c’è. Non c’è un uomo che parli un linguaggio che includa la molestia, la violenza, il potere dentro l’amore e il fatto che la relazione d’amore non possa prescindere da gerarchie strutturali. Oggi che le donne stanno di nuovo venendo fuori – e non sono cose nuove, ridicono cose che avevano già detto ma nessuno ascoltava – le si ascolta, le si manipola un po’, e possibilmente così le si mette a tacere di nuovo. Il potere sa benissimo come fagocitare qualunque sguardo rivoluzionario, basta spettacolarizzarlo o vittimizzarlo, renderlo massa, fashion, glamour: funziona benissimo. Penso che Padreterno sia un libro che parla di oggi, e che sia allo stesso tempo un invito a un uomo che potrebbe finalmente e improvvisamente ripensare la propria sessualità, il proprio sguardo sulle donne e i rapporti di potere.
Aristeo parla con il padre morente. Qual è il ruolo della figura paterna, in questo percorso di comprensione?
In un’intervista, un uomo mi ha detto: «Se fossi stato capace di dire alcune cose a mio padre e chiedergli della sua storia, oggi sarei un uomo più felice». Mi colpì molto questa confessione perché era seriamente addolorato. Molti altri mi hanno raccontato esperienze simili. Un altro intervistato mi ha detto che non era andato al funerale del padre, e che il confronto con quel modello paterno non era riuscito ad affrontarlo nemmeno dopo la morte. È stato illuminante. Aristeo si racconta al padre, al modello di riferimento che lo ha fatto soffrire e che ora sta morendo e non ha più parola. Mi interessava ragionare sui modelli su cui si regge il patriarcato. Si regge sul silenzio.
In Padreterno, nella comprensione dell’origine della violenza gioca un ruolo centrale la famiglia, più che la società in senso ampio. Però ci sono le generazioni, e quindi un senso della storia e indirettamente della società che cambia.
Mi piaceva tenere chiuso l’ambito, mettendo al centro le relazioni e la sfera famigliare. Però le stesse figure famigliari appartengono a una società e a un tempo. Non è un livello privato e intimo separato, penso che la relazione amorosa, famigliare, amicale, racconti sempre dei codici sociali e dello spazio pubblico.
Insomma, il personale è politico…
È sempre così. E trovo sia deviante e anche poco innocente non concepirlo così.
A chi è indirizzato questo libro, a chi si rivolge?
La cosa strana di questo libro, che anche nell’ambito del femminismo è stata capita solo in parte, è che si tratta di un romanzo, che parte da storie vere e da un posizionamento politico preciso, certo, ma che persegue una scrittura totalmente romanzesca. Questo ha spiazzato anche Einaudi, che ha scritto che questo libro non ha trama perché non aderisce a una narratività didascalica, che ti accompagna, ti esemplifica. Insomma, non è paternalistica! Questa è una storia d’amore che fa accadere tutto il politico della terra ma non ti avverte mentre lo sta dicendo.
Penso anche che per un libro che parla di violenza con una voce maschile fosse un po’ presto quando è uscito. È paradossale quello che dico, ma non ho raccontato di una donna “vittima”, ho cercato di guardare con gli occhi di un uomo, un uomo che non si piace e non si vuole più così, e questo non sempre è stato accolto. Forse non a caso. Considera che nel 2015 non esisteva nemmeno la parola femminicidio. Non so, forse, una certa consapevolezza sociale, una certa richiesta che siano gli uomini a dare conto di sé, è di questi ultimi pochissimi anni.
E arriviamo all’ultima domanda. Padreterno è un libro con molti livelli di lettura e tanti percorsi diversi: la relazione d’amore, la violenza, le figure genitoriali, il ruolo metaletterario degli scontrini, una concentrazione di riferimenti culturali che chiamano in causa la cultura in senso ampio, a partire dai miti… E poi ci sono le api. Si può dire che le api rappresentino un’apertura poetica di questo libro, e forse il filo che lo tiene insieme?
Io ho un amore infinito per le api. Le api sono l’unico respiro verso il fuori che ha questo libro. Emily Dickinson parlava delle api come il simbolo dell’erotismo. Simbolicamente, sono tutte femmine e tutte dedite a una femmina che sola concepisce la sessualità, ma che per ottenerla deve uccidere i fuchi. Questo volo che mette in gioco per la prima volta il maschile e che però coincide con la morte… Mi sembrava anche talmente esplicito da essere ironico, volevo alleggerire un po’, dare un respiro leggero. Veramente l’unica trama tradizionale dentro al romanzo è quella delle api, che lavorano, occupano la casa di Aristeo, e infine lo scacciano per fare il miele al buio, per fare qualcosa di buono. Danno conto del vecchio binomio eros thanatos, amore e morte. Però con l’efferata ironia che a morire sono sempre e solo i maschi, anziché le femmine! Sì, le api sono il filo.

Alberica Bazzoni è ricercatrice in letteratura italiana e studi di genere all'Università di Warwick, Regno Unito.
