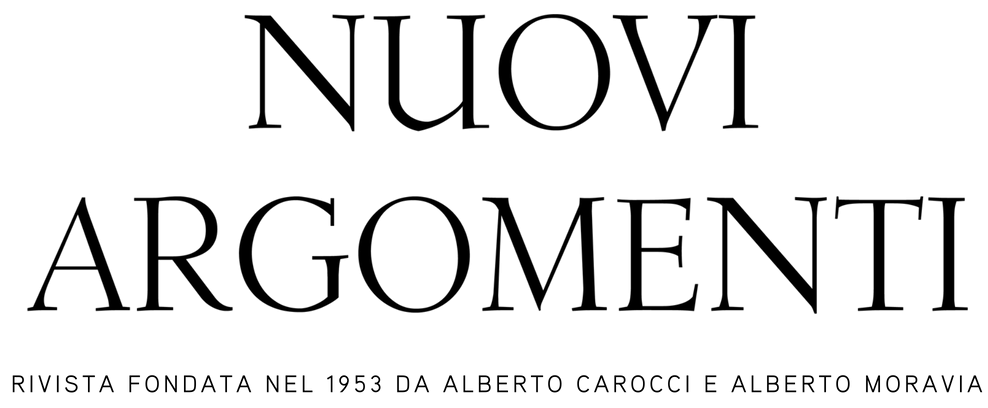di Andrea Agliozzo
Si chiamano mashrabiye, quelle geometriche aperture d’acciaio che disegnano la facciata dell’Institut du Monde Arabe di Parigi sul lungofiume sinistro della Senna. Composto dalla radice semitica <š-r-b> da cui deriva il verbo “bere” (šariba), il termine mashrabiya rimanda all’abitudine di rinfrescarsi all’ombra della grata che accelera il passaggio del vento. Viste da dentro, le aperture somigliano più a diaframmi fotografici che regolano la luce proiettata nei nove piani dell’edificio, quasi a fare di ogni camera orientata verso l’esterno una pellicola su cui imprimere di volta in volta una particolare sfumatura di colori. All’Institut du Monde Arabe ero stato per la prima volta in occasione di un evento organizzato dalla Maison de la Poésie per il festival «Paris en toutes lettres». All’interno di una sala ricoperta di tappeti e candele profumate, il pubblico ascoltava fino all’alba poesie e canti in lingua araba e francese. Catturato dalla terrazza al nono piano da cui è possibile osservare uno dei panorami più belli di Parigi, avevo deciso di tornarci per visitare la parte di edificio rimasta chiusa la sera dell’evento. Un modo come un altro per osservare meglio l’effetto della luce su quelle sofisticate aperture d’alluminio.
Al Musée dell’Istituto si accede per mezzo di un ascensore di vetro che si arresta al settimo piano. Nel corridoio che collega l’ingresso alla prima sala dell’esposizione, una linea azzurra sul pavimento fa da guida tra i pannelli di una mostra temporanea dedicata all’artista Emeric Lhuisset. Il titolo dell’esposizione è Last water war, ruins of a future, una serie di fotografie scattate sul sito archeologico di Girsu, in Iraq, che mostrano le rovine di una civiltà inghiottita dal deserto, in quella parte di mondo che ha visto fiorire, grazie all’opera di irrigazione dei campi, la scrittura e le prime città-stato. «Da quando gli uomini coltivano la terra», si legge all’ingresso dell’esposizione, «le rivalità legate all’acqua sono motivo di discordie». Come per gli scavi di Girsu, le parole sono per Lhuisset rovine da interrogare per decifrare il segreto del tempo: “rivalità” deriva dal latino rivalis, ovvero «colui che divide con un altro l’acqua di un fiume (rivus) per irrigare i rispettivi campi». La prima guerra documentata dell’acqua risale all’incirca al 2600 a. C. in Mesopotamia, quando le città-stato di Umma e di Lagash (di cui Girsu è la capitale religiosa) entrarono in conflitto per diversi secoli, contendendosi il controllo dei canali di irrigazione alimentati dal fiume Tigri. Gli scavi archeologici testimoniano l’antico conflitto; se interrogati, dicono qualcosa di ieri e di domani. Secondo Lhuisset infatti, una guerra dell’acqua potrebbe nuovamente delinearsi nel futuro, sugli stessi luoghi in cui le rovine di Girsu riposano. I fattori di tensione sono molteplici: la contesa del potere tra i territori regionali; la presenza dello Stato Islamico, che ha fatto della gestione dei canali un obiettivo strategico; il controllo esercitato dalla Turchia sui flussi d’acqua del Tigri e dell’Eufrate (progetto GAP); o ancora la crescita demografica, la crisi delle risorse e il riscaldamento globale.
![1. Emeric Lhuisset - Last water war, ruins of a future [Sito archeologico di Girsu (Telloh), Iraq, 2016]](http://www.nuoviargomenti.net/wp-content/uploads/2017/01/1.-Emeric-Lhuisset-Last-water-war-ruins-of-a-future-Sito-archeologico-di-Girsu-Telloh-Iraq-20161.jpg)
Emeric Lhuisset, “Last water war, ruins of a future” [Sito archeologico di Girsu (Telloh), Iraq, 2016]
Lhuisset si era già posto il problema della neutralità delle informazioni in due lavori precedenti, intitolati rispettivamente Combattenti (2010) e Teatro di guerra (2011-2012). In queste opere l’artista affrontava la retorica visuale, narrativa e simbolica, che influenza in larga parte la produzione delle immagini di guerra diffuse dai media e immediatamente riciclate dal cinema e dalle serie tv. In Teatro di guerra, in particolare, Lhuisset sfruttava la composizione pittorica di dipinti classici per rappresentare scene belliche dove veri combattenti venivano ritratti durante le operazioni militari; una telecamera posizionata sulla divisa dei soldati testimoniava – al contrario dell’immaginario sparatutto dei media internazionali – un conflitto statico, fatto di attese e tempi morti. Sono immagini che non servono a catturare l’emotività del pubblico, a mettere in piedi trasmissioni o contenuti virtuali volti a registrare grandi ascolti: esse non devono essere seducenti, per non rischiare di cadere nella spettacolarità che contestano. Nella serie Last water war l’artista lavora di conseguenza per sottrazione: la presenza dell’uomo scompare, con l’effetto di abolire qualsiasi tipo di eccezionalità. La neutralità delle immagini viene resa ancora più sconvolgente dalla durezza del paesaggio senza suono.
In una lettera indirizzata all’editore Einaudi per la pubblicazione di una seconda versione dei Cani del Sinai, Franco Fortini suggeriva allo stesso modo di utilizzare, per la copertina del libro, «un fotogramma del film, per esempio uno che rappresenta il monumento ai fratelli Cairoli a Firenze, o una veduta di via de’ Servi; quindi non [doppiamente sottolineato] immagini di guerra». Il film a cui Fortini si riferisce è Fortini/Cani, tratto da quel piccolo testo scritto «a muscoli tesi, con rabbia estrema» nel 1967, qualche mese dopo la Guerra dei sei giorni combattuta all’interno del conflitto arabo-israeliano. «“Fare il cane del Sinai” pare sia stata locuzione dialettale dei nomadi che un tempo percorsero il deserto altopiano di El Tih, a nord del monte Sinai» – si legge nella frase posta in esergo al libro – «Variamente interpretata dagli studiosi, il suo significato oscilla tra “correre in aiuto del vincitore”, “stare dalla parte dei padroni”, “esibire nobili sentimenti”». A latrare in aiuto dei vincitori erano in quel momento la stampa e l’élite culturale europea, prontamente schieratesi dalla parte degli israeliani per «liberarsi dalla colpa fascista» e stare finalmente tra i buoni, scaricando sull’Arabo «l’odio accumulato contro la generazione dei padri». Il cane del Sinai era colpevole non tanto «per l’atteggiamento assunto, per la scelta compiuta, razionale o emotiva» ma, prima di ogni altra considerazione, «per essere stato così bene scaldato dalla propaganda». Il rigore del paesaggio naturale tuonava però su quel rapido filisteismo della stampa: Sul Sinai non ci sono cani.
Il film, diretto nel 1979 dalla coppia francese Jean-Marie Straub e Danièle Huillet, alterna la voce di Fortini – quel «signore che […] cova in se stesso una esistenza sconfitta e legge, quasi incredulo, quel che un altro se stesso ha scritto con una enfasi riverberata dai silenzi e dai fragori del presente circostante» – ad alcune immagini «apertamente allusive ad un passato che potrà essere anche futuro se qualcuno saprà volerlo». Nelle lunghe sequenze panoramiche delle Alpi Apuane, l’uomo è assente; si afferma, al contrario, «l’enorme presenza dei morti», delle vittime degli eccidi nazisti sulle alture tosco-emiliane. Mentre scorrono sullo schermo le immagini delle «montagne pacificate» della Toscana, Straub chiede a Fortini di tacere: è il panorama naturale a dire la Storia, a ricordare allo spettatore che il luogo non è un qui, ma un altrove. Mancando di spazio e di tempo («non oggi, ma ieri e domani»), la presenza dell’uomo viene brutalmente sospesa affinché su quei luoghi, come per il Proust del Tempo ritrovato, «cresca l’erba non dell’oblio ma delle opere feconde, sulla quale le generazioni future verranno lietamente a fare le loro “colazioni sull’erba”, incuranti di chi dorme là sotto».
Come nella serie fotografica di Lhuisset, il paesaggio delle Alpi Apuane chiede allo spettatore una partecipazione critica alla storia, senza uomini a imbracciare un fucile o bambini lasciati a morire tra le macerie. Le trasmissioni televisive di colpo scompaiono: è il silenzio delle rovine a imporsi sull’uomo con la sua persistente promessa di abitabilità. In una nota da inserire nella traduzione francese dei Cani del Sinai, Fortini descrive così la panoramica delle Alpi Apuane presente nel film: «La calma era apparente, qualcosa chiamava aiuto da un profondo. […] Il paesaggio chiedeva (noi chiedevamo attraverso il paesaggio) qualcosa come “un supplemento d’anima” […]. Tutta la realtà della lotta ‘materialistica’ delle classi era inclusa in quei colori di idillio ed era per noi inseparabile da quei canti di uccelli».
Fortini tornerà più volte a riflettere sul conflitto arabo-israeliano. Nel maggio del 1989, di ritorno da un viaggio compiuto un mese prima a Gerusalemme, scriverà una lettera agli ebrei italiani firmandosi col cognome ebraico del padre. Il racconto di quel viaggio verrà successivamente inserito in una sezione di Extrema ratio, un testo del 1990 il cui sottotitolo recita: Note per un buon uso delle rovine. Le rovine, come precisa l’autore nella prefazione al volume, non sono le stesse dell’Angelo della Storia di Benjamin, «ma quelle della cronaca dei nostri pochi anni»: macerie delle vecchie città a partire dalle quali è possibile costruire le città nuove da abitare (l’evangelica pietra scartata dal costruttore).
In questa parte di mondo dove i fiumi non sono ancora prosciugati, rinfrescarsi all’ombra di una mashrabyia si traduce d’improvviso nell’accordo di una voce che attraversa le rovine della storia. WQue Quella voce ricorda che «gli uomini i gruppi i popoli non sono uguali; ma non sono diversi solo perché il loro passato è diverso e perché diversamente li determina. […] Il loro passato li ha collocati dove sono; ma è il futuro a farli muovere. E sono diversi rispetto a te perché coinvolgono, con il loro agire nel presente, la tua diversità, il tuo agire».
Tra le rovine di Girsu fotografate da Lhuisset, l’unica struttura che rimane visibile, a distanza di millenni, è un ponte di mattoni d’argilla.
Nota:
Le citazioni presenti nel testo sono prese da Franco Fortini, I cani del Sinai, con una Nota 1978 per Jean-Marie Straub, In appendice: Lettera agli ebrei italiani, a cura del Centro Studi Franco Fortini, Macerata, Quodlibet, 2002.
Il catalogo della mostra Last water war, ruins of a future di Emeric Lhuisset è stato pubblicato nell’ottobre del 2016 dalla casa editrice indipendente “André Frère Éditions”, con prefazione di Jack Lang.