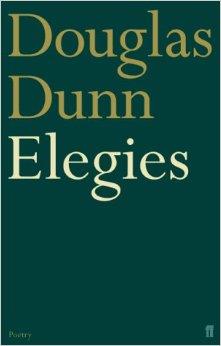La poesia che affronta direttamente un lutto personale non è soltanto il sofferto lamento del sopravvissuto per la perdita subita, può offrire anche un modello di rapporto con l’altro più prossimo come soggettività autonoma da riconoscere. A partire dalle strutture offerte dalla “Vita nova” di Dante e dal “Canzoniere” di Petrarca, Canzonieri in morte. Per un’etica poetica del lutto (Textus Edizioni, 2015) entra all’interno di sei canzonieri in morte del Novecento: i “Sonetos de la muerte” di Gabriela Mistral, gli “Xenia” di Eugenio Montale, le “Elegies” di Douglas Dunn, “Atlantis” di Mark Doty, le “Birthday Letters “di Ted Hughes e “Tema dell’addio” di Milo de Angelis (a cui si aggiungono i casi limitrofi della Postfazione poetica di Patrizia Valduga agli “Ultimi versi” di Giovanni Raboni e “Epoca immobile” di Giovanna Sicari), per osservare il lavoro che portano avanti nella loro dimensione macrotestuale con lo strenuo sforzo di ricostruire un ordine significativo a partire dagli sparsi frammenti che la memoria offre al sopravvissuto. Nel più o meno esplicito fallimento del tentativo emerge la possibilità di un discorso che non può esaurirsi nella costruzione compensativa di un’immagine della persona scomparsa, perché qualcosa dell’altro ritorna incessantemente nelle pratiche di vita dell’io, turba sia l’immagine fittizia del tu sia quella del me e chiede di essere considerato. L’atto ripetuto del volgere lo sguardo di Orfeo verso Euridice – un respicere che è anche un regarder nel doppio senso di Derrida – rappresenta allora proprio questo necessario prestare attenzione a chi è stato perduto. L’indicibile della morte individuale si trasforma in un ineffabile che fa dell’altro non più l’oggetto del discorso, ma la ragione e la causa della parola. Cantare né a qualcuno né di qualcuno, ma con la persona perduta.
Dal capitolo III. La ripetizione e i simboli
La storia, gli oggetti, l’assenza
Il testo di apertura di Elegies di Douglas Dunn lega la donna, la sua morte e la sua memoria a un singolo elemento simbolico: una mosca schiacciata tra le pagine del volume Bliss and Other Stories di Katherine Mansfield e rinvenuta per caso in una rilettura del libro. Il libro fisico e gli oggetti che contiene – la mosca, il biglietto dell’autobus – diventano allora tutta una storia di cui scandiscono il tempo, una storia non ancora conclusa: «I flick / Through all your years, my love, and love you still» (11-12).[1] E il libro che il poeta sfoglia come gli anni della storia della donna, di una vita e di un amore non ancora finito, diventa anche il libro che il lettore si accinge a leggere partendo, come in Dante e Petrarca, proprio da questo testo d’apertura.[2] E la mosca, «questa, questa mosca» (15) presente di fronte all’io a segnare nella deissi la concretezza dell’esperienza, sepolta tra le pagine del racconto Bliss diventa una lacrima asciutta che punteggia l’opera, un oggetto materiale che interrompe e minaccia la costruzione letteraria.[3]
Gli oggetti si moltiplicano nella seconda poesia, The Butterfly House, è tra di essi e con essi che la storia ha luogo nell’esistenza come nella memoria (17-27). La concretezza fisica, materica della casa si contrappone all’altrove radicalmente altro della morte, ma non eludendolo, bensì come accogliendolo, facendosi portatrice concreta della morte. Ogni oggetto, se da un lato si lega all’amore, ai momenti del poeta e della donna, dall’altro cerca i propri legami con l’intero mondo esterno alla casa (32-38):
This room is everywhere, in its pictures,
Its minerals and chemistry, its woods,
Its weeping fig, bamboos, its foreign stuffs,
That slave trade in its raw materials.
But timbers long for unfootprinted forests,
China was baked from clay, metals from earth,
And these tame plants were stolen from the ground.[4]
Gli oggetti racchiusi nella stanza anelano a un ritorno all’origine, al mondo loro naturale. Alle persone che abitano la Butterfly House accade qualcosa di simile. Gli oggetti che circondano il soggetto all’interno della casa non sono soltanto semplici materiali da tenere distinti dal sé come persona, piuttosto condividono un destino come condividono un ambiente, come un unico organismo collettivo. E come gli oggetti, anche la persona, che pure si sente a casa, nutre in sé un desiderio elementare di tornare all’origine, al proprio naturale elemento, quasi un ritorno a quella «long room of its being» che ha in sé un’idea di vita almeno quanto ha in sé un’idea di morte.[5] Quello che Dunn compie in Elegies è un intenso lavoro di spazializzazione della morte, di collocazione di questo evento, di per sé profondamente dislocante, all’interno della propria abitazione.
Ad arricchire il sistema degli oggetti ordinari che recano una traccia silenziosa della vita della donna o della vita in comune entrano gli abiti in Empty Wardrobes; abiti che si fanno veicoli di memorie precise e, allo stesso tempo, strumenti per esercitare una sorta di controllo sull’attività memoriale.[6] L’esercizio di stile della donna che li ha scelti corrisponde, adesso, a quello del poeta che li rievoca (5-8 e 13-16):
Clothes are a way of exercising love.
False? A little. And did she like it? Yes.
Days, days, romantic as Rachmaninov,
A ploy of style, and now not comfortless.
[…]
The dress she chose was green. She found it in
Our clothes-filled cabin trunk. The pot-pourri,
in muslin bags, was full of where and when.
I turn that scent like a memorial key.[7]
L’abito porta con sé il ricordo di un odore che si fa proustianamente chiave per la memoria del soggetto – non può non essere proustiano, in Creatures, quel «Penso a lei» portato dall’azione «bagno il mio pane nel latte» (27) come lei aveva dato del pane inzuppato nel latte alle «pigre serpi» (22) – e torna alla mente un giorno a Parigi quando lui ha negato alla donna un acquisto alle Galeries Lafayette: quel ricordo «ritorna stanotte, ad agitarmi» (20) insieme al rimpianto, al pentimento, al senso di colpa. L’esercizio di stile non controlla del tutto la materia e la memoria.[8] Adesso, insieme ai vestiti, quel che resta è il dolore (21-24):
Now there is grief the couturier, and grief
The needlewoman mourning with her hands,
And grief the scattered finery of life,
The clothes she gave as keepsakes to her friends.[9]
È il dolore che si fa creatore, una sorta di cucitrice che lavora il lutto con le sue mani. Il lutto è in quegli sparsi fronzoli della vita, i vestiti che la donna ha regalato alle sue amiche come ricordo. La sofferenza per l’assenza è recata da – e incarnata in – quel che la donna lascia dietro di sé: gli orpelli a cui lei aveva dato importanza, che erano stati parte della sua vita, frutto dei suoi gusti e delle sue scelte. Sugli oggetti si depositano le tracce delle persone che li hanno toccati, usati, vissuti, e su di essi resta depositata la loro memoria per chi si trova costretto a sopravvivere.[10]
È nei luoghi e negli oggetti, i più semplici della vita quotidiana, che, freudianamente, si prende coscienza dell’assenza della persona amata, anche con la durezza di una rivelazione improvvisa dell’impossibilità del riaccadere, dell’essere definitivamente collocata nello spazio dell’accaduto e del non più accadibile. Così inizia Dining (1-4):
No more in supermarkets will her good taste choose
Her favourite cheese and lovely things to eat,
Or, hands in murmuring tubs, sigh as her fingers muse
Over the mundane butter, mundane meat.[11]
In questo testo che ha l’andamento parlato, talvolta ironico, e pieno di reiterazioni di una vera elegia (anche con il suo passaggio dal parlare della donna in terza persona: «My lady» ai versi 9 e 13, al rivolgersi direttamente a lei con un’invocazione: «O my young wife», 25), la dolorosa presa di coscienza è segnata dai ripetuti «No more» (1), «Nor» (5), «never more» (9), e si lega all’ambiente tutto domestico della cucina, all’amore che la donna nutriva per il cibo e la sua preparazione. Un amore volto, nella seconda metà del testo, nella sua assenza dalla cucina e nella necessità di continuare certe pratiche (18-24):
And it is hard for me to cook my meals
From recipes she used, without that old delight
Returning, masked in sadness, until it feels
As if I have become a woman hidden in me –
Familiar with each kitchen-spotted page,
Each stain, each note in her neat hand a sight to spin me
Into this grief, this kitchen pilgrimage.[12]
La sovrapposizione di ruoli e di azioni, in quel momento della vita privata e quotidiana che è la preparazione dei pasti, porta quasi un’identificazione delle due persone, facendo scoprire al soggetto la parte femminile in sé nascosta, e rinnova il dolore nel vedere che quei medesimi gesti sono realizzati da un’altra persona, che è egli stesso, e non più dalla donna. Si evidenzia così un vuoto che lui stesso è chiamato a colmare prendendo il posto e assumendo su di sé le pratiche dell’assente. Ma la poesia presenta un altro momento alla fine del testo, quello del suo ultimo giorno di vita e della malattia che limita la capacità di azione della donna, le rende impossibile assolvere quel compito abituale che amava: il «cucinare e cenare» del verso 9. Per il primo deve essere sostituita dalle sue amiche, o comunque da altre figure femminili ringraziate nei versi, al secondo ha sostituito ormai solo il tè; è per questo che il soggetto è «perfino contento» nel vederla mangiare, nella sua ultima notte, la zuppa preparata da Jenny (25-32):
O my young wife, how sad I was, yet pleased, to see
And help you eat the soup that Jenny made
On your last night, who all that day had called for tea,
And only that, or slept your unafraid,
Serene, courageous sleeps, then woke, and asked for tea –
“Nothing to eat. Tea. Please.” – lucid and polite.
Eunice, Daphne, Cresten, Sandra, how you helped me,
To feed my girl and keep her kitchen bright.[13]
Lo spazio della donna, così ampio nel ricordo dei viaggi fatti insieme, si è ridotto a quello concesso dalla malattia, perché il cancro è una malattia che evidenzia il suo processo, come per Giovanna in Tema dell’addio o come l’Aids per Wally in Atlantis. Il suo spazio ormai coincide con il letto e la «sua camera», a cui si fa riferimento in molti testi e che sono poi identificati come suo ultimo luogo in The Kaleidoscope (9-14):
I climb these stairs a dozen times a day
And, by that open door, wait, looking in
At where you died. My hands become a tray
Offering me, my flesh, my soul, my skin.
Grief wrong us so. I stand, and wait, and cry
For the absurd forgiveness, not knowing why.[14]
Di fronte a quel luogo, a quell’ultimo luogo terreno della donna, il soggetto si presenta come in un sacrificio totale e ripetuto di sé, piangendo nell’accorata richiesta di un perdono di cui non si conosce il motivo.
[1] «Sfoglio / tutti i tuoi anni, amore mio, e ti amo ancora».
[2] Per una lettura della poesia nella prospettiva dell’allusione intertestuale si veda M. Rouse, The Self’s Grammar. Performing Poetic Identity in Douglas Dunn’s Poetry 1969-2011, Winter, Heidelberg 2013, pp. 191-197.
[3] Sul carattere ambivalente della rappresentazione letteraria del dolore che questa apertura segnala si veda D. Kennedy, Aesthetic Pain: Authenticity & Literary Anxiety in Douglas Dunn’s Elegies, in «English» 55 (2006), pp. 299-309, in partic. 301-303.
[4] «La stanza è ovunque, nelle sue immagini, / i suoi minerali e la sua chimica, i suoi boschi, / il suo salice piangente, i bamboo, la sua roba straniera, / quel commercio di schiavi nelle sue materie grezze. / Ma il legno anela foreste mai calpestate, / la ceramica fu fatta dall’argilla, i metalli dalla terra, / e queste piante domestiche furono strappate dal terreno».
[5] Sembra esserci un legame con la freudiana pulsione di morte. Si può immaginare la propria morte – o invocarla come in Dante e Petrarca – perché si realizza che si sta già morendo, che tutto sta già morendo, ma questa morte non è un radicale annullamento della vita, piuttosto una sua ricollocazione all’interno di un movimento generale – una tensione che pervade tutto – di ritorno verso un luogo originario, verso una dissoluzione della temporanea individuazione.
[6] Sull’importanza degli abiti che avvolgono il corpo e in generale degli oggetti con cui si interagisce quotidianamente si veda D. Lupton, The Emotional Self, Sage, London 1998.
[7] «I vestiti sono un modo di esercitare l’amore. / Falso? Un po’. E a lei piaceva? Sì. / Giorni, giorni, romantici come Rachmaninov, / una strategia di stile, ed ora non priva di conforto. / […] / Il vestito che scelse era verde. Lo trovò nel / nostro baule pieno di vestiti. Il pot-pourri, / in borse di mussola, era pieno di tempi e luoghi. / Girai quel profumo come una chiave della memoria».
[8] Su come tali involontarie memorie proustiane abbiano un portato di desimbolizzazione, con una riduzione della centralità dell’io e una maggiore visibilità della diversità fenomenica, che libera gli oggetti «dalle costrizioni del desiderio ansioso» e «fortifica la loro resistenza alla violenza dell’intento simbolico», si veda L. Bersani, The Culture of Redemption, cit., pp. 22-28.
[9] «Adesso c’è il dolore sarto di classe, e il dolore / cucitrice che piange il lutto con le mani, / e il dolore sparsa eleganza della vita, / i vestiti che diede come ricordo agli amici».
[10] Nel funzionamento della memoria in relazione a oggetti materiali Elizabeth Hallam e Jenny Hockey distinguono tra gli oggetti prodotti al fine di ritualizzare la morte e «quegli oggetti materiali che diventano veicoli di memorie in virtù del loro coinvolgimento o della loro associazione con persone decedute», E. Hallam, J. Hockey, Death, Memory and Material Culture, Berg, New York 2001, p. 211. Margitta Rouse nota che in Elegies «gli oggetti non rappresentano un sostituto simbolico nel racconto della perdita maschile ma spesso segnalano una negoziazione della differenza sessuale per celebrare la donna defunta come donna», Rouse, The Self’s Grammar, cit., p. 197.
[11] «Il suo buon gusto non sceglierà più nei supermercati / il suo formaggio preferito e cose squisite da mangiare, / né, con le mani in tini borbottanti, sospirerà mentre le sue dita meditano / sul burro terreno, la carne terrena».
[12] «Ed è difficile per me cucinarmi i pasti / con le ricette che usava lei, senza che ritorni / quel vecchio piacere, mascherato da tristezza, fino a che mi sento / come se fossi diventato una donna nascosta in me – / abituata a ogni pagina chiazzata di cucina, / ogni macchia, ogni nota nella sua grafia chiara una visione che mi spinge / in questo dolore, questo pellegrinaggio da cucina».
[13] «O mia giovane moglie, quanto ero triste, anche se soddisfatto, di vederti / e aiutarti a mangiare la zuppa fatta da Jenny / la tua ultima sera, tu che tutto il giorno avevi chiesto del tè, / e solo quello, o dormito i tuoi sonni senza paura, sereni, coraggiosi, poi ti risvegliavi e chiedevi del tè – / “Niente da mangiare. Tè. Per favore.” – lucida e cortese. / Eunice, Daphne, Cresten, Sandra, quanto mi avete aiutato / a nutrire la mia ragazza e a tenere splendente la cucina».
[14] «Salgo queste scale una dozzina di volte al giorno / e, davanti a quella porta aperta, aspetto, guardando dentro / dove sei morta. Le mie mani diventano un vassoio / che offre me, la mia carne, la mia anima, la mia pelle. / Il dolore ci ha colpito così. Sto in piedi e aspetto, e invoco / l’assurdo perdono, e non so il perché».
Maria Borio è nata nel 1985 a Perugia. È dottore di ricerca in letteratura italiana contemporanea. Ha pubblicato le raccolte Vite unite ("XII Quaderno italiano di poesia contemporanea", Marcos y Marcos, 2015), L’altro limite (Pordenonelegge-Lietocolle, Pordenone-Faloppio, 2017) e Trasparenza (Interlinea, 2019). Ha scritto le monografie Satura. Da Montale alla lirica contemporanea (Serra, 2013) e Poetiche e individui. La poesia italiana dal 1970 al 2000 (Marsilio, 2018).