[Proseguono gli appuntamenti di «Officina Poesia» dedicati all’incontro tra poesia e arti figurative, sceniche, musicali. Proponiamo oggi la seconda delle conversazioni tra Tommaso Di Dio e alcuni pittori under 35 che lavorano a Milano. L’intervista è accompagnata da un videoclip. Fotografia e video di Flavio Pescatori.]
Giulio Zanet è un artista con cui mi ritrovo alla cieca. È nato nella provincia di Torino, a Colleretto Castelnuovo, nel 1984. La provincia italiana gli ha lasciato addosso qualcosa di rabdomantico e gli ha impregnato il midollo di nomadismo e del suo esatto opposto: l’assoluta percezione della fermezza eterna del paesaggio. Come tutti quelli che sono cresciuti in provincia, si adatta benissimo a vivere malamente in città: gli sembra un atto dovuto, che risponde ad una giustizia profonda, imperscrutabile. Ha fatto l’Accademia di Belle Arti a Milano; e da allora vive accanitamente fra le strade di questa ‘mini’ metropoli, cambiando così spesso l’indirizzo dove dorme che sembra non avere casa se non nella sua pittura.
Sono andato a trovarlo nel suo studio, a Nord, in uno dei tanti Nord di Milano, il Nord che già fu di Emilio Praga; da qui, nei giorni rari e splendenti di luce aperta e senza foschia alcuna, si vedono nettamente i profili lontanissimi delle Alpi chiamare qualcosa senza voce. La via dove ha luogo la sua pittura porta il nome di uno dei più grandi poeti della Magna Grecia ed incrocia il pittore antico più splendente della storia dell’arte; non foss’altro perché di lui, artista del fragile visibile, nessuna opera ci è rimasta, solo un’infinita serie di leggende. Fra le vie intorno, in maniera solo apparentemente caotica, si enumerano uno fra i massimi filosofi antichi, un oscuro intellettuale locale duecentesco, un musicista di inizio novecento e poi valli, valli: una serie meravigliosa di valli. Tanta antichità e tanta meraviglia si incrostano, oggi, su solitari bar cinesi, su bassi capannoni cupi e palazzi anonimi; in uno di questi, nel suo caratteristico stile anni ’70, si trova lo studio di Giulio Zanet.
Per giungervi, è necessario attraversare prima uno spiazzo catramato, attorniato dalle altissime geometriche costruzioni; poi, svoltando all’improvviso, inoltrarsi in una minuscola scaletta di cemento, adiacente ad un folto d’edere senza senso. A quel punto, aperta una porta metallica di un deciso blu ciano, ci si trova davanti ad un diverticolo assiale, oscuro e profondo. Se avrete coraggio, entrate, entrate pure; questa è una tana di neon, un’umida e caotica miniera di cemento e colori assillanti.
 Se osservo lo spazio dove lavori e penso alla tua pittura, mi vengono in mente alcuni versi di un poeta romano, Valerio Magrelli: “Questa pagina è una stanza disabitata. / Ogni tanto porto una seggiola rotta / o un pacco di giornali, e li abbandono / in un angolo: nient’altro. / Quello che avanza si dispone qui / e nella tregua dell’uso si deposita. / È l’ultima sosta degli oggetti / prima di uscire dall’orizzonte della casa, / nella luce chiara del loro tramonto.” (da “Ora serrata retinae”, 1980). Forse lo studio di un artista è qualcosa di medio fra la pagina bianca dello scrittore e la tela. Giulio, da quanto tempo lavori in questo studio?
Se osservo lo spazio dove lavori e penso alla tua pittura, mi vengono in mente alcuni versi di un poeta romano, Valerio Magrelli: “Questa pagina è una stanza disabitata. / Ogni tanto porto una seggiola rotta / o un pacco di giornali, e li abbandono / in un angolo: nient’altro. / Quello che avanza si dispone qui / e nella tregua dell’uso si deposita. / È l’ultima sosta degli oggetti / prima di uscire dall’orizzonte della casa, / nella luce chiara del loro tramonto.” (da “Ora serrata retinae”, 1980). Forse lo studio di un artista è qualcosa di medio fra la pagina bianca dello scrittore e la tela. Giulio, da quanto tempo lavori in questo studio?
Da cinque anni. Prima ero ad Affori, poi attraverso un’amica sono arrivato qui.
Cinque anni non sono pochi: cosa ti fa rimanere qui?
Tutta questa roba! Come vedi lo uso come un magazzino, è chiaro: un magazzino di vita. È tanti anni che ci lavoro e inevitabilmente le cose si accumulano. In più, sai, ho un sentimento della casa un po’…
… un po’ precario?
Sì, precario… da quando faccio traslochi a Milano (e ne ho fatti tantissimi), questo è il punto dove ritorno sempre. Mi muovo, trasloco, ma torno sempre qui. Giro e vivo con il meno possibile; con le mie valige estive… adesso che sarà inverno cambierò valigie, userò le mie valigie invernali… (ride)
Le valigie… in effetti nei tuoi quadri c’è spesso il tentativo di dare una forma ad una specie di…
… casa?
Volevo dire stabilità, ma ecco, sì. Mi sembra di riconoscere sempre due principi nella tua pittura, uno stabile e uno instabile: che si scontrano. È qualcosa che entra nella tua pittura, ma mi sembra che ci vivi dentro questo scontro…
Forse vivo così perché non è una mia necessità forte avere un punto fermo. Eppure: forse sì, e nei quadri esce fuori questa voglia di stabilità. Ma non è un’ossessione. Però mi piacerebbe…
Ah! Ti piacerebbe: ma in che senso?
Ho avuto una famiglia molto stabile. Quindi, forse, la volontà di fuga la vivo con un senso di colpa: la fuga è forse sempre un tradire la casa dei genitori… e questo si ripercuote nei miei lavori, forse. Io mi lamento sempre che non ho abbastanza soldi per una casa, che potrei trovare un lavoretto migliore e così via. Ma evidentemente non voglio, non è una mia priorità. Per lavorare, ho bisogno di uno spazio privato, ma non una proprietà privata. Se vivo in un luogo, dopo due settimane, lo sento mio e mi ci sento bene come se fosse mio. Non me ne frega niente della proprietà di uno spazio. Non sento la necessità di uno spazio che sia mio e organizzato totalmente da me. Non ho legami, non ho legami spaziali.
Allora questo studio è proprio il solo punto più fisso della tua vita? Alla fine, possiamo dirlo: questa è casa tua.
Sì, più o meno… anche se non la curo tanto. Tante cose qui non sono neanche mie…
Però dipingi sempre qui. Guardando la stanza dove dipingi con la sedia davanti alla tela, si percepisce che è un luogo carico, si sente una sensazione di potenza. Deve dare i brividi essere padroni totali di uno spazio pittorico…
(ride, molto) Eh, ma ci sono momenti in cui stare davanti alla tela bianca ti fa sentire come una nullità! Ti stacchi dall’erotismo del quadro, lo rivedi e ti sembra così misero… però è vero tu sei il creatore, davanti alla tua tela, in quel momento, per quanto poco dura, sei il solo padrone…
Quanto tempo ci metti a dipingere un quadro?
Dipende, è veramente variabile. A volte pochissimo, due giorni, a volte quattro mesi.
Mi fa ridere una cosa che sto pensando: non dipingi mai dove dormi!
No, in effetti. Vengo sempre qua, e me ne vado quando sento di aver finito. Non mi porto via mai niente.
Una volta ho incontrato un’artista che viaggiava sempre con le sue opere. Lavorava su carta e con l’inchiostro: arrotolava i fogli e via, viaggiava da una mostra all’altra.
No, no: io ho proprio bisogno di un luogo dove lavorare. Potrebbe essere la mia casa, ecco, però solo lì. Questo da sempre. Non mi sono mai portato in giro la roba. Non disegno in giro, e non mi porto dietro mai il mio lavoro. Ho bisogno di mettermi lì, nel mio angolino…
 Tu quindi non lavori mai di fronte alla realtà?
Tu quindi non lavori mai di fronte alla realtà?
No, nel senso che non dipingo mai in presa diretta. Io immagazzino: ci lavoro sempre con la realtà. Non è importante dove attingo, non è importante per niente. Se dovessi fare un ritratto, non userei mai un modello vivo davanti a me: non è importante che sia quella persona specifica o un altra. Alla fine sono io che gli do un’identità.
Ogni ritratto, dunque, è un autoritratto?
Non è bella questa cosa, però forse è vera.
Mi viene in mente un fotografo, Aldo Palazzolo. È un grandissimo ritrattista. Mi ha detto spesso che per lui un ritratto è uscito bene soltanto quando “il soggetto è stato ucciso”. Quando lo scatto cancella il soggetto, ne riporta un’immagine che non è del soggetto: se fra la realtà e lo scatto c’è un abisso, allora è un buono scatto. Cosa ne pensi?
Io non lo so.
C’è un punto della tela da cui parti? Perché inizi da lì?
(silenzio)… secondo me non c’è un punto da cui parto… (silenzio)… però forse sempre un po’ dal centro. (silenzio) Sto pensando se c’è sempre…
È un momento teso, in effetti; dico: l’inizio.
Eh certo. Tutte le volte ci sono queste tele bianche… e ti dici: e adesso cosa faccio? Ma perché dipingo? lo faccio, non lo faccio…
Prima di di pingere, tratti le tele?
Le compro già bianche. Recentemente mi sta capitando di sbiancare tele vecchie. Non ho soldi per comprare la tela. Le sbianco e ci lavoro su. Non lo so, non mi importa: sono tele vecchie, non c’è più affezione… ma capita anche con le tele nuove.
Le cancelli perché non ti piacciono?
No, non perché non mi piacciono. Una volta che le ho fatte, basta, no? Ne faccio un’altra. Potrei usare sempre la stessa tela!
La tela mondo!
Fare tutti i lavori sulla stessa tela… eh, sarebbe bello…
C’è un elemento ricorrente nelle tue tele?
Ultimamente c’è sempre questo lavoro che faccio con le strisce… cambia ogni volta, ma tornano sempre. Poi ti faccio vedere il primo quadro dove sono arrivato alle strisce. Appena l’ho finito, ero molto esaltato: ho addirittura urlato.
Deve essere una forte sensazione, quando un artista trova il suo stilema, ad una forma piena, sente che la misura è colma. Come le fai? Cosa ti interessa della striscia? Cosa ti soddisfa?
È un movimento in cui mi ritrovo. È un gesto. Mi piace molto la contrapposizione fra il gesto automatico, questa meccanica attraverso la protesi della bacchetta, e come poco a poco, con il colore e il movimento, il meccanismo si fa pittura in un modo che mi piace da matti. Poi naturalmente le strisce le lavoro molto, le sporco. Io lavoro sempre con i colori puri; li mischio sempre direttamente sulla tela. Ho sempre usato il colore così, ma farlo con le strisce è proprio bello. Perché poi i colori si sovrappongono, si accostano, mi sorprendono. C’è sempre una parte di sorpresa, di casualità che si scatena. (si alza, va in un angolo, fruga e prende le bacchette). Prendo alcune bacchette di legno, le intingo nel colore e le appoggio alla tela; a volte le uso anche come impronta, le premo sulla tela. A volte le muovo, le oscillo e creo degli effetti di sovrapposizione. Sono belle. Più le usi, più creano delle irregolarità. La riga ti viene meno precisa, ci sono delle sbavature.
Da dove ti viene questa idea delle strisce?
Molti hanno usato le strisce, una marea… credo che però ogni pittore abbia trovato una sua strada diversa per lavorare su questo.
Tu dipingi mai ad olio?
No, da un po’ no. Io dipingo con acrilico e con smalto. Le strisce non le ho mai fatte ad olio… Gli acrilici sono molto più piatti. Mi piacerebbe fare le strisce ad olio… però è molto più faticoso, non si asciugano mai… lo farò, lo farò prima o poi…
(si alza e va a cercare qualcosa in giro per lo studio. Sta cercando il primo quadro con le strisce: era sepolto sotto altri quadri e sotto molti fogli sotto il divano. Guardiamo il quadro).
Ecco le prime strisce: vedi, fin dall’inizio non erano geometriche, erano molto sporcate, lavorate.C’è molto azzurro che si sovrappone…
L’azzurro è più gestuale…
Quando capisci che il lavoro sulle righe è finito?
Non te lo so dire bene, è come capire che un quadro è finito.
E allora, Giulio, quando un quadro è finito?
Quando mi sembra che sia risolto. Potrei dirti quando tutte le parti sono equilibrate, ma non è vero… quando non manca più niente… insomma è una cosa che si impara. Un po’ di tempo fa andavo sempre oltre: a quadro finito mi dicevo sempre che avrei dovuto fermarmi un attimo prima. Sto imparando a fermarmi al momento giusto. Sto ancora imparando.
Spesso inserisci elementi geometrici nei tuoi quadri… per esempio questa forma? Come sei arrivato a questa forma?
Beh, questa è una casetta…Sì, sembra una casetta per gli uccelli…
Eh, vedi, sembra una casetta per gli uccelli, sembra così e va benissimo così. E invece viene da tutta un’altra cosa. È un immagine di una casa dentro una cava, un pezzo di un marchingegno, un macchinario, una specie di macina industriale.
Tutta un’altra cosa!
(ride) Sì, tutta un’altra cosa! Ho preso questa immagine e l’ho completamente trasformata. Ma non importa. Sembra una casa per uccelli, perché forse è molto più vicina a una cosa che sentivo di dire, che sentivo di esprimere. Vedi, funziona così…
Ultimamente le tue figure alludono a spazi architettonici: e dalla geometria si passa all’architettura…
Nei miei lavori più recenti sì. L’architettura è stata un po’ graduale nella mia pittura. Quando era molto più figurativo, la composizione dei mie quadri era già molto architettonica, ma solo a livello compositivo. Poi piano piano ho sentito che non fosse più necessaria tutta quella figurazione e ho tradotto quel gusto della composizione in architettura vera e propria, questa geometria un po’ metafisica: allude a spazi ma non sono spazi realistici, però sono spazi percorribili. Io credo c’entri con il sapere quando fermarmi. Prima amavo complicare i piani prospettici, intrecciarli, sovrapporli. Da tre anni ho smesso. Forse prima mettevo troppo nei quadri: qui ho cercato di sintetizzare, di essere più essenziale.
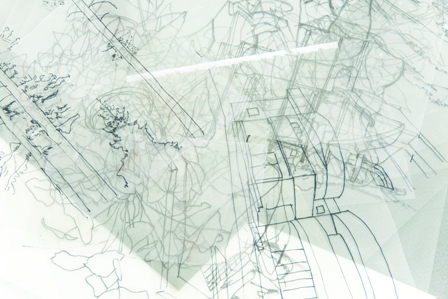 Io ti ho conosciuto come pittore con i quadri della fase precedente… c’è una continuità fra quei quadri e questi che stai facendo ultimamente?
Io ti ho conosciuto come pittore con i quadri della fase precedente… c’è una continuità fra quei quadri e questi che stai facendo ultimamente?
Sono andato a togliere. A me piacciono molto i miei lavori precedenti. Ma credo di essere arrivato a un punto in cui avevo esaurito, avevo esaurito la ricerca. E me ne sono reso conto quando iniziavo a fare i quadri con troppa facilità. Dicevo ok, questa cosa mi viene bene, e piace anche agli altri: basta. A me piace che quando lavoro ci sia una sfida, ma sfida non è il termine giusto. Io mi ci voglio divertire con quello che dipingo. Se faccio qualcosa che già so, non mi diverto più, non c’è più rischio.
Il lavoro sulle prospettive multiple era dei tempi dell’Accademia oppure già successivo?
Il periodo delle prospettive multiple è già venuto dopo l’Accademia. Prima facevo “testoni”: teste composte da molte teste. Facevo dei collage pittorici. L’occhio di un soggetto, l’altro di un altro, le labbra di uno, gli zigomi di un altro. Già lì c’erano dei germi di quello che avrei fatto dopo…naturalmente ero più interessato all’umano… penso sia soprattutto un fatto di età: tutti, credo, a vent’anni, sono interessati alla figura umana, di più di quanto siamo interessati a trenta…
Verissimo.
Nei quadri più recenti, c’è ancora l’umano, ma in una forma diversa, qualcosa di più… di più…
Più?
Forse meno… meno? Diciamo che non ho più bisogno di raffigurare l’umano. Ho un distacco. L’uomo c’è nelle cose che faccio, nei resti e negli spazi: manca il soggetto, c’è solo il verbo.
Il verbo? Cosa intendi?
Sì, c’è l’azione, il verbo: l’azione umana, ma sempre senza soggetto. Il momento prima e il momento dopo, ma in quell’attimo dipinto non c’è niente, il soggetto non c’è.
L’energia… è per questo che ti piace Schifano?
Sì per questo, sicuramente. Mi piace molto come figura d’artista. Mi piacciono sempre gli artisti che hanno questo approccio serissimo, certo, ma anche scanzonato nei confronti dell’arte. Anche Bacon, in fondo, lo era: una sorta di inconsapevolezza, di approccio ingenuo…
Ti piace essere deresponsabilizzato?
Sì, tantissimo.
Non vuoi sapere dove vai, per questo dicevi prima: il rischio…
Sì, i miei verbi sono sempre all’infinito. Dipingo spazi umani, architetture, ma non coniugo: non solo non voglio il soggetto, ma non voglio neanche coniugare il verbo. Solo verbi all’infinito. Non coniugo mai, ma continuo a cambiare verbo. Tanti lavori, tutti diversi, ma non mi addentro mai, non mi inquadro mai, né in un genere, né in un formato. C’è qualcosa di adolescenziale in questo, forse una nostalgia dell’adolescenza…
C’è un verso di Milo De Angelis che mi è venuto in mente adesso: “bisogna consegnare, / tra qualche minuto, bisogna / consegnare anche la brutta.” (“Torna antica la parola”, da “Quell’andarsene nel buio dei cortili”, 2010). Nei tuoi dipinti anche tu, consegni tutto, consegni anche la brutta.
È un po’ come fossero sempre delle brutte. Quando arriva il momento della bella, mi sono annoiato di me. Mi piacciono le brutte. A me piacciono gli artisti così. Ci sono anche pittori che stimo che sono sporchi e puliti insieme. Ma, profondamente, a me piacciono i pittori sbagliati, sporchi. A me piace questo eterno provare. Non mi piace quando riconosco che diventa un’abitudine.
Alcuni tuoi quadri vedo che hanno le cornici…
Non incornicio quasi mai… compro le cornici ai mercatini… se faccio delle serie di opere simili, allora mi piace mettere tutte cornici diverse. Per Loveless [mostra tenuta allo Spazio Meme, Carpi, settembre 2013] invece ho scelto tutte cornici uguali, per una precisa scelta espositiva… comunque, in genere, non amo molto le cornici. Non amo molto neanche il telaio. Io tutte le mie tele le esporrei con le cornici di scotch, che è poi come lavoro, mi piacerebbe fare così. L’ho fatto in un paio di occasioni. Lo scotch stacca, ma è tutto sullo stesso piano: il quadro non è un oggetto diverso dal muro.
Rothko e Newman hanno lavorato tantissimo su questo aspetto della dimensione dell’opera e del loro rapporto con il muro. Hai mai dipinto sul muro? Hai mai fatto un muro tuo?
No. Non ci ho mai pensato. Però vorrei lavorare sulla carta da parati. Dipingere e usare la carta da parati come una specie di cornice, intorno al quadro. Mi piacciono le textures delle carte da parati. E sarebbe bello anche usarle come tele, intervenire direttamente sul pattern industriale.
È forse per questo che ultimamente stai lavorando sull’astratto?
Avevo voglia di sperimentare l’astratto, perché arrivavo dalle righe. Poi ero alla ricerca come ci siamo detti di un lavoro più essenziale, a togliere piuttosto che ad aggiungere: e mi sono detto proviamo a togliere tutto e sono arrivato all’astratto. Ho fatto una piccola serie di nove tele astratte. È stata una parentesi, una piccola parentesi.
In che senso una parentesi?Ma sì, un lavoro per sperimentare un aspetto della mia pittura, un estremo. Quelle cose che però rimangono. Comunque l’esperienza di lavorare così mi ha spostato completamente. Nei lavori che farò in futuro ci saranno delle parti astratte e cercherò di integrarle con uno stile differente.
Nelle tue tele precedenti, lo stile pittorico astratto era visibile soltanto nel cielo…
Però era sempre cielo, ancora figurativo. Ora con l’astratto ho cercato di liberare il colore piuttosto che la linea. Sto rinunciando un po’ alla protezione della linea. Forse perché mi sento più sicuro, grazie all’uso delle bacchette per le strisce. Grazie a loro, sto riuscendo a liberare il colore in maniera nuova. Ma non ancora fatto un quadro astratto di grande formato, non ho forse ancora fatto “un vero astratto”. Sento una forte tensione che non riesco ancora a liberare completamente. Se ci riuscirò credo che sarò contento.
Guardando il tuo lavoro fin dai tempi dell’Accademia, si vede che tu hai sempre lavorato sulla complessità, sulla sovrapposizione di diverse immagini prese da contesti diversi. Con gli astratti ritrovi ancora questo aspetto della complessità nella tua pittura?
C’è sempre una dialettica fra linea e colore. Continua ad esserci un contrasto fra modalità differenti di dipingere all’interno dello stesso quadro. Nello stesso lavoro c’è una parte geometrica e un’altra dipinta volutamente male, più sbrigativa e sommaria.
In effetti, spesso i tuoi dipinti sono divisi in due parti stilisticamente ben distinte e ho visto che recentemente hai fatto dei dittici: una parte è occupata dalle righe, oppure è astratta o anche molto geometrica, mentre l’altra è figurativa. Cerchi uno stile eclettico?
Sì. Ma che ci sia sempre un contrasto, fra qualcosa. Non mi vengono bene i quadri tutti in uno stile. Non mi piace farli. Mi piace che manchi uniformità. È una cosa che mi viene anche rimproverata. Ma a me interessa proprio questa mancanza di omogeneità. Forse però è un problema di esperienza. Forse con l’età mi verrà da essere più uniforme… ma non credo. Perché è un po’ come se lo trovassi a fondamento della vita, o della mia vita: di come sono io. È una cosa che mi appartiene molto e sento che appartenga anche al mondo che vivo, alla realtà che mi trovo davanti. Che qualcosa sia armonico e che qualcos’altro poi si rompa e vada nel caos. Nelle strisce stesse è contenuto questo contrasto. La regolarità dello strumento e il gesto che lo rompe. Forse nelle righe ho trovato proprio la sintesi di questo contrasto non armonizzabile, che sento a fondamento di ciò che io penso sia la mia pittura.Fin dalla prima volta che ho visto il tuo lavoro ho avuto la netta sensazione che la letteratura ti avesse influenzato. Qual è il tuo rapporto con la letteratura?
Io leggo molto, soprattutto narrativa. Prima di tutto perché ci trovo un sacco di intrattenimento. Ed è molto rassicurante questo, perché ci saranno sempre libri da leggere, non finiscono mai ed è bellissimo. Poi un sacco di robe che so, le so perché le ho lette nei romanzi. Perché contengono tanto, hanno una storia e hanno un sacco di cose in più, te le buttano lì e te le metti dentro. La narrativa ti fa conoscere il mondo e conoscere te stesso.
Nel tuo dipingere, cosa senti che hai preso dal romanzo?
Prima di tutto i titoli dei miei quadri: non sono mai frasi tratti dai libri, ma riecheggiano spesso cose che ho letto. Credo di condividere un’attitudine con il romanzo. Io non so raccontare e non so scrivere, però dipingo come se volessi raccontare, ma senza avere un’idea della trama: racconto senza trama. Come nel romanzo, i miei quadri cercano di contenere molte cose insieme. E poi il romanzo mi dà tantissime immagini, una miriade di immagini: una miniera.
In fondo, dipingo come leggo. Non dipingo mai per più di un’ora o due di fila e torno spesso sui miei quadri, durante il giorno o in giorni diversi. Quando torno al quadro, ci sono tutte le cose che ho fatto o letto nel frattempo: entrano dentro nel quadro che dipingo. È come se cercassi un’immagine con più tempi, con una progressione di tempi e una sovrapposizione, quasi come se fosse un romanzo, insomma, ma su di un piano solo.
Con tutti i tuoi traslochi, dove tieni i libri? Quali libri o autori ami di più?
Tantissimo di quello che ho letto non è qui nel mio studio. L’ho tutto sparso in giro, perso nelle case che ho lasciato, oppure li avevo presi a prestito e li ho restituiti agli amici. Mi piace molto Bukowski: parla spesso di letteratura, ma a me sembra che parli sempre di pittura. Un libro che mi ricordo particolarmente è… non mi ricordo il nome dell’autore… è morto giovanissimo, era pubblicato dalla ISBN…
“Trilobiti” di D’J Breece Pancake: un libro meraviglioso!
Eccolo! Sì, un libro bellissimo. Non mi ricordo nulla, ma mi ha proprio toccato. Oppure un altro libro della stessa casa editrice che mi è piaciuto tantissimo è La scuola dei Disoccupati di Joachim Zelter.
Non lo conosco. Perché ti ha colpito?
Perché c’è una umanità spogliata da tutto… se non lavori, chi sei? Chi diventi?
Tu dipingi e basta o per vivere fai anche altro?
Mah, ho fatto tantissimi lavori. Recentemente sono stato dog-sitter e driver per le modelle. Piaccio molto alle bestie: i cani mi trovano simpatico.
Grazie Giulio!
Grazie a te.
(ottobre 2013)
Milano Under 35 – La poesia incontra la pittura /1 (“La ragione è tutta pittorica”. Intervista a Linda Carrara)
Maria Borio è nata nel 1985 a Perugia. È dottore di ricerca in letteratura italiana contemporanea. Ha pubblicato le raccolte Vite unite ("XII Quaderno italiano di poesia contemporanea", Marcos y Marcos, 2015), L’altro limite (Pordenonelegge-Lietocolle, Pordenone-Faloppio, 2017) e Trasparenza (Interlinea, 2019). Ha scritto le monografie Satura. Da Montale alla lirica contemporanea (Serra, 2013) e Poetiche e individui. La poesia italiana dal 1970 al 2000 (Marsilio, 2018).







