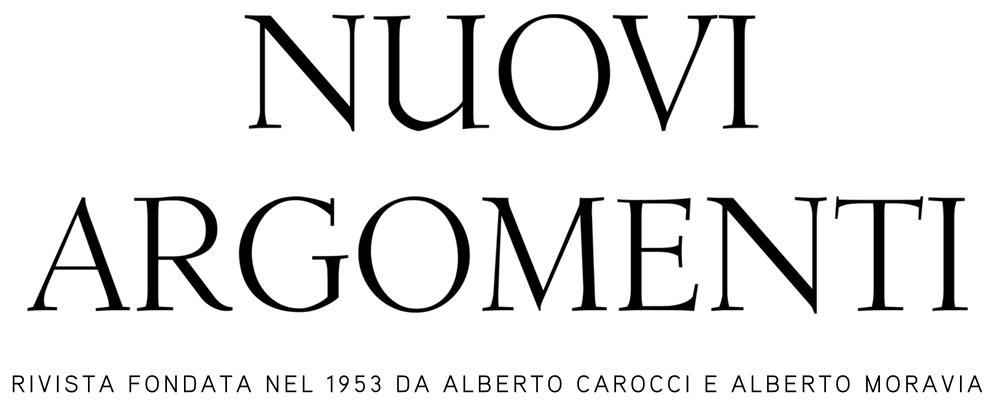«Ho imparato a esprimere gli umori»: con questo verso-chiave si apre la nuova raccolta di Maurizio Cucchi. Un verso che certamente segna il limite di un lungo apprendistato della parola, ma che soprattutto rivendica la coerenza del percorso che il poeta ha condotto fino a questo punto, fino al riconoscimento di «un mondo più affabile/ e poroso». Senza tornare alla dimensione “primitiva” de Il disperso, possiamo citare quattro versi da Poesia della fonte (Mondadori 1993) per comprendere la sostanza di quanto si va affermando: «Cogliere il fondo al fondo/ e farlo infine erompere, sgorgare/ dagli occhi, dalla pancia molle,/ ignorando se stesso». Malaspina vive di una fisicità non dissimile, in cui corporalità e pensiero visivo collaborano nella definizione di una realtà sempre più inclusiva e, per quanto è possibile intendere, definitiva nelle sue parti o particelle elementari. Si tratta di un percorso della consapevolezza, avviato da un moto contiguo (e, se si vuole, involontario), segnato dall’occorrenza in serie, non esplicita, ma ineludibile, di verbi quali «retrocedo», «mi muovo», «sprofondo», disseminati come puntelli di un cantiere rivolto alle sue fondamenta.
La consapevolezza, del resto, deriva dalle cavatine di supporto che non servono a mantenere la misura del fiato, ma guidano il lettore tra i livelli e i depositi connettivi che allungano i percorsi della significazione, tra realtà e ragione: «E io procedo così, dissotterrando»; «Era il ruvido attrito diretto/ della materia, come le mie unghie,/ che mi attraeva, mi assorbiva». Brani che risuonano nell’inciso-preludio posto a capo del secondo componimento della sezione Abbandoni: «(Sono talmente infisso nel passato che la mia ansia arretra fino al buio senza memoria. Risalgo così a quel flusso ininterrotto di moltitudini, e di invisibili emergenze catalogate poi nell’enfasi della storia. Scavo a ritroso, sono una talpa, io stesso l’esito di un’alchimia infinita e di infinite sequenze di informazioni secolari. Scendo a vite come nel legno, piano piano e paziente, ma regolarmente)». Qui risiede l’essenza della poetica di Cucchi, attento ormai a collezionare con cura, a selezionare, e quindi ordinare, gli aspetti della realtà, senza rinunciare a quei “camuffamenti” che Alberto Bertoni sintetizza nel risvolto di copertina (e ben chiari al poeta stesso: «Innumerevoli sono i sosia/ […]./ Io stesso, infine, altro non sono/ che un comune esemplare,/ appartenente a un gruppo,/ a una tipologia scontata,/ come milioni»), ma che stavolta certamente muovono verso le soglie di una maturità umanissima, almeno per quella «nostalgia diffusa» che trapela da ogni immagine e da ogni parola.
E le parole sono quelle misteriose-fantastiche dell’infanzia e quelle laviche ricondotte dall’immersione geologica nella propria esperienza, tracce di una finissima «Religio»: «scorlére», «peekaboo bang», «cavedio», «baggiane», nomi che risuonano e diventano emblemi Nel cortile delle giovani mamme, secondo movimento di Malaspina fortemente connotato dall’insistenza del dettaglio, come se davanti alla macchina da presa si svolgesse il racconto dei versi in una sequenza che ha ragioni schiettamente emotive. Le suggestioni più profonde, comunque, trapelano dai versi della sezione centrale, quella Macchine movimento terra dove si compie il miracolo/inganno della rappresentazione, come già era avvenuto per vie diverse nel romanzo La traversata di Milano (Mondadori 2007) e quindi in Il viaggiatore di città (Archivio Dedalus edizioni 2011), intervista-videoritratto ideata e realizzata da Vincenzo Pezzella. Cucchi cammina per le strade di quella città che è sempre stata attraversata e vissuta dalla sua poesia, questa volta fissandosi alchemicamente nei prodotti più o meno saturi della natura e della cultura. Il clima è sospeso all’apparenza, ma quanto accade inevitabilmente coopera alla creazione di un assoluto insieme specifico e irresoluto (come per certi versi accadeva nella Contemplazioni meccaniche e pneumatiche di Pier Luigi Bacchini): «Nel tempo che invece non esiste/ che è un’illusione o solo svolgersi/ ordinario di un sé fino a maturazione/ e fine, sbando definitivo e arresto/ per lo spin del misero soggetto/ nel paradosso semplice del mondo,/ giacciono strati, subsidenze, depositi/ di inesplorata materia remotissima».
Siamo lontani ormai dalla prospettiva acquiescente che in parte permeava, seppure con occhio clinico, i baluginii di Vite pulviscolari (Mondadori 2009), fino a quella chiusa in cui Cucchi diceva: «e mettendo già il piede sul suolo/ mi fingo a me stesso più goffo/ per darmi certezza del felice attrito/ col mondo, con la materia/ che mi accoglie e accarezza./ Che dolcemente mi azzera». Ora il passo è sicuro e deciso nelle sue perlustrazioni, fino alla registrazione di fenomeni riassunti nella loro primigenia unità temporale e quindi trasposti da un tempo “immaginativo” ad uno d’indole filosofica e universalizzante, dove il soggetto è voce corale e la sua pronuncia assume i toni della meditazione sintetica: «Perciò io adoro il presente/ perché solo il presente contiene/ tutto quello che è stato/ ma il presente sospeso, la luce/ questo blocco di terra pressato». Nonostante l’evidente tratto di sospensione rappresentato dall’allocuzione nominale che risolve il componimento appena citato, in realtà Macchine movimento terra racconta sotterraneamente della trasformazione del paesaggio urbano, della sua necessità e del suo valore – verrebbe da dire – escatologico: non siamo poi così lontani dagli accenti de Il pianto della scavatrice pasoliniano, sebbene nella poesia di Maurizio Cucchi difetti la soluzione mitologico-resistenziale-antropologica che è supplita da una metodica cognitiva alimentata da illuminismo e rigorismo scientifico, piuttosto evocativo rispetto alla tradizione allegorica che percorre i libri dell’ultimo Caproni, quello che almeno si distingue tra Il franco cacciatore e Res amissa.
Se molto ancora si potrebbe dire sul rovescio del finale, Console o capitano, svolto a mezzo tra accensioni e recitativo, tra dismissione e surplus d’identità, ancora ci piace ricordare che, ad uno sguardo d’insieme, i frammenti che ancora dominavano una sequenza invero centrale come Rutebeuf, contenuta ne L’ultimo viaggio di Glenn, quegli stessi frammenti ormai si sono dilatati. Le tracce lasciate fin dal Disperso, infatti, non esitano ora a trovare un loro posto sicuro nel principio di significazione, anche dove l’espressività cede il passo a certo espressionismo (memore di alcuni versi e alcuni quadri di Tadini), pure in un clima lapidario, dove l’unica insorgenza è quella costante della memoria, vincolata e direzionata da una soggettività una volta di più libera e, non a danno, compiaciuta: «mi compiaccio di esprimermi/ in prima persona/ in modo diretto e libero/ come ho finalmente imparato».
Immagine: Foto di Maurizio Cucchi.
Maria Borio è nata nel 1985 a Perugia. È dottore di ricerca in letteratura italiana contemporanea. Ha pubblicato le raccolte Vite unite ("XII Quaderno italiano di poesia contemporanea", Marcos y Marcos, 2015), L’altro limite (Pordenonelegge-Lietocolle, Pordenone-Faloppio, 2017) e Trasparenza (Interlinea, 2019). Ha scritto le monografie Satura. Da Montale alla lirica contemporanea (Serra, 2013) e Poetiche e individui. La poesia italiana dal 1970 al 2000 (Marsilio, 2018).